Prima di essere ucciso, Giacomo Matteotti venne anche molto diffamato
Dai fascisti ovviamente, responsabili dell'omicidio del deputato socialista un secolo fa, ma anche da altri avversari politici, cattolici e comunisti
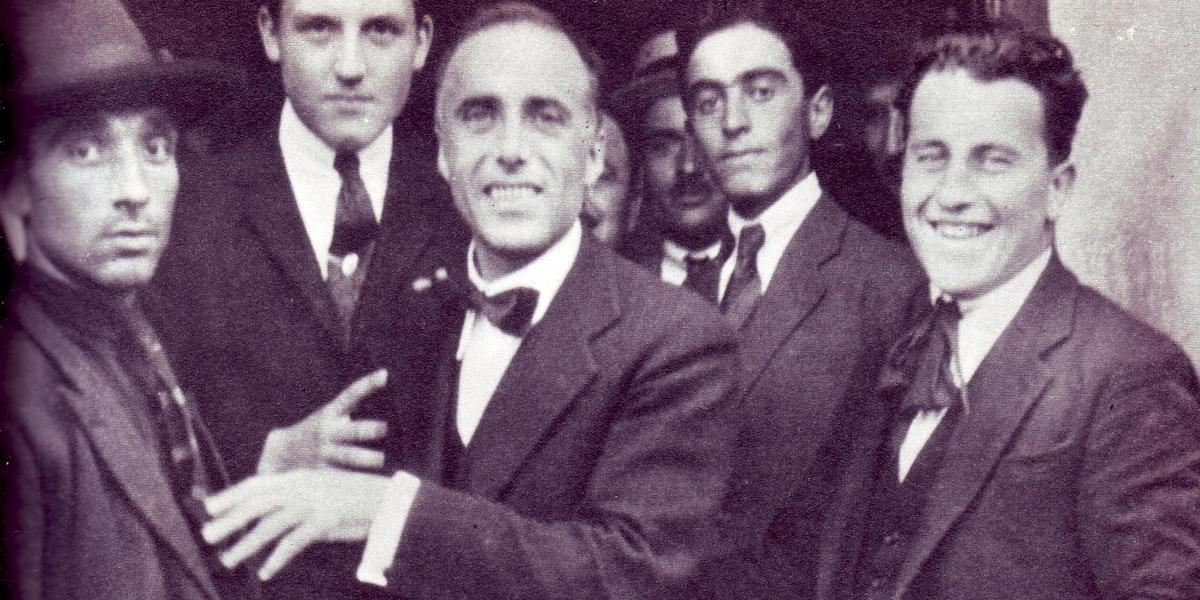
Essere troppo ricco. Essere mezzo austriaco. Essere figlio di usurai. Essere un privilegiato, un borghese che faceva la bella vita ma che voleva giocare a “fare il compagno”. Sono tra le accuse più ricorrenti di cui Giacomo Matteotti venne fatto oggetto dai suoi avversari politici nella sua breve vita, e che avevano ben poco a che fare con la sua attività di amministratore locale nella provincia di Rovigo e di deputato del Partito socialista. Riguardavano piuttosto sue vicende personali e ricordarle oggi, cento anni dopo l’omicidio di Matteotti, aiuta a comprendere da un lato come promuovere campagne di delegittimazione di avversari politici utilizzando le loro faccende private sia una pratica storicamente radicata; dall’altro, mostra come non fossero solo i fascisti a insultarlo in questo modo, ma anche i conservatori cattolici e i comunisti.
Ovviamente le accuse dei fascisti ebbero un significato storico assai più pesante, visto che poi furono loro ad aggredire Matteotti e ucciderlo nei pressi di casa sua a Roma, il 10 giugno 1924. Ma prima di quel 10 giugno e prima che prendesse il potere Benito Mussolini, c’era già un’abitudine diffusa di esasperare e mistificare fatti più o meno imbarazzanti – o anche semplicemente infondati – riguardanti la famiglia di Matteotti, per screditare la sua attività politica.
I primi attacchi gli arrivarono già nel dicembre del 1914, quando Matteotti, che da tempo guadagnava credito e visibilità per le sue iniziative a favore dei lavoratori agrari del Polesine, era da poco diventato il leader dei socialisti della provincia di Rovigo, in Veneto. Il 19 dicembre di quell’anno il settimanale cattolico Il Popolo gli dedicò un articolo intitolato «Giacomino Matteotti! Il socialista impellicciato», nel quale si alludeva in maniera malevola alle origini della ricchezza della sua famiglia: «Quando voi ritirerete l’onesto frutto dei vostri numerosi crediti con o senza ipoteca, quanta compassione vi sorgerà in cuore se penserete ai miseri che un giorno dovevano lasciare la casetta, il campicello, la magra armenta, i pochi mobili di casa in mano di certi strozzini».
Non è un caso che le critiche più precoci le fecero i cattolici. In una terra depressa e arretrata qual era il Polesine, la propaganda socialista attecchiva con successo tra i braccianti, e questo rappresentava una minaccia per le gerarchie ecclesiastiche, contrarie ideologicamente alle teorie marxiste. Matteotti, peraltro, già prima della Prima guerra mondiale aveva iniziato a formulare quello che poi negli anni seguenti sarebbe diventato il suo approccio ricorrente alla questione agraria nella sua terra: più pragmatico, non dogmatico, fondato sulle richieste concrete dei contadini, che alle suggestioni rivoluzionarie evocate da anarchici e comunisti preferivano l’impegno per definire accordi di lavoro tra gli agrari e i braccianti, per migliorare le condizioni di vita di questi ultimi.
Ed è proprio questo suo sforzo che i suoi avversari intendevano svilire diffondendo voci disdicevoli sul suo conto e sul conto di suo padre, Girolamo Matteotti. A 19 anni Girolamo Matteotti aveva assunto la direzione della piccola bottega artigiana di famiglia e l’aveva trasformata, insieme alla moglie Elisabetta Garzarolo, in una sorta di piccolo bazar con due sedi a Fratta Polesine: vendeva attrezzi per la campagna, utensili per la casa, tessuti. Aveva poi accumulato ricchezze e comprato centinaia di ettari di terreni in vari comuni del Polesine, in parte ottenuti partecipando all’asta dei beni parrocchiali confiscati alla Chiesa dallo Stato dopo l’Unità d’Italia (e già questo gli aveva procurato l’ostilità dei prelati locali).
Ma soprattutto Girolamo Matteotti prestava soldi a interesse, a tassi che arrivavano fino al dieci per cento, molto alti anche per l’epoca. Tuttavia morì a 63 anni nel 1902, quando Giacomo Matteotti aveva diciassette anni e aveva appena iniziato la sua attività politica, restando da lì in poi sempre piuttosto defilato rispetto agli affari di famiglia, la cui gestione passò alla madre Elisabetta Garzarolo (in verità tutti a Fratta la chiamavano “Isabella”). Matteotti visse principalmente della rendita dei possedimenti e delle attività famigliari, ma non prestò mai soldi a interesse.

Il presidente della Repubblica Ciampi visita la tomba di Matteotti, a Fratta Polesine, il 10 ottobre 2003 (Enrico Oliverio/ANSA)
La diceria si diffuse comunque in fretta e inseguì Matteotti anche negli anni successivi, quando iniziò ad avere incarichi sempre più importanti nei comuni della provincia di Rovigo e quando poi, a partire dal dicembre 1919, divenne deputato. Col passare del tempo furono sempre più i fascisti ad accusarlo di essere un usuraio, accusa che fu forse la più persistente della sua vita.
Ancora il 24 maggio 1924, due settimane prima dell’omicidio, Il Popolo d’Italia (quotidiano fondato da Mussolini nel 1914 e poi diretto da suo fratello Arnaldo Mussolini) pubblicò un articolo in cui c’era scritto:
[…] il milionario onorevole Matteotti, che potrebbe essere grato al fascismo di avergli salvato le terre dall’esproprio bolscevico, non può perdonare al fascismo di avergli stroncato la carriera di arrivista.
Oltre che per questo presunto arrivismo e per la sua ricchezza, Matteotti venne più volte preso di mira dalla propaganda fascista anche per l’origine della sua famiglia. Il nonno, Matteo Matteotti, era arrivato a Fratta negli anni Cinquanta dell’Ottocento, trasferendo lì la sua attività di lavoratore del rame che faceva in precedenza a Comasine, un piccolo borgo della Val di Peio, in Trentino, dove era nato anche il padre Girolamo. All’epoca il Trentino era un territorio austriaco, e lo sarebbe rimasto fino alla fine della Prima guerra mondiale: secondo i fascisti questo bastava a rendere Matteotti un «anti-nazionale», anche perché tra il 1914 e il 1915 si batté per la neutralità.

Il cadavere di Matteotti trasportato in una bara dopo essere stato ritrovato nel bosco della Quartarella, a nord di Roma, il 16 agosto 1924, più di due mesi dopo il suo assassinio (Archivio GBB/CONTRASTO)
Matteotti era infatti tra i più intransigenti avversari delle tesi interventiste che spinsero l’Italia a entrare nella Prima guerra mondiale: rimase isolato persino nel suo partito, dove in tanti si lasciarono convincere della necessità di non alimentare una propaganda antipatriottica, secondo la teoria del «né aderire né sabotare».
Matteotti invece rimase sempre fermamente ostile a qualsiasi ipotesi di entrata in guerra dell’Italia, e mentre gli altri esponenti socialisti rimanevano perlopiù in silenzio, lui continuò a lungo a fare dichiarazioni pubbliche in favore della neutralità. La cosa gli procurò anche dei problemi: venne tenuto sotto osservazione dalle autorità locali e, dopo essere stato richiamato alle armi, nel 1916 fu mandato a Messina per evitare che la sua propaganda contro la guerra facesse proseliti al fronte. Matteotti era motivato da convinzioni ideali, perlopiù, però per la retorica fascista degli anni seguenti fu facile mistificare, dicendo che alla base del suo neutralismo «disfattista» ci fosse un’antica simpatia per gli austriaci.
Come dicevamo però le accuse più ricorrenti riguardavano il suo status economico. Gli veniva rinfacciato non solo dai suoi avversari della destra, ma anche da parlamentari e dirigenti comunisti, come se il fatto che Matteotti fosse ricco squalificasse la bontà del suo impegno per la causa dei lavoratori. Il «paròn Matteotti», nel senso di padrone, o il «social-milionario», furono epiteti che gli vennero attribuiti dalla propaganda comunista. La stessa questione, insomma, veniva agitata da diversi partiti con toni e obiettivi diversi, ma con la comune finalità di delegittimarlo sul piano personale prima ancora che politico. Insomma, le accuse arrivavano anche da comunisti come Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga, Umberto Terracini.
Questi tre esponenti comunisti, peraltro, erano stati protagonisti della scissione del gennaio del 1921, al celebre congresso del Partito socialista di Livorno. Il motivo della scissione fu una precisa indicazione di Lenin, che propose l’espulsione dei “riformisti” dal partito stesso. I riformisti erano gli esponenti che rifiutavano l’approccio violento e rivoluzionario del marxismo e prospettavano invece la realizzazione del socialismo attraverso le riforme, appunto, in un processo più democratico che rifiutava l’accettazione supina di ciò che voleva l’Unione Sovietica. Spettava ai “massimalisti”, ossia quelli che erano per un approccio più radicale, espellere la corrente più moderata. I massimalisti però si rifiutarono e la mozione non passò.
La maggioranza del partito decise di non espellere i riformisti, e quindi la corrente ancora più estremista che era per l’espulsione dei riformisti, tra cui Bordiga, Gramsci e Terracini, se ne andarono dal partito fondando il Partito Comunista d’Italia.

Lo stato maggiore del PCI riunito al teatro Eliseo per commemorare il trentesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, sotto le due grandi foto di Gramsci stesso e di Palmiro Togliatti, il 16 maggio 1967 (Fausto Giaccone/Contrasto)
Le divergenze tra i socialisti che si riconoscevano nella guida di Filippo Turati, come Matteotti, e i comunisti, andarono aumentando nei mesi e negli anni seguenti, in linea con quanto accadeva anche in altri paesi. Ma in Italia questi contrasti si concentravano anche su come fare opposizione al fascismo: i comunisti rivendicavano una maggiore fermezza nella condanna al regime fascista, a cui contrapponevano non lo stato di diritto e il ripristino delle libertà democratiche, ma l’avvento della rivoluzione del proletariato, e consideravano anche i socialisti riformisti quasi come collaboratori del nemico.
In occasione del centenario dell’omicidio di Matteotti, lo studioso Antonio Funiciello, già capo di gabinetto dei presidenti del Consiglio Paolo Gentiloni e Mario Draghi, ha pubblicato un libro intitolato Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti.
Nel libro, Funiciello spiega che nella retorica di Gramsci di quel periodo si affermava «la volontà di abbattere non solo il fascismo di Mussolini e Farinacci, ma anche il semifascismo di Amendola, Sturzo e Turati»: cioè veniva condannato il tentativo di Turati (e Matteotti) di costruire un fronte di opposizione al fascismo insieme ai liberali e ai cattolici (guidati rispettivamente da Giovanni Amendola e don Luigi Sturzo) mettendo da parte ogni proposito rivoluzionario in nome della lotta al regime.
Al contrario, Matteotti riteneva che la velleitaria retorica rivoluzionaria dei comunisti facesse il gioco di Mussolini: «Il fascismo trova nel suo avversario, che gli somiglia, un naturale alleato». Come ha ricordato lo storico Emilio Gentile il 30 maggio scorso alla Camera in una seduta commemorativa, Matteotti pensava che il comunismo fosse «complice involontario del fascismo: la violenza e la dittatura predicata dall’uno diviene il pretesto della violenza e della dittatura in atto dell’altro». Ancora nell’aprile del 1924, in un momento di forte tensione tra socialisti e comunisti, Matteotti scrisse al dirigente comunista Angelo Tasca:
Lottare a fondo contro il fascismo? D’accordo. Ma in nome di che? Noi vogliamo lottare contro il fascismo in nome della libertà, voi della dittatura.
– Leggi anche: Che ne sappiamo davvero di Giacomo Matteotti?



