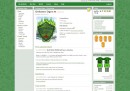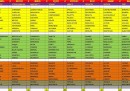Tifare giocatori che non esistono
Arnaldo Greco sui giochi sportivi manageriali – Fantacalcio, Fanta NBA, Hattrick, Football Manager – e i bizzarri legami sentimentali che producono in chi li frequenta
Arnaldo Greco ha raccontato sull’Ultimo Uomo la sua esperienza di giocatore di Hattrick, Football Manager, Fanta NBA, Fantasy Football e cose del genere: giochi sportivi manageriali, nei quali è possibile gestire ogni singolo aspetto di una squadra – di calcio, di basket, eccetera – e seguirla partita dopo partita scegliendo chi comprare, chi vendere, chi far giocare, eccetera. Col tempo si finisce per sviluppare una specie di affetto verso i propri giocatori: anche quelli che in realtà sono soltanto dei nomi fittizi per descrivere personaggi che non esistono.
Quando qualche settimana fa un noto giocatore di football americano ha annunciato il suo abbandono allo sport adducendo, tra le cause del prematuro ritiro, lo strapotere del fantasy football mi sono chiesto cosa ci fosse di così orribile in quel passatempo. E se dovessi sentirmi—pur non avendo mai provato il fanta-football—in qualche misura responsabile, essendo un fan assoluto di qualsiasi fantasport. Parlando con qualche amico, ho scoperto che per loro la chiave del successo dei fantasport o dei giochi manageriali, risiede tutta nel controllo. Ciò che adoriamo è la sensazione di poter controllare quell’assist in più, quel tiro da tre sbagliato di troppo, o il terzo decimale della media battuta. In un’epoca di control freak, ciò che ci tiene, dunque, attaccati al più semplice fantacalcio (il fantasport col minor numero di variabili al mondo) o al manageriale più complesso è quella sensazione di poter incidere su un risultato analizzando e agendo sui minimi particolari, che sia l’allenamento infrasettimanale dei propri atleti o impostare l’atteggiamento più o meno offensivo di un’ala destra. Di conseguenza quel giocatore di football lì non doveva sentirsi vittima dei giochi, era una posizione semplicemente illogica: i numeri che realizzava non gli appartenevano più. Lui credeva che senza quei numeri sarebbe stato considerato un giocatore più forte, ma era una pretesa assurda: dal momento in cui lui realizza quei numeri, lui è quei numeri. Sono sanciti e non c’è niente oltre quelli se non la possibilità di migliorarli o peggiorarli.
Eppure a me sembra di sentire che ci sia qualcosa oltre al controllo. Che la corrispondenza tra un atleta e come usiamo le sue cifre non si limiti al rapporto tra noi e le cifre ma si allarghi anche all’atleta. Allora mi sono chiesto se l’affetto o la simpatia che proviamo per le versioni statistiche e gli avatar degli atleti corrispondano ad affetto e simpatia anche per gli atleti in carne e ossa oppure non c’è passaggio tra gli uni e gli altri. Un tifoso della Roma vuole bene a Pjanic più o meno di un tifoso della Roma che ha Pjanic pure al fantacalcio? E a Chris Paul voglio più bene di un anno fa perché segna 26 ragguardevoli fantapunti di media nel mio team di fantanba? O non me ne frega niente di lui visto che non ho visto nessuna partita dei Clippers quest’anno e Chris Paul non so neppure che faccia abbia? A chi voglio bene? Di chi mi preoccupo? Del vero Chris Paul o di quella riga che corrisponde a Chris Paul su hoops sports? Se si facesse male per chi mi dispiacerebbe? Quella riga di statistiche, di rimbalzi, assist, falli fatti e subiti a partita è sempre Chris Paul o è un’altra cosa che non gli appartiene?
Nel 1968, Roobert Coover scrisse The Universal Baseball Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop. (in italiano “Il gioco di Henry”). Il libro racconta la storia di Henry, una persona ordinaria con una passione totalizzante, il baseball. In realtà, a voler essere il più precisi possibile, Henry si appassiona a una sorta di pre-fanta-baseball, crea, infatti, una sua lega professionistica, l’Universal Baseball Association, con le sue squadre e i suoi giocatori, tutti inventati di sana pianta; e ogni sera, dopo il lavoro, torna a casa e gioca coi dadi e il suo campionato. A ogni lancio corrisponde un’azione dei giocatori. Lui annota tutti i punteggi su alcuni quaderni. La diversa abilità del lanciatore, la diversa abilità del battitore, le diverse abilità dei ricevitori, le misure dello stadio, il tempo atmosferico, la stagione, tutto contribuisce a determinare un punteggio che poi il caso, nella forma di un lancio di dadi, informerà in qualche modo. Henry calcola e appunta i punteggi, annota le statistiche, calcola le percentuali, immagina le telecronache. Quando, però, il rookie Damon Rutheford, figlio di uno dei più forti giocatori di ogni epoca (inventato anch’esso ovviamente), riesce a concludere un “perfect game” dopo una lunghissima, appassionante, e raccontata in ogni minimo dettaglio, serie di lanci fortunati di dado, Henry si esalta a tal punto da perdere anche l’ultimo contatto con la realtà. E la fantalega prende il sopravvento sulla sua vita.