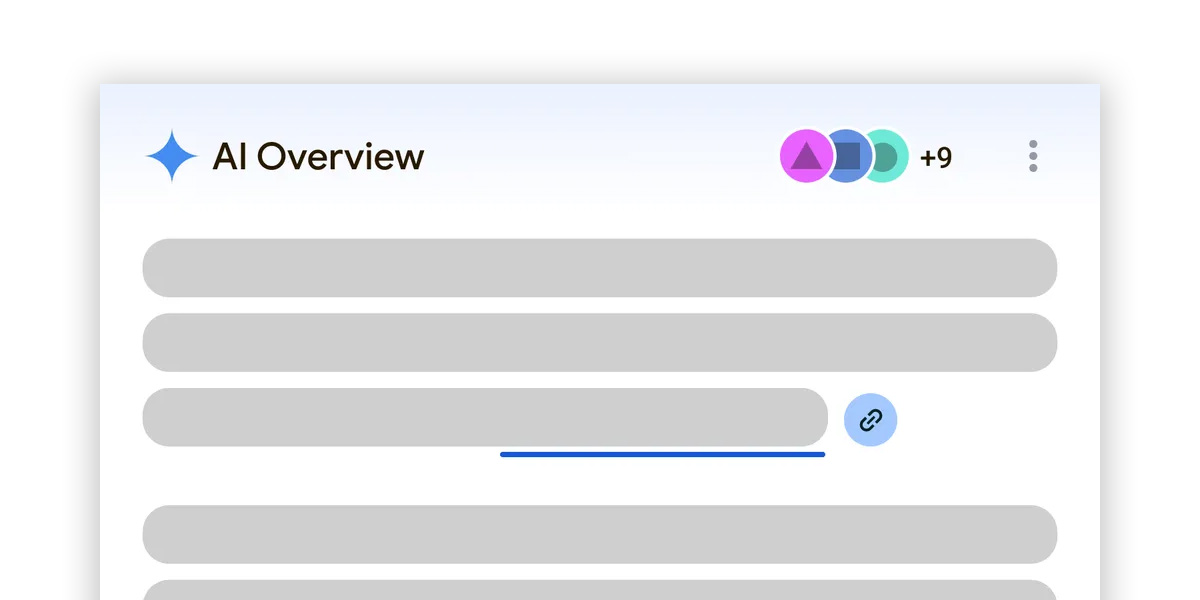Troppo corretto
«Torniamo al politicamente corretto. Che sia una questione molto, molto complicata, si sa. Mi sembra giusto aggiungere che proprio le questioni molto, molto complicate richiedono (per non complicarsi ulteriormente) un qualche sforzo di chiarimento. E qualche presa di posizione»

Un professore afroamericano di mezza età, colto e spiritoso, non sopporta più gli stereotipi sui neri (ovvero su ciò che i bianchi pensano che lui debba pensare di se stesso). Il ghetto, la trap, l’emarginazione non gli appartengono. Perché mai dovrebbe fingersi una vittima della società? Ha scritto dei libri (di scarso successo) nessuno dei quali contiene quegli ingredienti di denuncia sociale, e di orgoglio etnico, che stanno molto a cuore alla critica. Semplicemente: gli interessano altre cose. E pensa che la letteratura sia un’altra cosa.
È circondato da bianchi molto woke, devastati dal senso di colpa, che si aspettano dai neri, e sui neri, solo appassionati j’accuse, e storie truculente di ghetto, galera, ribellione. Invano il prof cerca di spiegare ai suoi studenti di letteratura (quasi tutti bianchi) che i luoghi comuni e i percorsi obbligati non aiutano a scrivere bene, e anzi: producono solo banalità e stereotipi. I suoi colleghi (bianchi) non apprezzano l’eterodossia del professore, e decidono di sanzionarlo. Lo sospendono dall’insegnamento.
Per uscire dall’angolo nel quale si sente rinchiuso, il professore organizza una beffa. Scrive sotto pseudonimo, fingendosi un omicida evaso dal carcere, una feroce parodia della condizione dei neri (ovvero: di come la condizione dei neri viene stereotipata). Chiama il suo romanzo Fuck, il più scontatamente trap dei titoli, e sceglie una scrittura rozza e “incazzata”. Ma la beffa gli riesce fin troppo bene: il libro viene preso per un “vero” romanzo “black”, trova un editore entusiasta e ha un successo clamoroso. L’intenzione satirica non viene colta. La parodia viene presa per buona. Fuck frutta molti dollari all’autore, e con essi la definitiva, amara cognizione che non è la qualità della scrittura, a vincere. È il suo essere “alla moda”, il suo essere atteggiata, il suo scorrere dentro gli argini della prevedibilità.
Questa è la storia, spoilerata giusto il necessario, del film American Fiction, opera prima dell’esordiente Cord Jefferson, nato a Tucson (Arizona) nel 1982, che prende di petto, secondo me con grande humour e profondità, la grande questione del “politicamente corretto”. Budget molto contenuto, un attore strepitoso (Jeffrey Wright) nei panni del protagonista, sceneggiatura e dialoghi notevoli, regia che va al sodo (e il sodo come sempre sono le persone, le loro facce, i posti dove abitano). American Fiction veleggia verso un paio di Oscar, ma non è questo che conta. Conta – per questo ve ne parlo – che è uno di quei film che già durante i titoli di coda trascina in discussioni politiche, analisi e controanalisi, le persone che lo hanno visto. Tocca un nervo scoperto. Gioca con le nuove morali instillando il sospetto che siano nuovi moralismi. E nuovi conformismi.
Mi è sembrato un film eccellente per la qualità – anche satirica – e per lo sguardo “anticipatore” (pur essendo l’adattamento di un romanzo di Percival Everett del 2001): potrebbe diventare uno degli inneschi dell’inevitabile dibattito prossimo venturo (è già nell’aria) sulle ragioni e i torti del politically correct, specie nella sua versione fondamentalista, che è quella americana.
(Breve nota per i cinefili. In certi snodi della trama American Fiction mi ha ricordato quel capolavoro di Mel Brooks che è The Producers (1967), titolo italiano, parecchio scemo, Per favore, non toccate le vecchiette. Anche lì un paio di praticoni del mondo dello spettacolo, a scopo di raggiro, scrivono quello che a loro pare il peggiore musical di tutti i tempi – per essere sicuri che sia una porcheria si affidano a uno sceneggiatore nazista, e a guitti conclamati – ma riscuotono un clamoroso, imprevisto successo, che manda all’aria tutti i loro piani. Uno dei più grandi film comici di sempre. La satira che prediligo è quella che mette a fuoco la stupidità umana e non si limita a strillare che tutte le colpe sono del potere. Chiusa la parentesi cinefila).
Torniamo al politicamente corretto. Che sia una questione molto, molto complicata, si sa. Mi sembra giusto aggiungere che proprio le questioni molto, molto complicate richiedono (per non complicarsi ulteriormente) un qualche sforzo di chiarimento. E qualche presa di posizione. Ora ci provo, scusandomi in anticipo per l’estrema sintesi.
La genesi del politically correct non è solamente facile da capire: è perfettamente condivisibile. Si tratta di “oggetti” del linguaggio che decidono di diventarne i soggetti. Vogliono cambiare le parole usate per definirli. Parlare di se stessi e non “essere parlati”. Probabilmente le più classiche e più popolari innovazioni prodotte da quella rivoluzione verbale sono il successo della parola gay (invece degli orribili e infiniti nomignoli dispregiativi attribuiti alle persone omosessuali) e la messa al bando della parola nigger, ormai impronunciabile non solo negli Stati Uniti: tanto è vero che ho esitato a scriverla per esteso piuttosto che nella sua forma “indicibile”, che è “n…..”. Negli Stati Uniti, n-word.
Si capisce che certe parole sono micro-contenitori di tutte le cicatrici che la discriminazione (principalmente razziale e sessuale) ha comportato e ancora comporta per milioni di esseri umani. Non stiamo parlando solo di formalità, dunque, stiamo parlando della vita delle persone. Quando Nichi Vendola, nel 2013, venne ospite a Vieni via con me (uno speciale Fazio/Saviano, su Rai 3, che ebbe un ascolto travolgente), lesse un lungo elenco dei termini correnti per indicare gli omosessuali in italiano e nei vari dialetti; e la gragnuola avrebbe potuto avere soprattutto un effetto “comico” non fosse che intorno a ciascuna di quelle parole aleggiavano violenze secolari, dileggi feroci, vite scempiate dal pregiudizio.
Bene, dunque. Giusta intenzione. Riscossa delle minoranze. Costringere alla riflessione e all’autocritica le maggioranze. Meditare sull’uso pigro e distratto del linguaggio, che è invece materia viva, appassionante, spesso bruciante. Solo che, per dirla semplice, e per dirla come la penso io: la cosa è sfuggita di mano. Il politicamente corretto è diventato, soprattutto a sinistra e soprattutto nel mondo anglosassone, un nuovo canone e una nuova gabbia. Una specie di “modalità virtuosa” con derivazioni censorie (e autocensorie) che aleggia ovunque, e rischia di imporre una soluzione solamente “formale” a problemi sostanziali. Lo disse benissimo Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti, verso il termine del suo secondo mandato, nel 2015, in una celebre intervista per un podcast: il razzismo è una questione così grave e così radicata nella società americana, che per sconfiggerlo “non basta certo evitare di dire nigger in pubblico per una questione di buona educazione”. Molto preciso il riferimento alla “buona educazione” che salva la forma, e lava le coscienze, ma lascia intatta la sostanza delle cose. Lui la pronunciò per esteso, quella parola, e la pronunciò proprio per avvertire, ormai dieci anni fa, che non è con i tabù verbali che si affronta la realtà. Trattò il politically correct come una specie di pensiero magico, che facendo scomparire una parola razzista fa scomparire il razzismo.
Tralascio, per ovvie esigenze di sintesi, un sacco di argomenti e sotto-argomenti. Faccio solo un breve cenno a quello che definirei l’effetto-Vannacci, ovvero l’idea tipicamente reazionaria che l’intero fascio dei vecchi pregiudizi e dei vecchi luoghi comuni sia addirittura “anticonformista”, e liberatorio, a fronte delle nuove convenzioni del politicamente corretto: come se la muffa fosse il rimedio all’aria che tira, e non fosse lei stessa (la muffa reazionaria) l’aria che ha tirato per secoli, e ancora tira in larghi settori della società. E faccio un altro cenno, inevitabile, al lungo elenco di misfatti, anche con effetto retrospettivo, imputabili a quel vero e proprio neo-puritanesimo (o neo-vittorianesimo? mutande ai pianoforti?) che ha imposto censure proterve e illecite a opere letterarie. Una per tutte, la cancellazione di alcune espressioni “sconvenienti” dai romanzi di Roald Dahl: non si deve dire “dita adunche” perché potrebbe offendere le persone troppo magre. Esempio che cito spesso per la sua irraggiungibile ridicolaggine, e per la sua insopportabile pruderie.
American Fiction sembra imputare i danni del politically correct fondamentalmente al senso di colpa dei bianchi. E affida ai neri il compito – come dire – di redimere i bianchi da questa loro ossessione. Io sto con quel film, lo condivido, credo che le persone davvero interessate alla libertà e alla dignità delle altre persone non possano accettare che una mentalità oggettivamente censoria da un lato, tragicamente conformista dall’altro, diventi una minaccia costante alla libertà di espressione. L’offesa, l’urto della Storia, la vulnerabilità degli esseri umani, sono ingredienti della vita che bisogna gestire con delicatezza e con rispetto, ma anche opponendo forza e libertà di giudizio a tutte le categorie del conformismo. L’idea che una persona molto magra possa risentirsi perché uno scrittore per ragazzi, mezzo secolo fa, scrisse di una strega “dalle dita adunche”, è offensiva in primo luogo per le persone magre. Le persone, anche le persone deboli, non sono così stupide da rassicurarsi per una censura o per una formalità ipocrita. Rivestire il mondo con una vernicetta consolatoria, una uniforme patina di “buona educazione”, così come la disse Obama, non lo rende meno ingiusto o meno doloroso. Lo rende solo più moralista e più stupido.
*****
Per una strana, affascinante circolazione d’aria, e di parole, la lettera di Marta che ho pubblicato la settimana scorsa, nella categoria “femminismo”, si è riconnessa, un anno dopo, alla prima discussione di Ok Boomer!, quella di esordio: quanto importante – o non importante – sia il lavoro, e che peso deve avere nella vita. Con una divergenza di opinioni abbastanza netta tra noi boomers (il lavoro salva! Redime! Consola!) e i più giovani, sicuri che “la vita è anche molto altro”. E relativi rimescolamenti delle carte: qualche vecchio hippy, o vecchio rivoluzionario, che ricordava quanto fosse stata forte, nei Sessanta e nei Settanta del secolo scorso, la critica del lavoro; e qualche millennial, e anche gen-z, che usciva dai ranghi e invitava a darsi da fare, e sgobbare, per non rimanere ai margini del mondo…
Adesso Marta, 22 anni, avendo scritto che non ha nessuna voglia di “diventare una guerriera per sopravvivere”, essendo la guerra una faccenda maschile, ha riattizzato quel dibattito. Che coinvolge, eccome, anche i maschi. Sentite un po’.
“Scrivo per commentare con piacere la lettera di Marta, con la quale condivido anche la relativa giovane età pur appartenendo alla generazione precedente (quella dei millennials). Marta tocca un punto cruciale che va molto oltre la questione di genere. Noto una forte spaccatura sulla concezione del lavoro tra le nuove generazioni e quelle precedenti. Mi sono spesso sentito dire che in questo mondo di squali serve avere fame e bisogna essere disposti a sacrificare anche parte della propria vita privata per poter far carriera e diventare qualcuno. Trovo sia una declinazione della narrazione delle ‘guerriere’ tanto criticata da Marta. Come lei rifiuto totalmente questo tipo di mentalità”.
“Confrontandomi con amici e conoscenti ho sviluppato l’idea che in altri paesi ci sia molto più rispetto per il tempo libero (senza considerarlo ‘cazzeggio’, con accezione negativa) e per il benessere del singolo, quando nel nostro paese sembra invece naturale vivere per lavorare a discapito di tutto il resto: per poi arrivare anche a sorprendersi del crollo della natalità. Come si può pensare che possa mettermi ad insegnare a vivere a qualcuno quando ho a malapena il tempo per respirare? Questo approccio (in linea teorica) aveva forse un minimo di significato nel dopoguerra dove serviva ripartire, e le famiglie numerose erano ancora la norma, a discapito dell’emancipazione femminile. Ora è tutto cambiato, nessuno di noi ha conosciuto (per fortuna) la miseria e la distruzione della guerra, abbiamo avuto sì la fortuna di poterci formare senza i limiti di una volta e questo ci ha dato la consapevolezza che la qualità di vita non si limita solo a un lavoro stabile che permetta di arrivare a fine mese. C’è molto altro, basta anche solo un rapido colloquio con chi si occupa di salute mentale per realizzare quanto sia tossico questo approccio. La realtà è che viviamo in una società sempre più attenta all’apparenza di facciata e (secondo me) ancora troppo poco a forma e sostanza nelle loro definizioni più alte. Durante i tempi bui della pandemia abbiamo toccato con mano cosa significhi essere confinati in solitudine, lontani dai propri affetti, e credo sia profondamente vero che gli unici che si ricorderanno delle volte che sei tornato a casa tardi/tardissimo alla sera, saranno soltanto coloro che ti sono più vicini e che hanno vissuto la tua assenza”.
Elio
“Mi ha molto colpito quanto scritto da Marta, soprattutto nell’ultimo paragrafo:
‘Voglio una famiglia e voglio un lavoro che mi faccia sentire appagata. Non voglio più competere, né con uomini né con altre donne. E voglio questo per la maggioranza delle persone, non c’è niente di distorto né di tossico, solo tentativi di cambiamento’. Che non è altro di quello che volevamo io e molti miei coetanei trent’anni fa, freschi di maturità. E ci ho provato, seriamente. Ma non è successo, e quindi il piano A ha lasciato il posto a un piano B, anche lui messo da parte in favore di un ‘salta su quello che arriva prima’. Mettendo da parte la fortuna di ‘quello che è arrivato’ – lungi dal piacermi, figuriamoci dal gratificarmi, mi permette di garantire pranzo e cena alla famiglia – penso che quasi nessuno, fra i miei conoscenti, ha intrapreso una professione capace di appagare, per tacere sui diversi casi in questa professione non riesce nemmeno a pagare”.
“È quindi con gli occhiali lerci delle delusioni fin qui patite che leggo i ‘vorrei’ di Marta come delle utopie. Al termine di quella frase riportata, non lo nego, ho aggiunto mentalmente “… e poi ci sono le marmotte che incartano la cioccolata!”. Da ascrivere in parte al rosicamento che provo verso chi, per età ed energie, è in quella fase della vita in cui ancora ha la possibilità di cercare o crearsi (o anche solo immaginare) un lavoro che sia appagante, privo di competizione e pure compatibile con il resto della vita. La mia esperienza è che se un lavoro appaga, raramente remunera, e che una carriera è possibile costruirla solo immolando famiglia e colleghi sull’altare della competizione, come fosse un sacrificio umano. Ovviamente auguro a Marta di riuscire in quello in cui io e tanti miei coetanei abbiamo fallito. Le auguro di cuore di trovare una terza strada fra ‘vivere per lavorare’ e ‘lavorare per vivere’. Forse un passo per riuscirci (e vendicarci tutti, daje Marta!) è smettere di pensare che noi ‘zii’ (cioè quelli dell’età dei suoi genitori) avessimo aspirazioni così diverse dalle sue, a 22 anni”.
Stefano
*****
Sono un grande fan di Mahmood da quando vinse Sanremo nel 2019 con “Soldi”. Una volta tanto non ero lì per lavorare, ma per salutare un po’ di vecchi amici, bighellonare in quella bolgia, andare da Gaetano a mangiare il pesce. Un paio di giorni di vacanza. Mauro Pagani, che presiedeva la Giuria di Qualità (quella che spesso bilancia e a volte sovverte la vox populi del televoto), mi disse: “ascolta quel ragazzo, è molto bravo”. E aveva ragione. Dunque pubblico volentieri la mail di Alessandra, qui sotto (poi basta, che questa settimana la sto facendo davvero troppo lunga), perché parla bene di Mahmood e perché aggiunge qualcosa al leitmotiv “generazionale” di questa newsletter. Aprite bene le orecchie, boomers, e lustratevi gli occhi, prima che udito e vista si inceppino in modo irrimediabile. E prima che la luce dell’eros diventi solo un remoto ricordo…
“Da quasi boomer (sono del 1967, ma purtroppo o per fortuna spesso mi posiziono in modo più antico) con figlia adolescente (quasi 20 anni, ma come dice Soncini, dai 20 ai 35 adolescenti sono), mi sono ritrovata a guardare, una volta tanto senza la spocchia dell’ ‘ai miei tempi sì che la musica era tale, mica i trapper di oggi’, il video della nuova canzone di Mahmood, Tuta Gold, e mi è venuto da pensare che è, non saprei come dire, ‘sessualmente suggestivo’ anche se non c’è una, dico una, donna, e sono tutti prevalentemente intabarrati in abiti informi. E lo dico con ammirazione, senza ironia più o meno facile sull’orientamento del cantante, da persona che ha apprezzato anche il video di Texas Hold ‘Em di Beyoncè proprio perché si colloca nel risicato spazio condiviso tra erotico e pornografico. Se un prodotto fatto soprattutto per giovani e giovanissimi si distanzia anni luce da stereotipi e immaginari consolidati fatti di, mi sia permesso il termine, culone ondeggianti e supercar improbabili, forse possiamo ben sperare”.
Alessandra
Aggiungo solo che il video di Beyoncé (che ha fatto imbufalire un sacco di bianchi conservatori: una nera che canta il country! Profanazione!) è anche decisamente spiritoso. E si fa beffe della fissazione per le armi da fuoco.
“Zanzare mostruose” salta il turno per sfinimento del per altro curatore, che sarei io. Alla prossima!