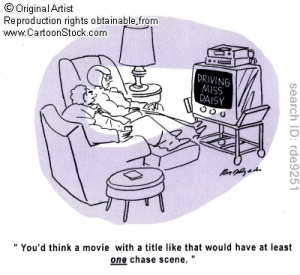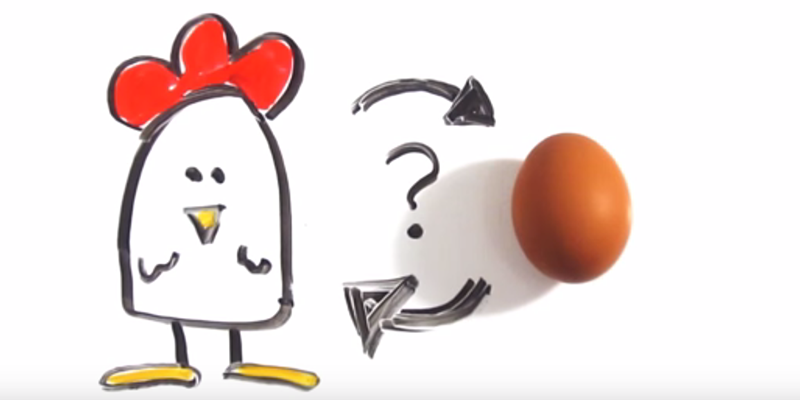Rivoluzione didattica con Fabris e Pascale
Certe domande uno se le fa fino a che campa, senza rispondere mai. Non è colpa di chi si fa le domande, e non è manco colpa delle domande, perché certe domande servono a trovare le risposte e certe altre no, sono fatte apposta per essere domande e basta.
All’università seguivo i corsi di Adriano Fabris, che cominciavano ogni anno con una introduzione, una specie di proclama di intenti. Fabris era un filosofo, ed era anche un didatta eccezionale. Aveva dei tempi comici perfetti, e gli piaceva anche la battuta, ma il suo magnetismo era dovuto a un’altra qualità, più precipua. Fabris era in grado di dire delle frasi a effetto come se fossero state frasi banali. Sapeva usare un tono neutro per aforismi fulminanti, e uno caloroso per i passaggi più anonimi. Per questa sua bravura nello scegliere gli accenti di una lezione, riusciva a focalizzare l’attenzione dello studente sul cuore delle questioni: lo svolgimento del tema.
Il primo momento (quello introduttivo, lo status quo da cui si partiva, l’acquiescenza delle convinzioni raggiunte in un determinato secolo riguardo un certo dibattito) e l’ultimo (quello della sintesi o della risoluzione, di un nuovo equilibrio basato su nuove conquiste) perdevano importanza rispetto a quello centrale (il ragionamento, lo sforzo, la ricerca di un approdo cui si potrebbe anche non pervenire mai, e dunque lo spaesamento, l’ansia, il dramma del pensiero). Riusciva a mostrare che il lavoro della filosofia era tutto lì, nel momento centrale, e che il cristallizzarsi di una posizione (inevitabile nella storia della cultura) costituiva una battuta d’arresto, uno stallo, la parte più noiosa della faccenda. Un po’ come negli sparatutto hollywoodiani. Si parte da una serenità idilliaca, che poi viene perduta a causa di un evento tremendo, e che per essere riconquista ha bisogno che si attraversi l’inferno. Le belle formule sono solo belle, sembrava voler dire Fabris col tono monocorde riservato alle frasi a effetto, se volete qualcosa di avvincente dovete cercarla nelle peripezie, nel come ci si arriva e nel come di nuovo se ne riparte.
“La filosofia non dà risposte”, gli sentivi annunciare il primo giorno, “La filosofia riformula le domande”.
La battuta era trita anche per uno studente del primo anno, ma lui sapeva pronunciarla in un modo che le restituiva tutto il suo smalto, e se eri una matricola vera (a Pisa c’erano anche le matricole false, cioè le matricole normaliste, che in realtà sono luminari della propria disciplina travestiti da diciannovenni) subivi il fascino ambiguo di cui Fabris sapeva ammantarla: la considerava una definizione di filosofia valida? O ce la sottoponeva per irridere un luogo comune? Come voleva essere guardato Fabris da noi? Con complicità o con sospetto? Cosa voleva che pensassimo di quella formula? Per scoprirlo, dovevi seguire tutto il corso. E alla fine non l’avresti saputo comunque, perché Fabris voleva dirti che le questioni interessanti rimangono aperte, e tenere aperta una questione è l’unico modo corretto di esercitare il pensiero, che è quella bella fatica di fare passi avanti e passi indietro, senza fermarsi mai.
Fabris in pratica non ci trattava come matricole. Ci svezzava con gradualità e dolcezza, ma senza esitazione. Siete universitari adesso, che ve ne fate del lieto fine? Se siete qui, è perché vi interessano le peripezie. Anzi, sapete che vi dico? Che siete abbastanza grandi da saperlo: la conclusione non esiste. E se anche esiste, non ce ne facciamo niente, non fa per noi.
Nel dibattito politico italiano non ci sono molti Fabris (forse, ad avere un atteggiamento problematico, c’è solo Giannino). La campagna elettorale, la ricerca del nostro assenso, va avanti senza che mai ci si concentri sulla parte centrale, quella del percorso. E dell’ambiguità si fa un uso strumentale e utilitaristico, non didattico. I candidati si rinfacciano le responsabilità delle condizioni di partenza, e poi passano subito a prospettare il momento risolutorio: votando me, sarete di nuovo felici, troveremo un nuovo equilibrio, ritroveremo il buon governo, vi traghetterò verso una nuova serenità, della fatica mi farò carico io, voi non dovrete preoccuparvi di nulla, anzi, nemmeno ve le sto a spiegare le fatiche che dovremo fare, vi parlo direttamente della fine, di come staremo bene dopo. Manca il dramma. Manca il lavorio del pensiero. Come faremo ad arrivare dove ci vogliono portare? Cosa dovremo attraversare? Come lo attraverseremo? E attraversandolo, quanto cambieremo? Quanto il percorso stesso muterà la destinazione finale che ci eravamo prefissi? A voler raggiungere l’India, si può finire in America? Su questa parte, non si sofferma nessuno.
I discorsi elettorali sono tutto un salto dallo ieri al domani. Gli elettori vengono trattati come matricole. Nessuno ha fiducia nel loro potersi appassionare più al percorso che al traguardo. Nessuno dibatte i problemi nel merito, nessuno ti fa entrare nello svolgimento, nel calcolo, nell’analisi. Difficile capirci qualcosa. Difficile che si raggiunga la maturità di studenti universitari. Si rimane bambini delle elementari, contenti per quei due secondi in cui facciamo lo scivolo, e piangenti quando finiamo con la faccia sulla sabbia. In attesa che il papà ci rimetta in cima, evitandoci la fatica di doverci rialzare e fare le scale.
PS: se qualcuno avesse voglia di leggere pensieri nitidi sull’argomento, può godersi Questo è il paese che non amo di Antonio Pascale, cui questo post vuole essere un sentito, anche se indegno, omaggio.