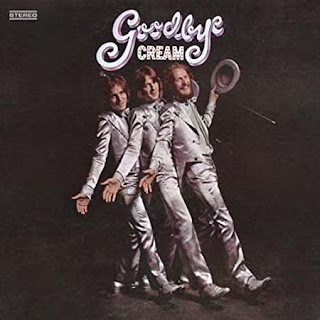Due canzoni per farla finita (Beatles, #55-46)
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56)
50 anni fa i Beatles sono finiti, ma come? Qual è l’ultima canzone dei Beatles? È un discorso complicato. Il loro ultimo disco era stato registrato prima del penultimo. Il penultimo era diviso in due lati molto diversi, ciascuno con un finale a effetto: uno composto da Lennon, uno progettato da McCartney e indovinate, non erano d’accordo su quale usare come finale finale. Li trovate entrambi in questa puntata, rispettivamente al #54 e al #47. Decidete voi.
PS: vi amo. No, in realtà volevo ricordare che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Sono loro che tifano John, io non c’entro…
55. Girl (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Tetta, tetta, tetta. Dicevamo che con Michelle i Beatles stavano cercando consapevolmente di conquistare il mercato continentale europeo. In effetti la canzone uscì in singolo soltanto in alcuni Paesi europei (tra cui l’Italia): il lato B era Girl, con cui spesso viene paragonata, nel classico derby McCartney/Lennon. E anche in questo caso, se il favore del pubblico va al Lato A di Paul, i critici preferiscono nettamente il numero di John. Sembra più sofferto, sincero, meno stereotipato, ecc. ecc. Senonché, proprio nel momento più drammatico del brano, mentre il bridge sta per convergere sul ritornello, ti accorgi che in sottofondo qualcuno sta cantando in falsetto: “tetta, tetta, tetta”. Così, per scherzo. “Era un modo per rilassarci un po’ nel bel mezzo di questa grande carriera che stavamo forgiando” (è Paul, nella sua autobiografia). “Quando potevamo metterci qualcosa che fosse un po’ sovversivo, lo facevamo. George Martin avrebbe potuto dire; “ma stavate cantando dit dit o tit tit?” “Oh, senz’altro dit dit, George, ma suona un po’ come “tetta tetta”, vero?” E poi entravamo in macchina e scoppiavamo a ridere”. C’è questa componente autoironica, in tutta la storia dei Beatles, che può essere disorientante.
Eppure Lennon con Girl sembrava voler fare sul serio. Il desiderio di comporre un brano ‘all’europea’ è tradito dalla progressione degli accordi nella strofa, più semplice del solito ma ricalcata su un’idea quasi archetipica di ballata cantautorale: la minore, re minore, mi maggiore. È l’unica strofa dei Beatles che avrebbe potuto aver scritto anche un Brassens, anche un De Andrè: quest’ultimo in particolare avrebbe potuto scriverla anche dieci anni dopo. Nel ritornello (un giro di Do neanche troppo camuffato) Lennon ha l’idea di introdurre un nuovo strumento musicale: il sospiro affannoso, anzi, l’aspirazione affannosa (c’è chi ci legge un chiaro riferimento al consumo di cannabis) (c’è chi vede la cannabis dappertutto, e in molti casi è soprattutto negli occhi rossi di chi guarda) (però nel caso dei Beatles del 1965 non è un’ipotesi così azzardata).
L’ultimo tocco europeo, a dire il vero un po’ incongruo ma suggestivo, è lo strano effetto ‘sirtaki’ ottenuto dal raddoppiamento delle chitarre acustiche verso la fine. Anche questa un’idea di Paul, ispirata da una recente vacanza in Grecia. Alla fine anche il John di Girl è un turista dell’esistenzialismo: senz’altro meno sfacciato di Paul, non usa un frasario da turista per provarci con le ragazze locali, ma si apparta in un angolo a contrariarsi per un amore difficile per una donna impossibile che dovrebbe averlo ridotto a uno straccio – un amore che ai biografi non risulta ma vabbe’, dettagli. In seguito avrebbe raccontato nelle interviste che “la ragazza che più la vuoi più te ne fa pentire, eppure non rimpiangi un solo giorno” era una prefigurazione di Yoko. E se da una parte fa un po’ sorridere questa tendenza a dedicare a tua moglie anche le canzoni che hai scritto prima di conoscerla, l’idea che la Ragazza sia davvero Yoko rende la terza enigmatica strofa un ascolto da brividi. Le fu mai detto, quando era giovane, che la fama l’avrebbe condotta al piacere? Ha capito cosa intendeva colui che disse che l’uomo deve spezzarsi la schiena per meritarsi un giorno di riposo? Ci crederà ancora, quando lui sarà morto?
54. The End (Lennon-McCartney, ma si sarebbe dovuta attribuire a tutti e Quattro; Abbey Road, 1969).
Oh Yeah! All right! Prima di diventare la Fine dei Beatles, The End era semplicemente il finale del Medley di Abbey Road, e a quanto pare ne è anche il brano più apprezzato dai critici. Curioso, perché è il momento del Medley che assomiglia meno a una canzone e più a un movimento di un brano musicale più complesso. Si tratta di un pezzetto di musica notevole soprattutto per quello che non è: non è un lungo addio, non è una melanconica suite strumentale, non è un pezzo di bravura. The End è molto meno, e questo ce la fa amare molto di più. Questa idea di andarsene alla svelta senza troppe smancerie.
Oh you gonna be my dream tonight. Se davvero The End fosse una jam session – ne ha tutta l’aria, ma diffidiamo – sarebbe probabilmente la jam più breve mai incisa : due minuti (un minuto e mezzo se togliamo la coda). Per fare un confronto con quel che andava per la maggiore in quel periodo si può accostarla ad Apple Jam, il terribile disco che Harrison allegò in omaggio con All Things Must Pass: più di mezz’ora di improvvisazioni strumentali senza capo né coda. Oppure con i brani live sempre più interminabili dei Cream. Già, i Cream.
The End all’inizio si chiamava Ending. Non era necessariamente la Fine dei Beatles, ma avrebbe potuto esserlo. Un momento però: cosa voleva dire “la Fine dei Beatles”?
Oggi abbiamo tutti una certa familiarità col concetto di ‘fine di un gruppo’. Può trattarsi di un litigio, meno spesso di una separazione consensuale – sappiamo anche di non doverci fidare troppo, ci sono gruppi che si sono già sciolti tre o quattro volte. Ma nel 1969 tutta questa liturgia non esisteva. Le band erano una relativa novità: nascevano continuamente, spesso cambiavano elementi da un disco all’altro, e altrettanto spesso sparivano dalla circolazione: un disco sbagliato, un contratto finito, e dopo un po’ nessuno si chiedeva più se i Them esistessero ancora o no. Al tempo insomma era più un fallimento che un divorzio. Le cose però stavano cambiando, e anche in questo i Beatles avrebbero potuto essere all’avanguardia: la prima band a sciogliersi ufficialmente. Se non che prima di loro c’era già stata una band molto famosa che non solo aveva già concepito il suo scioglimento come un divorzio, ma lo aveva anche messo letteralmente in scena, con tanto di disco e concerto d’addio: i Cream.
Un vero fulmine per la scena rock: persino i Beatles, durati appena otto anni, fecero in tempo a vederli nascere, esplodere come fenomeno commerciale e artistico, e uscire di scena col botto. Come dice il demiurgo in quel film: la luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo. I Cream si erano dissolti per aver preso una strada che prima dei Beatles non era nemmeno tracciata: il titanismo strumentale. Si erano letteralmente liquefatti in un brodo di jam, risucchiati dai rispettivi ego che portavano Jack Bruce ad alzare sempre più il volume del basso e Ginger Baker a pestare sempre più forte per farsi sentire: una sera Clapton smise semplicemente di suonare, e i due colleghi nemmeno se ne accorsero. Tutto questo in quella manciata di anni in cui questo genere musicale – il blues inglese suonato nell’accezione più virtuosistica – era considerato dai critici un genere commerciale, un cedimento al gusto del pubblico, che evidentemente è molto cambiato: oggi vuole sentire dei finti gangster chiacchierare al microfono, ieri si deliziava di lunghissimi assoli di chitarra, basso e batteria. I Beatles avevano potuto assistere a tutto il fenomeno da una posizione privilegiata, e ora toccava a loro lasciare la scena. I Cream sul lato A di Goodbye avevano salutato il loro pubblico con quindici minuti di improvvisazioni: i Beatles si concessero novanta secondi. The End non è una caricatura degli eccessi del blues rock inglese (come si poteva intendere Yer Blues): anzi tutto il contrario. Se le caricature accentuano proprio gli aspetti eccessivi, The End fa l’esatto opposto, obbligando i quattro strumentisti a dare il meglio di sé in una brevissima unità di tempo, che forse è il più importante stilema dei Beatles: la concisione.
Dopo il rapido assolo di Ringo (il titubante Ringo che sin dall’inizio dell’avventura aveva messo ben chiaro che gli assoli non lo interessavano), i tre chitarristi non solo hanno pochi secondi a disposizione, ma devono cedersi il posto ogni due battute: più che una jam è una coreografia. Alla fine è probabilmente l’unica jam che qualche ascoltatore conosce a memoria, dai primi tom tom di Ringo all’accordo di pianoforte che emerge sul finale. Prima suona Paul, poi George, poi John; di nuovo Paul, di nuovo George, di nuovo John. E per una terza e ultima volta: Paul, George, John. Ognuno cerca per quel che può di descrivere sé stesso con la chitarra. Nessuno ha tempo o spazio per fare cose incredibili: John compensa al suo deficit tecnico con la creatività che contraddistingue i suoi migliori momenti di chitarrista tecnico. “Nessuno di noi”, sembrano intendere, “avrebbe molto da dire da solo”. Eppure si stanno salutando.
E alla fine l’amore che prendi è uguale all’amore che fai. Il che è molto poetico, apparentemente, ma se ci rifletti non è che significhi granché, è un mccartneysmo da incarto di cioccolatino. A meno che non voglia dire una cosa molto triste: l’amore è un gioco a somma zero, tu porti il tuo, l’Altro porta il suo, e alla fine ve ne tornate con la stessa quantità d’amore con cui eravate partiti. Al che rispettosamente dissento, sir Paul McCartney: l’amore che vi siete fatti è sempre stato di molto superiore alla somma delle parti, e vi ha lasciato senz’altro più ricchi, anche se forse non era facile accorgersene nel 1969. Ma si sa, avevate tutti avuto un anno difficile.
53. Got to Get You Into My Life (Lennon-McCartney, The Beatles, 1966)
Ma te l’ho detto che ho bisogno di te ogni singolo giorno della mia vita? A un certo punto sembrava che tutte le canzoni d’amore in realtà parlassero di droga – no, non è stato un certo punto, sono stati tipo trent’anni, da Lucy in the Sky a La mia signorina di Neffa, tutto un estenuante darsi di gomito, uno strizzare l’occhiolino. (In seguito non è che le canzoni abbiano smesso di parlarne, ma almeno sono usciti dalla gabbie dei doppi sensi). È una cosa che ho sempre trovato poco sopportabile, forse perché non mi drogo. In realtà assumo sostanze anche più nocive, ma consentite dalla legge, per cui non c’è gusto a farci i doppi sensi.
Parlare di sostanze stupefacenti in una canzone era coraggioso, diciamo fino al 1968: poi è diventata una soluzione perfino banale, una specie di gioco a protrarre l’adolescenza come se là fuori ci fossero ancora i vostri genitori che si preoccupano se a vent’anni vi fate le canne (nel frattempo i genitori sono scappati a Cuba con la badante sexy e i soldi della vostra università). Per una o due canzoni in cui la dipendenza è descritta in modo mirabile, ce ne sono centinaia che si limitano a vendere un po’ di trasgressione ai ragazzini. E più che gli artisti a volte sono proprio i fan che si intestardiscono a cercare riferimenti al fumo e all’acido e all’oppiaceo in qualsiasi brano, come se parlare di stupefacenti fosse intrinsecamente più cool che parlare d’amore o di pace universale o di tasse – quando invece è la cosa più banale e più semplice, si può fare da soli: persino per l’amore bisogna essere almeno in due. E però proprio quando cominciavamo ad abbracciare un sano processo di revisione, proprio quando iniziavamo ad accettare che Lucy in the Sky fosse stata ispirata a un disegno infantile e Cold Turkey raccontasse il decorso di un’intossicazione alimentare, se ne esce bel bello Paul McCartney e avverte il mondo che Got to Get You Into My Life, una delle sue canzoni d’amore più entusiastiche e trascinanti… era dedicata alla cannabis. Alla cannabis. Una droga che forse è stata cool in un semestre del 1965.
Ora. In effetti, se sposti l’attenzione dalla musica al testo, non c’è dubbio che Paul stia parlando di un rapporto ossessivo (“What can I do, what can I say, when I’m with you I want to stay there…”) Sulla sincerità di Paul al riguardo non c’è modo di dubitare, visti anche solo i precedenti penali: Paul McCartney è riuscito a farsi sequestrare la marijuana in valigia quasi ovunque, dalla Svezia alle Barbados: una volta l’hanno beccato pure nella sua fattoria scozzese, coi semi sbagliati. L’episodio più famoso è la carcerazione in Giappone nel 1980: dieci giorni e tutte le date saltate. Però è un po’ come immaginare che Strangers in the Night parli di un tizio che finalmente scopre le sigarette. Davvero, tutto qui? Paul ha bisogno di cannabinoidi tutti i giorni della sua vita? Se glieli date sarà felice e canterà meravigliose canzoni? C’è qualcuno che considera la canzone migliore, ora che l’abbiamo calata nel contesto indicato dall’autore?
Io no. Anzi ho bisogno di non crederci. Secondo me Got to Get You Into My Life si merita una storia migliore. Ho deciso di credere che parli (come Here, There and Everywhere) di una persona fantastica che Paul incontra proprio perché ha bisogno di cambiare prospettiva: e che decide di amare ogni giorno della sua vita. In effetti sembra proprio Linda Eastman, salvo che… Paul non l’aveva ancora conosciuta. Da cui forse la necessità di una rimozione: dopo aver incontrato Linda, Paul potrebbe avere avuto pudore di una canzone come Got to Get You. Obietterete che è Paul McCartney, e di canzoni in cui giurava eterno amore ne aveva già scritte a quintalate, a partire da Love Me Do (sì, c’è una promessa di eterno amore persino in Love Me Do). Giustissimo, ma Got to Get You è più intima. Forse proprio perché stavolta Paul non promette più niente, stavolta Paul implora. È finito il tempo in cui componeva brevi frasi retoriche per gli innamorati timidi, ora per Paul l’amore non è più un contratto: è un’impellenza fisica, una necessità quotidiana. Una droga? Sì, forse una droga. Ma non necessariamente.
A parte questo, Got to Get You è una straordinaria canzone soul. Come fai a capire quando hai scritto una straordinaria canzone soul? Se te la riprende quasi pari Ella Fitzgerald, ci sono buone possibilità. Se poi te la rileggono gli Earth, Wind and Fire, direi che ci siamo. Una cosa interessante è che Got to Get You non nasce così immediatamente soul: ha un periodo di incubazione in cui mostrava più tracce evidenti di quel gusto vagamente ipnotico-orientale che Paul aveva seminato qua e là in Revolver (l’assolo di Taxman, il melisma di I Want to Tell You). Soprattutto i cori di John, che si sentono in una outtake di Anthology e avrebbero portato la canzone in una direzione sensibilmente diversa (e più vicina ad altri brani revolveriani di John e George). Paul però, lo abbiamo visto, è in grado non solo di inventarsi notevoli soluzioni di arrangiamento, ma anche e soprattutto di scartare quelli che non funzionano abbastanza. Chiunque altro si sarebbe tenuto quei cori, ma Paul voleva qualcosa di più, e così li toglie (proprio come in Can’t Buy Me Love, altro brano ripreso dalla Fitzgerald) e sceglie di inserire una trionfale sezione di fiati che diventano il tratto distintivo della canzone.
52. Julia (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
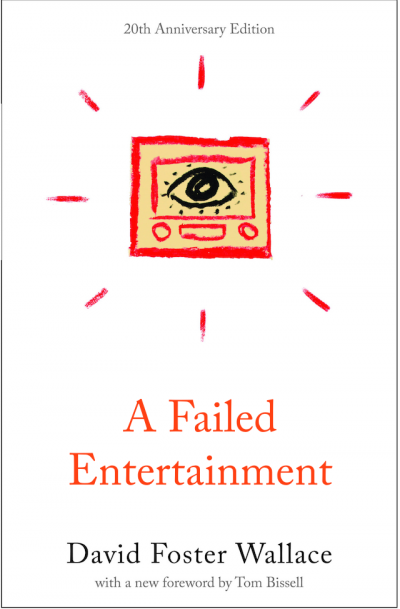 Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l’ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all’Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c’è davvero in quell’Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l’aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l’intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l’ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all’Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c’è davvero in quell’Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l’aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l’intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Julia funziona in un modo simile. Mi piace pensare che Lennon abbia iniziato a scriverla addirittura pensando al figlio Julian – per poi virare immediatamente verso il ricordo della madre – che sfuma immediatamente in quello dell’amante: “Ocean Child”, Yoko Ono. Tre persone intorno al cuore, tre generazioni che sono la stessa persona che nasce, muore, rinasce. Il tutto salmodiato sopra quell’arpeggio ipnotico che è il vero tesoro che Lennon ottenne in India: non dal maestro di meditazione Maharishi, ma dal maestro di fingerpicking Donovan. È lo stesso arpeggio infinito che sentiamo in Dear Prudence; lo stesso sul quale un anno dopo Lennon sta ancora cantando Everybody Had a Hard Year. Julia è l’unico brano di tutto il canone beatle che Lennon suona da solo – scartando anche qualche potenzialità armonica scoperta durante le prove: la versione finale è ancora più scarna dei demo. È un brano che può mettere in imbarazzo – quale altro artista, prima o dopo il 1968, avrebbe confessato con altrettanto candore a un pubblico così vasto che per lui madre e amante erano una cosa sola? E doveva ancora cominciare l’analisi.
I posteri si domanderanno se John Lennon abbia veramente posato i piedi sulla nostra stessa terra. Dopotutto Edipo è un mito; Buddha e Gesù Cristo sono più miti che personaggi storici; ma un figlio di un marinaio nato sotto i bombardamenti, squartato emotivamente da un padre che lo vuole in Nuova Zelanda e una madre che lo affida alla sorella; cresciuto da donne, poi orfano; ragazzo terribile in pantaloni attillati; giovane padre, chitarrista cantante e compositore pop, idolo delle teenager e del suo manager omosessuale; tossicomane, poi artista concettuale, leader pacifista sotto inchiesta federale; poeta maledetto, avvistatore di UFO, rockstar in congedo permanente, morto per mano di un fan. Nessun mitografo o evangelista o romanziere postmoderno sarebbe riuscito a inventarsi un personaggio così. Eppure alla fine era solo un ragazzo che diceva quel che provava, come noi evitiamo di fare il più delle volte perché proviamo cose orribili o anche solo imbarazzanti. Julia, figlia dell’oceano, chiamami.
51. And Your Bird Can Sing (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
Quando il tuo uccellino si sarà rotto, lo porterai indietro? Wikipedia ci informa che il twee pop è un sottogenere dell’indiepop caratterizzato da “semplicità e innocenza percepita”, “armonie tra voci maschili e femminili”, “melodie accattivanti e testi d’amore”. Che tra tanti stili i Beatles abbiano anticipato anche il twee appare perfino scontato – in un certo senso il twee è un tentativo di rimanere vicini a quel nucleo di innocenza che durante l’esplosione del rock sembrava essersi nebulizzata nello spazio profondo. Lo stesso Lennon, quando compone il suo brano più apparentemente twee, si sta già guardando indietro: se è mai stato innocente, quel periodo è passato da un pezzo. Addirittura la finta ingenuità del testo riprende uno stilema dylaniano: c’è molto della Queen Jane ritratta sul secondo lato di Highway 61 in questa ragazza ricca di risorse e gadget che prima o poi tornerà da un innamorato che non si fa impressionare. And Your Bird Can Sing manca la top50 di striscio ed è un peccato, ma è in fondo il suo destino di brano-sottovalutato-di-Revolver: un pezzo in cui Lennon non sembrava credere troppo, caratterizzato da un riff sovrabbondante suonato da due chitarre armonizzate (a suonarle nella versione definitiva pare siano Paul e George), che tra tante possibili dimensioni del rock ne esplora una che nel 1966 non era forse ancora immaginabile. Quando la ripescheranno più quindici anni dopo, i Jam sembreranno aver trovato una gemma nascosta. Un altro piccolo tesoro è la “laughing track” di Anthology, in cui Paul e John vengono colti quasi subito da ridarola e non riescono a smettere: stupisce sempre la loro capacità di prendersi in giro da soli, facendo il verso alle proprie canzoni ancora prima di completarle. (Tutti i tentativi di trovare nel testo riferimenti a celebrità supponenti non superano il livello del gossip. La più demenziale evoca addirittura Frank Sinatra e la sua abitudine italianeggiante a riferirsi al sesso maschile col termine “bird”. Ma no, nessuno ha mai sentito John o Paul davvero cantare “and your bird can swing”).
50. If I Fell (Lennon-McCartney, A Hard Day’s Night, 1964)
“Se mi innamorassi di te, mi prometteresti di essere fedele?” Certe canzoni parlano di sé stesse, al punto che potremmo chiamarle metacanzoni (ma forse è meglio di no). Per esempio If I Fell parla della necessità di fare le cose sul serio, ed è effettivamente la canzone più sofisticata che i Beatles avessero scritto fino a quel momento. Dunque, se da una parte c’è un’aspirante innamorata che deve capire che “l’amore è più che stringersi le mani”, dall’altra ci siamo noi, che dobbiamo capire che John Lennon non è solo l’idolo delle teenager che ha appena sbancato le top10 di mezzo mondo con una canzoncina sullo stringersi le mani. John Lennon è un compositore coi controcazzi, altroché, senti che progressioni, senti che armonie. E sia noi sia la ragazzina in effetti restiamo impressionati da tanto sfoggio di argomenti, ma… non riusciamo a fidarci.
C’è qualcosa di troppo artefatto, costruito – sofisticato, appunto. Persino sul piano sintattico: già il verso introduttivo è un periodo ipotetico del secondo tipo, detto anche periodo della possibilità (ovvero sì, ci sono ancora effettive chance che io mi innamori di te). Da un punto di vista musicale, stiamo ascoltando una lunga introduzione lenta, uno stilema tipico degli standard confidenziali (ad esempio Night and Day). Così, sin dai primi istanti (“from the very start”) sia la musica che la sintassi del testo ci hanno avvisato: questa non sarà la solita facile canzone d’amore in balera, qui le cose cominciano a farsi intricate. Se non proprio contorte. Eppure lo scambio proposto è lo stesso descritto basilarmente in Love Me Do: amore in cambio di fedeltà (“I’ll always be true, so please love me do“). Ma ora è tutto ipotetico, come durante una contrattazione.
In inglese l’innamoramento si esprime con un verbo che implica una caduta: to fall in love (in italiano invece l’amore è qualcosa in cui si entra). Dunque innamorarsi in inglese è un lasciarsi cadere compromissorio. Lennon non può farlo senza precise garanzie. Non è proprio il modo più romantico di descrivere l’inizio di una relazione, ma Lennon aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione: il motivo per cui non è così sicuro di lasciarsi cadere è che comunque ha già (avuto?) una partner, quindi si tratta di capire se un’eventuale seconda caduta possa comportare un’esperienza più appagante.
Ma più appagante in cosa? Non lo sapremo mai – anche e soprattutto in questo consiste l’ambiguità della canzone. Cosa significa “l’amore è più che stringersi le mani”, cosa vogliono esattamente John e Paul quando chiedono di essere amati “di più”: una più alta comunione delle anime? O una più lieta disposizione al sesso prematrimoniale? Non lo sapremo mai, ma su wikipedia qualcuno ha annotato che cantandola dal vivo avevano spesso difficoltà a trattenere le risate (anche la sequenza di A Hard Day’s Night propone una lettura goliardica, con Ringo che diventa oggetto delle affettuose attenzioni di John). In cambio di questa non meglio precisata prova d’amore, la partner otterrà non solo le gioie dell’amore corrisposto, ma quelle più sofisticate che si ottengono soltanto quando si diventa oggetto d’invidia: “Spero che tu veda che mi piacerebbe amarti e che lei piangerà scoprendo che noi siamo in due, se m’innamorassi di te”. Questa strofa finale merita uno schema, perché concentra in quattro versi una complessità sintattica che non credo di aver trovato in nessun’altra canzone pop: addirittura la frase “If I fell in love with you”, quando torna alla fine (suggerendo l’idea della chiusura di un cerchio), è diventata una subordinata di quinto grado!
E va bene mr Lennon, abbiamo scoperto che lei non è solo uno scimunito che agita la frangetta sul palco in costume di scena. Lei è un musicista capace di comporre progressioni armoniche originalissime e un cantante in grado di seguire melodie complesse; inoltre è un seduttore/manipolatore, ben disposto a innamorarsi ma solo dietro precise garanzie, espresse con una retorica fin troppo forbita e intricata, che forse esprime anche un certo disagio, l’imbarazzo dei negoziatori. Beh, se le cose stanno così, forse è meglio che ti rimetti il costume, John, e che ricominci a raccontarci qualche amorazzo da balera…
49. All My Loving (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
Chiudi gli occhi e ti darò un bacio. A chi vi dice che John Lennon era un chitarrista scarso, chiedete di suonare la chitarra ritmica di All My Loving. Quattro terzine a battuta, si era mai sentita una cosa del genere? Si è mai sentita in seguito? Forse aveva in mente il banjo di sua madre, anche se alle nostre orecchie mediterranee può ricordare più facilmente un mandolino. Rimane il tratto distintivo di All My Loving, ulteriormente impreziosita dalla linea di walking bass di Paul e dai gorgheggi di quest’ultimo, armonizzati con parsimonia. All My Loving potrebbe essere il primo vero caso in cui i Quattro hanno cercato di dimostrare che sotto i caschetti c’erano dei musicisti, anche se la loro idea di virtuosismo era sensibilmente diversa dalla nostra (e non fu ripresa dai gruppi coevi): vedi l’assolo countryeggiante di George, che invece di essere il vertice tecnico del brano è quasi un momento di riposo tra due strofe che sono una tempesta di accordi e una mitraglia di note di basso.
Non era affatto semplice da suonare All My Loving, e ce ne possiamo accorgere ascoltandola nella versione live all’Hollywood Bowl, con Ringo che parte un po’ troppo veloce e John e Paul che con tutta la più buona volontà non riescono a stargli dietro. E possiamo notare due cose: la prima è che non erano effettivamente i bravi musicisti che avrebbero voluto essere. Il che avrebbe potuto consigliare loro più prudenza in sede di studio, e invece no, tutto il contrario: continueranno a suonare cose più difficili di loro e al limite smetteranno di suonarle dal vivo. La loro musica non smetterà mai di essere una sfida alle loro capacità di strumentisti, un modo per sorpassare i propri limiti. La seconda cosa è che all’Hollywood Bowl malgrado gli errori a catena la canzone funziona lo stesso, come se tutta l’intelaiatura meticolosamente costruita in sala prove alla fine non fosse che un dettaglio: la vera energia della canzone pulsa più in profondità. Per quante volte abbiamo biasimato le ragazzine che ebbero il privilegio di ascoltare i Quattro dal vivo e l’hanno sprecato a urlare tutto il tempo sovrastando gli amplificatori, vale la pena di farsi venire il dubbio: forse era l’unico modo di vivere davvero l’evento, spogliando le canzoni dalla prestazione occasionale dei Quattro, coprendo i suoni imperfetti con un rumore bianco oltre il quale resiste poco più del ricordo della canzone che ci siamo già ascoltati centinaia di volte su giradischi di casa. Proprio come chiudere gli occhi e fingere di baciare quelle labbra (invece di quelle di chiunque altro).
48. Don’t Let Me Down (Lennon-McCartney, lato B di Get Back!, 1969; inserita in Let It Be Naked).
Un giorno finalmente qualcuno chiese ad Arthur Janov, lo psicoterapeuta che ideò la terapia primaria: quanto c’è di vero nella scenetta tipica delle biografie di John Lennon? Cioè davvero lui si metteva in un angolo a urlare e lei lo stuzzicava a rovistare nel profondo dei suoi traumi infantili? Lui rispose: “Nonsense. Non facevamo nulla del genere”. È che ai biografi piace romanzare, senz’altro, e il fatto che il bestseller di Janov si chiamasse L’urlo primordiale è una circostanza troppo ghiotta. Ma Lennon aveva già iniziato a emettere urla primordiali molto prima di conoscere Janov. Anzi è probabile che tra tanti terapeuti scelse Janov, malgrado non fosse proprio il più comodo (esercitava in un altro continente) proprio perché questa idea dell’urlo risuonava con quello che aveva già sperimentato cantando “yes I’m lonely, wanna die“, o “I want you so bad it’s driving me mad“, e soprattutto “don’t let me down“, questo piccolo enorme verso intraducibile in italiano.
Non è che John stia semplicemente supplicando di non essere deluso: John vuole essere sorretto. Ne va della sua vita. Il primo “don’t let me down” è una supplica, che lo sospende sull’orlo di un Fa#minore; il secondo è già una risposta, che lo riaccoglie nell’abbraccio di un confortevole Mi. Lennon era già in una fase di autoterapia: tutti e Quattro in un certo senso lo erano. Negli studi di Twickenham nel gennaio del 1969 stavano cercando di ritrovare un senso al loro stare insieme. Forse avevano aspettative troppo alte: suonare dal vivo, ma senza tradire gli standard che avevano raggiunto ad Abbey Road con le sovraincisioni. L’unico sistema era provare, provare e ancora provare. Si sarebbe rivelato ben presto un metodo troppo sfibrante per i Quattro, eppure i due brani che furono stampati in aprile su un 45 giri (Get Back! e Don’t Let Me Down), sono di ottima fattura. Registrati a fine gennaio dopo che il gruppo era tornato agli studi della Apple, con l’apporto non secondario di Billy Preston, non assomigliano già più ai brani del Disco Bianco che era uscito da pochi mesi (a uccidere i Beatles fu anche questa terribile fretta). Sono brani apparentemente semplici, ma realizzati in un modo unico, da cinque musicisti che li hanno suonati e risuonati fino a dare uno stile personale a ogni nota. L’amore per gli arrangiamenti sovraincisi è stato sostituito da un gusto per la prestazione: anche se non c’è il pubblico ti sorprendi a pensare “speriamo che ce la facciano stavolta”. In effetti qualche errorino verso la fine c’è, ma sono pur sempre i Beatles, e non era così facile suonare i Beatles, per i Beatles. Ho sempre trovato straordinario quel contrappunto scandito nel bridge centrale all’unicono dal basso di George e dalla chitarra di Paul, mentre John canta che è innamorato per la prima volta (“non capisci? Durerà! È un amore senza fine, un amore senza età”). Sembra di sentire una sezione di fiati. Non c’è, ma se ci fosse suonerebbe esattamente le note di George e Paul. Sembra una scelta talmente ovvia: un po’ di Esercito della Salvezza a fare il verso a John che ha quasi trent’anni e insiste nel ruolo di orfano.
A Don’t Let Me Down capita quello che succedeva ad altre canzoni dei primi Beatles dopo un po’ che le suonavano: una specie di progressivo insorgere della parodia. Dovrebbe essere un grido d’amore assoluto, ma qua e là è lo stesso John a fomentare il sospetto che si stia facendo il verso da solo. Il vezzo melodrammatico di allungare di un quarto gratuito la prima battuta della strofa (“Nobody ever love me like she does”, quell'”ever” è del tutto ridondante, come ogni avverbio) quando arriva alla strofa finale sembra autoparodico (“I guess nobody ever really done me”), addirittura due avverbi! Nel film sorridono tutti parecchio, tranne Ringo che è preoccupato di sbagliare le entrate. Paul accenna anche qualche posa in favore del cameraman; per lui più che un urlo primordiale è un ballabile lento.
Nessuno ha mai capito davvero perché Don’t Let Me Down fu esclusa da Let It Be, il disco postumo che documentava quelle sessioni: tanto più che nel film omonimo la canzone viene eseguita sul tetto della Apple (in Let It Be Naked c’è una versione del concerto, ottenuta montando due take diverse). Non va presa necessariamente come una sconfessione del brano; magari aveva un senso commerciale. I Beatles avevano sempre evitato di far confluire tutto il materiale dei singoli negli album. E allo stesso tempo non si può ignorare come Don’t Let Me Down sia una delle testimonianze più importanti e riuscite di quel particolare periodo della storia dei Beatles – uno dei pochi episodi che danno un senso a un’esperienza altrimenti fallimentare. Di lì a poco sarebbero tornati in uno studio coperto e si sarebbero rimessi a sovraincidere come se non ci fosse un domani (che in effetti non ci fu).
47. I Want You (She’s So Heavy) (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).

was mache ich hier
Voi come immaginate la vostra morte? Lo so, chiedo scusa. Con tutti i problemi che ci sono al mondo, eravate venuti qui apposta a leggere qualcosa di leggero, qualcosa che per un attimo vi facesse passare di mente un paio di preoccupazioni: qualcosa sui Beatles. Cascate male: 47, Morto che Parla (giuro, non l’ho fatto apposta). Secondo alcuni I Want You e She’s So Heavy sono due canzoni diverse: un blues e una coda sinfonica, che per quanto mescolate assieme (la coda è anche l’introduzione) mantengono una loro specifica identità. Mixare il blues e Beethoven era qualcosa che tutto sommato non aveva ancora fatto nessuno; dopo I Want You una generazione di virtuosi musicisti prog ci avrebbe provato, concentrandosi però sugli aspetti formali più che sull’impatto emotivo: tutto il contrario di quello che fa qui John Lennon, che il blues lo conosceva di seconda mano e di Beethoven magari giusto le sonate che gli strimpellava al piano la moglie; però era in grado di intuire quella frequenza in comune che Beethoven condivide persino con Robert Johnson: un senso di fatalità ineluttabile, un Destino che bussa alla porta e non c’è niente da fare. Voi come immaginate la vostra morte? Un giorno busserà pure alla vostra porta, chiedo scusa. E sarà solo l’inizio.
Se ammettiamo che I Want You (il blues) e She’s So Heavy (Beethoven) siano due canzoni separate ma montate assieme, su Abbey Road di medley ce ne sarebbero due: quello lungo sul secondo lato che termina con La Fine, e quello breve lennoniano sul primo lato, che finisce con una lunga coda strumentale e un silenzio improvviso. Sappiamo che Lennon pensava ormai di divorziare dai tre colleghi. Sappiamo anche che avrebbe voluto invertire i lati del disco, ovvero farlo cominciare con Here Comes the Sun e chiuderlo nell’abrupto modo in cui finisce She’s So Heavy, quello stacco netto che probabilmente portò qualche acquirente a riportare il disco in negozio come copia fallata. Alla fine vinse Paul, che aveva più voglia di preoccuparsi di dettagli come la scaletta del disco e il mix finale; ma soprattutto un’idea di finale molto più conciliante col pubblico: un bel carosello di chitarre, una bella frase proverbiale e cerimoniosa al punto giusto, magari ancora un ultimo scherzo per gli amici, e poi a casa: che non è mica finito il mondo, eh? Al limite saranno finiti i Beatles.
Invece per Lennon stava finendo proprio il mondo. Il confronto tra i finali dei due medley tradisce proprio questo enorme scarto esistenziale: è come se dai due lati del disco John dicesse a Paul: ma ancora ti preoccupi per i Beatles? Non capisci che sto morendo? Potrebbe essere domani come tra vent’anni, non lo sai che il tempo è un dettaglio, un’illusione? che tutto è già stato scritto, come un serpente di note che si mangia la coda, e inoltre sono passato all’eroina? E anche ammesso che sopravviva all’oppiaceo più forte sul mercato, cosa può esserci dopo di più potente, di più definitivo, di più pesante?
Il brano comincia, ironicamente, con un assaggio della coda finale, interrotto dopo dieci secondi dal riff di I Want You. Che sia un blues lo capiamo al primo ascolto, anche solo dal fatto che Lennon canti all’unisono con la chitarra, come aveva cominciato a fare durante le sessioni di Twickenham, e sembra non potersene stancare. Diventa ancora più chiaro dopo dieci battute, quando il riff viene ripetuto una quinta più in alto: è un blues lentissimo dunque, quasi fermo, ed è in minore: ma è un blues. Lennon desidera qualcosa, la desidera così forte che ne sta impazzendo, e questo è tutto. Non c’è neanche più spazio per il bestiario allegorico di Yer Blues, qui non ci sono più né immagini né metafore, la coscienza è ridotta a una voce che grida il suo desiderio nel deserto. Può essere il desiderio di una persona o di una sostanza, ma è un desiderio nudo, che non lascia scampo, al punto che non sembra più avere molta importanza se sarà alla fine soddisfatto o no: follia e morte seguiranno in ogni caso. Nei momenti in cui gli viene lasciato spazio il basso di Paul non sta fermo un attimo, un canarino in una gabbia pentatonica; alla fine di ogni strofa Billy Preston pesta l’organo come uno strumento a percussione: finché sulla soglia dei due minuti tutto tace all’improvviso per un istante brevissimo – neanche il tempo di inalare, e John sta già intonando “She’s So…” Ed entra il Destino.

È così pesa
Entra senza bussare e non è che possa passare inosservato – ugualmente, al primo arrivo potremmo ancora non aver capito chi è davvero. Siamo distratti dai cori (“heavy, heavy, heavy“) e dall’assolo di Preston che non sa di essere stato convocato a un funerale: per lui è una passerella e non se la fa sfuggire (il suo assolo si disperde nel riff come uno schizzo di qualcosa in un liquido più scuro). Così farà la morte con molti di noi: la prima volta la scambieremo per un male passeggero, o un’avventura folle ma con una via di uscita. Niente di così terribile. Dura venti secondi, e poi riparte il blues, che a dire il vero non è più lo stesso blues: fu registrato in un secondo momento, anche se poi quasi tutti gli strumenti furono doppiati, il che fa sembrare la versione finale molto più coesa di quanto non sia. È una I Want You 2, una specie di cover vagamente caraibica, alla maniera di Black Magic Woman dei Fleetwood Mac. Anzi, per essere più precisi: sarà Santana nel 1970 a immortalare Black Magic Woman suonandola sul ritmo vagamente caraibico di questa porzione di I Want You. Lennon continua a ribadire il suo desiderio mortale ma troviamo meno facile credergli: magari è ancora sotto botta. Segue un ulteriore scambio tra I Want You2 e She’s So Heavy che confesso di trovare abbastanza ridondante, malgrado McCartney e Preston ce la mettano tutta per non annoiare l’ascoltatore: così che siamo già a 4:30 quando Lennon lancia il suo grido primordiale e fa entrare il Destino per l’ultima volta (tra le altre cose, I Want You – She’s So Heavy è anche una funebre parodia di Hey Jude: prendi una canzone triste e fanne un requiem).
È abbastanza ironico che la parte beethoveniana della canzone sia più semplice della parte blues: e allo stesso tempo è giusto così, Lennon non ricorre a Beethoven per mitigare un complesso di inferiorità musicale: Lennon cerca nel romanticismo qualcosa di molto più semplice e mortale. Il serpente di note che si mangia la coda è formato da una breve scala ascendente di quattro semiminime che appena sembrano essersi assestate su un plateau, cascano subito in basso con una terzina (dal sapore vagamente blues); cominciano ad annaspare con un’altra terzina e finalmente ritrovano la via per risalire verso l’alto: ma a questo punto siamo di nuovo sullo stesso plateau, stiamo di nuovo per ricadere con la stessa terzina, stiamo di nuovo annaspando: è un loop, non se ne esce, non se ne può più uscire. Dopo qualche ciclo non ricordiamo neanche più qual era l’inizio e quale la fine: è tutto perfettamente circolare e autoconseguente e noi ne siamo prigionieri. Ci alziamo, prendiamo fiato, ricadiamo, annaspiamo, ci rialziamo. Sarà sempre così: desiderio, parziale appagamento, delusione, angoscia, desiderio. Possiamo cambiare donna e cambiare sostanza, ma non possiamo cambiare il nostro destino: siamo nati desiderando e il Desiderio ci farà girare finché non sarà stanco di noi: finché senza preavviso non ci saremo più e non avremo nemmeno il tempo per accorgercene, sarà uno stacco netto, ecco, John Lennon la sua morte la immaginava così. Sì, lo so, voi volevate soltanto riascoltare una vecchia canzone, mi dispiace. Non succederà più, prometto. Non si poteva più fare niente dopo I Want You. John lo aveva fatto presente, ma Paul non capiva e poi vabbe’, chissenefrega, divertitevi pure coi vostri dischi di canzoncine, mentre io muoio.
46. Drive My Car (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Ho detto a questa ragazza che avevo buone prospettive, lei mi ha risposto, seh vabbe’ lo sappiamo. È tutto ok quando lavori per due noccioline, ma io ti farò vedere cos’è il successo. Baby, puoi guidarmi la macchina, lo sai che io sarò una star. Se vi chiedessero di spiegare l’ottimismo della Swinging London con una canzone sola, avreste qualche dubbio? Beep Beep, Beep Beep, Yeah! Philip Norman racconta come Paul in quel periodo andasse in giro travestito, baffi finti e cose del genere, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Dopo averlo letto diventa impossibile non immaginare che Drive My Car parli proprio di questo: Paul che si diverte ad attaccar bottone con una ragazza che ha Grandi Aspettative: lei sarà una star del grande schermo, tu nel frattempo puoi farle da chaffeur. Non c’è neanche bisogno di decifrare il doppio senso – che comunque c’è, autorizzato dallo stesso Paul (“Drive my car era un vecchio eufemismo blues per il sesso”). La ragazza ce la può fare, in fondo è sfrontata il giusto, probabilmente ha anche già riconosciuto chi è quel tizio con i baffi finti che può davvero guidarla al successo.
Con Drive My Car Paul sta giocando a nascondino col suo personaggio pubblico. La protagonista sta confessando i suoi sogni di gloria all’unico ventenne a Londra che non ne ha più, li ha realizzati tutti – cos’altro poteva chiedere alla fortuna Paul McCartney, nel 1965? Magari giusto una ragazza ingenua e intraprendente da rimorchiare al parco, un pomeriggio da persona normale a fare sogni a occhi aperti. Anche da un punto di vista musicale, Drive My Car rappresenta i Beatles formato rock al massimo della forma: sembra tutto semplice ma non c’è niente di banale. Paul, che per una volta ha una storia coerente da raccontare (con tanto di battuta finale!), opta per la più classica alternanza di strofa e ritornello. Per la strofa rispolvera il suo timbro littlerichardiano: una scelta singolare visto che sta dando la parola a una ragazza: ma serve a ribadirne la sfrontatezza: e soprattutto a marcare il contrasto col momento in cui da sfrontata si fa ammiccante, e le seconde voci si dispongono un accordo di settima minore (“but you can do something in between“). Il riff di chitarra raddoppiato dal basso è un’idea di George, un prestito riconosciuto da Respect di Otis Redding.
Drive My Car è in effetti uno dei rari casi in tutto il catalogo Beatles in cui una donna parla. Il caso è ancora più eccezionale dal momento che parla per tutto il ritornello, ed è suo lo stesso titolo della canzone: non succederà più, mi pare, fino a Let It Be. Molti titoli dei primi Beatles erano richieste d’amore da declinare in modo più o meno fisico: Love Me Do, Please Please Me, Hold Me Tight, I Want to Hold Your Hand, eccetera. Ma il più provocatorio di tutti Paul lo mette in bocca a questa ragazza che forse è meno ingenua di quanto appare: puoi guidarmi la macchina, baby. E forse ti amerò. Chi sta guidando davvero, dei due?