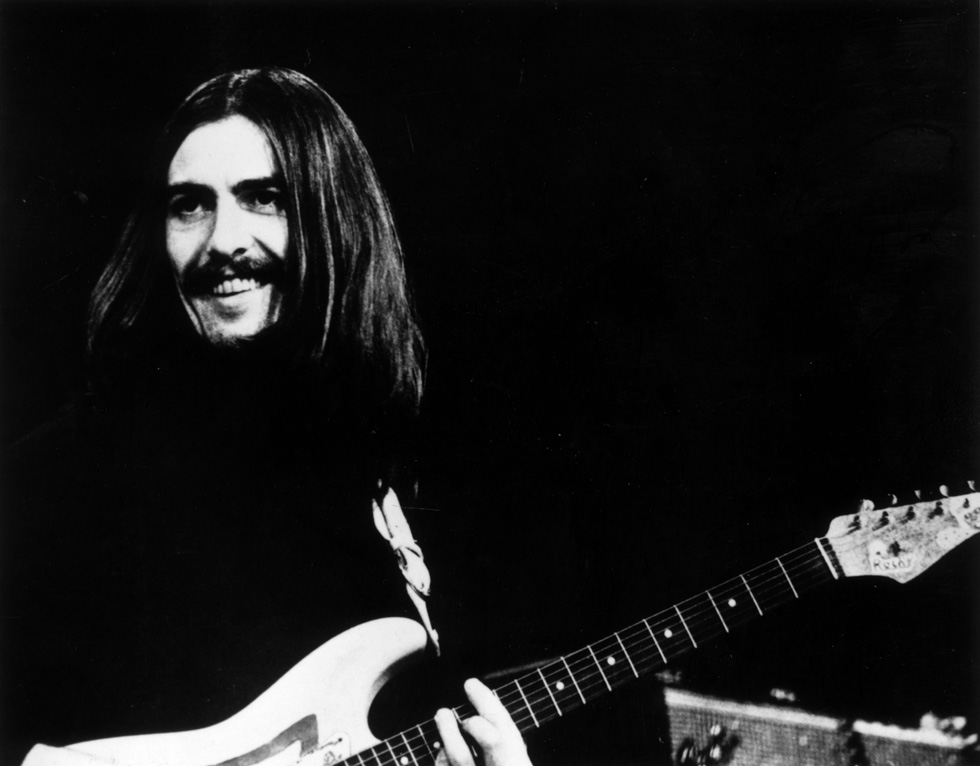Ora però parliamo dei RAGAZZI
(Buongiorno a tutti, questa è la classifica di tutte le canzoni dei Beatles, come stiamo procedendo? Ormai siamo quasi a metà, in un punto in cui ci imbattiamo in canzoni né eccezionalmente brutte né eccezionalmente belle, insomma in brani non eccezionali di cui forse è più facile dimenticarsi. Persino i Beatles, a volte, davano l’impressione di non rammentarsene).
Puntate precedenti: Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201), (#200-181), (#180-165).
La playlist su Spotify.
165. Free as a Bird (Attribuito a Lennon-McCartney-Harrison-Starkey, Anthology I, 1995)
“Can we really live without each other?
Where did we lose the touch
That seemed to mean so much?
It always made me feel so…”
“Free as a bird”.
I Beatles, tra le altre cose, sono un Mito della Caduta. A questa idea nel 1995 Paul McCartney doveva essersi rassegnato; aveva avuto tutto il tempo per farlo. C’è stata un’età dell’oro, benedetta dagli dei, in cui qualsiasi accordo infilato a casaccio in una canzone per teen-ager era un capolavoro. Era favoloso, era assurdo, forse un insieme pazzesco di coincidenze, ma insomma a un certo punto è finito, e mezzo secolo dopo non smettiamo di chiederci: di chi è stata la colpa? Sono stati i soldi, le mogli, l’invidia, la droga, insomma cosa? Se solo si potesse dare tutta la colpa a Mark Chapman: se solo fosse così facile. Ma neanche puoi tenertela, questa immensa colpa, o dividerla con altri tre compagni che non avevano nemmeno trent’anni. E ora che faremo? Siamo condannati a vivere del frutto del nostro sudore? Scrivere dischi per tutta la vita anche se la gente vuole ascoltare solo quelli che buttavamo fuori allegramente a vent’anni? Come abbiamo potuto rassegnarci a vivere l’uno senza l’altro? Quand’è che abbiamo perso quel Tocco che ci rendeva così, così…
(Dillo tu, John)
“…così liberi“, dice John. “Liberi come uccelli“.
(Salvo che non è John, è solo un vecchio nastro registrato).
I morti non invecchiano, l’avrete notato. In qualsiasi momento torniate a trovarli vi mostreranno lo stesso sorriso, che a seconda della luce o della stagione vi saluta o vi compatisce o vi sbeffeggia. Ma è sempre lo stesso e col tempo può persino risultare irritante, questa cosa di rimanere sempre sulle stesse posizioni, tornare sempre sugli stessi ricordi. I morti non ne hanno altri, non cambiano più idea, e John Lennon per esempio aveva idee molto nette sui Beatles e sulla libertà.
La libertà, per Lennon, era anche e soprattutto libertà dai Beatles. Lo aveva scritto abbastanza chiaro in God, ma non è che McCartney avesse avuto idee molto diverse quando in You Never Give Me Your Money sognava di fuggire su una limousine lontano da quella gabbia di matti. Paul però ha avuto tutto il tempo per cambiare idea, per assistere alla progressiva costruzione del Mito (della Caduta) e sopravviverne, accettando di esserne il protagonista. E così rieccoli assieme, il vivo e il morto, in un fotomontaggio irrimediabilmente sbagliato e comunque struggente. John, che odiava i Beatles, aveva scritto un ritornello sulla gioia di essere liberi; Paul scrive un bridge sulla pena di non poter più essere liberi, perché i Beatles non esistono più. È impossibile capirlo dal nastro registrato, ma quando riprende a cantare, è come se John stesse sorridendo di lui.
(Ora che sono passati 25 anni da quando Yoko Ono concesse a Paul McCartney l’uso del demo di Free As a Bird, possiamo dirlo: non è una canzone dei Beatles. Ormai è remota da noi quanto erano lontani i veri Beatles dai superstiti che tornarono a incidere Free As A Bird nel 1995. In quel decennio un paio novità tecnologiche resero per qualche stagione meno macabro il concetto di “duetto col defunto”, che diventò anzi una specie di format: aveva cominciato Natalia Cole duettando col papà e nel giro di dieci anni si arrivò a remixare Elvis. Anche in questo contesto Free non poteva che lasciare perplessi, malgrado l’amore e il rispetto con cui era stata rilavorata dai tre superstiti con Jeff Lynne. Ma non c’era ancora modo di sapere come avrebbe retto al tempo: se gli anni, accumulandosi, l’avrebbero fatta suonare più simile ai veri brani dei Quattro. 25 anni dopo viviamo in un mondo digitale, ossessionati dal concetto di fake, e Free As a Bird ci urta proprio in quanto falso storico. Ma tra altri 25 anni chissà).
164. Wait (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
It’s been a long time. Come forse intuite, questa non è la prima classifica di tutti i brani dei Beatles dal migliore al peggiore. Quando sarà finita sarà ovviamente la più lunga (e faconda), ma nel frattempo il primato spetta ancora al magazine on line Ultimate Classic Rock, che qualche anno fa pubblicò una lista di più di 220 canzoni, comunque 27 in meno della nostra, ah ah, pivelli. UCR ignorò la più parte degli inediti di Anthology, certe outtakes del Disco Bianco che non erano ancora state pubblicate e… Wait. No, aspetta, perché saltarono Wait?
Wait è tutt’altro che un brano inedito, e si trova anzi in uno degli album più importanti. Però ha un titolo molto breve, uno di quelli che si cancellano con un clic, e questo potrebbe aver tratto in inganno i compilatori. Per dire quanto è facile dimenticarsi di Wait. Persino i Beatles se ne dimenticarono, in un certo senso, escludendola da Help!, per poi recuperarla qualche mese dopo, mentre la scadenza natalizia incedeva inesorabile sulle sessioni entusiasmanti ma meno fruttuose di Rubber Soul. Non significa necessariamente che la considerassero uno scarto: magari era un’idea sulla quale avrebbero preferito lavorare un po’ di più (ma ebbero solo il tempo per aggiungere tamburello e maracas, un assolo di George e un coro di Paul). Wait è un classico esempio di riempitivo beatle dell’età di mezzo: non è un avanzo registrato in fretta e alla bell’e meglio come Little Child, né un bizzarro esperimento di laboratorio come Good Morning. È un brano tutt’altro che banale e anzi discretamente sperimentale per l’uso delle percussioni ‘in crescendo’, la strofa in sestine alternate ABCABC, la presenza sia di un ritornello sia di un bridge, cantato da Paul, che dà alla canzone una dimensione ulteriore. Però è quel tipo di brano che scivola rapido senza restare in testa, mettiamola così. Io comunque me lo sono ricordato, nella classifica del Post Wait c’è. (Ne avrò senz’altro dimenticato un altro. Con un po’ di fortuna non se ne accorgerà nessuno).
163. I Don’t Want to Spoil the Party (Lennon-McCartney, Beatles For Sale, 1964)
John Lennon nel numero “a questa festa mi si nota di più se me ne vado”. I Don’t Want to Spoil the Party rompe un tabù: per la prima volta qualcuno nel beatleverso ammette di avere preso “un drink o due”. Quindi, insomma, si beve. Chissà se si fuma addirittura… Il secondo lato di Beatles For Sale è il momento in assoluto più country nella discografia dei Beatles, e a questo punto ormai abbiamo capito che il country era un genere che i Beatles non disprezzavano, ma a cui si rivolgevano per disperazione: la ragazza simpatica a cui ti riduci a fare il filo per cercare di dare senso a una serata che non doveva finire così. E malgrado in questo caso il country sia in sostanza una mascheratura, sotto la quale I Don’t Want conserva una struttura schiettamente pop, c’è in questa scelta qualcosa di assolutamente appropriato.
Il country mette in scena stereotipi rigorosi: la società è una sala da ballo, stare al mondo è apparentemente facile (è sufficiente chiacchierare, bersi un bicchiere, rispettare le figure della danza), salvo che il cantante proprio non ci riesce. Decide quindi – virilmente – di allontanarsi da solo, perché la Festa non dev’essere rovinata. Tutto abbastanza giusto e inoltre a chi di noi non è successo, di scoprire che eravamo in un posto solo perché speravamo che ci fosse qualcuno, qualcuno senza il quale la società si svela un meccanismo vano e insensato. Ovviamente era previsto che la cantasse Ringo (o magari George, avrebbe avuto un senso anche per George). Ma anche stavolta la scadenza natalizia si avvicinava minacciosa, non restava che mettersi a flirtare con tutti le vecchie canzoni che non erano ancora state incise in quei due anni, alcune delle quali erano brani country ancora più adatti a Ringo (Honey Don’t) o a George (Everybody’s Trying to Be My Baby). Così alla fine I Don’t Want rimase a John – oppure fu John a capire che in una canzoncina del genere c’era qualcosa di sommessamente tragico che meritava il suo prezioso intervento vocale? Non lo sappiamo. Non siamo neanche sicuri di chi siano i cori: chi ci sente George, chi John, chi Paul (soprattutto nel bridge). Quest’ultimo nella sua biografia fa i complimenti a… Ringo: si vede che è da un po’ che non la riascolta. Ma insomma si vede che è facile dimenticarsi anche di I Don’t Want to Spoil the Party. Come di tante feste di cui non ti restava che la puzza di fumo sui vestiti il giorno dopo, e un vago senso di vuoto.
162. For You Blue (Harrison, Let It Be, 1970)
I’ve loved you from the moment I saw you. Qual è l’ultima canzone dei Beatles? Scelta ardua. Candidati papabili: Let It Be, in quanto ultimo singolo, e ovviamente The End. Ma dopo The End c’è pur sempre Her Majesty. Oppure I Me Mine, che fu l’ultima canzone che registrarono nel 1970. Ma a quel punto Lennon era già fuori, e quindi perché non aggiungere Free As a Bird, incisa appena 25 anni dopo? Però dopo Free c’è Real Love… Insomma, è complicato.
Il Disco Blu finiva con The Long and Winding Road, una scelta suggestiva perché davvero quell’orchestra non te l’aspetti, è una specie di sigla a sipario già sceso. Quanto all’ultimo album, Let It Be, finisce con un brano che era uscito come singolo addirittura l’anno prima, Get Back!: più che un finale sembra un bis. Prima di Get Back! Phil Spector volle inserire For You Blue, che quindi è uno dei meno credibili candidati alla posizione di “ultima canzone dei Beatles”. E tuttavia nella sconcertante banalità di questo blues in 12 battute, uno dei rari casi di riempitivi senza vergogna in tutta la loro discografia, c’è qualcosa che ci dice che davvero la storia è già finita.
John si diverte a suonare la chitarra con un bossolo di metallo, George lo incita invocando il dio della slide guitar (“Elmore Jones got nothing on this, baby!”). È quel tipo di jam rilassata che segue una tempesta. Come se non ci fossero più scadenze, non più battaglie da combattere, territori da marcare: solo vecchi amici che perdono tempo suonando un blues, purché sia il blues meno triste possibile. Più che l’ultima, For You Blue sembra la prima canzone che i Beatles hanno inciso dopo essersi sciolti.
161. Octopus’s Garden (Starkey, 1969, Abbey Road)
“Restai sul ponte col capitano e parlammo delle piovre. Mi raccontò che vanno in giro sul fondo del mare cercando pietruzze luccicanti, lattine di metallo e bottiglie per collocarli davanti alle loro tane, come se fossero un giardino. Pensai che fosse fantastico, dato che anch’io all’epoca avrei voluto vivere sotto il mare”.
Con la sua seconda prova autoriale, Ringo torna in quei fondali marini che ci aveva fatto scoprire cantando Yellow Submarine. Ma persino gli abissi non sono più quelli di una volta: se nel 1966 erano l’ambiente ideale per avventurose scorribande di un gruppo di amici, ora quel che importa davvero è che laggiù si è al sicuro (“safe”). La Piovra, ci spiega Ringo, ci farebbe entrare, perché la Piovra sa attraverso cosa siamo passati: e laggiù urleremmo e nuoteremmo e canteremmo e riposeremmo, nell’ombra, e nessuno saprebbe più trovarci.
Se è finalmente una buona canzone per bambini (quella che non erano riusciti a incidere sulla colonna sonora di Yellow Submarine), è stata scritta da un padre moderatamente apprensivo e stanco dei tumulti del successo. Ma in un certo senso è ancora la vecchia fantasia di Brian Epstein, di quando si era messo a cercare un’isola greca dove rifugiarsi coi suoi quattro ragazzi e non invecchiare mai. Ringo la concepì al largo della Sardegna, sullo yacht che gli aveva prestato Peter Sellers, in quello scorcio d’agosto in cui era scappato dalle session del Disco Bianco. Octopus’s Garden trova la sua strada per Abbey Road soprattutto grazie al piccolo aiuto di George Harrison, che trasforma l’abbozzo dell’amico in una canzone completa e ne approfitta per aggiungere il riff di chitarra più spensierato del disco. Si riverbera sul brano la luce smagliante di Here Comes the Sun, segno dell’intesa particolare maturata tra i due Beatles di seconda fila – la stessa squadra che due anni dopo avrebbe mandato in classifica It Don’t Come Easy. Chissà che avrebbero combinato ancora assieme se i Beatles non si fossero sciolti (chissà perché continuiamo a farci questa domanda. Si sono sciolti. Non poteva andare diversamente. Sul serio, dai).
160. Slow Down (Larry Williams, singolo americano del 1964, poi nell’EP Long Tall Sally).
Un altro brano di cui è facile scordarsi. Persino i fan di Larry Williams – e non ne aveva troppi – gli preferivano il lato B, Dizzy Miss Lizzy. Gli stessi Beatles avrebbero onorato Dizzy usandola come chiusura del loro ultimo disco vagamente yeah-yeah, una specie di ultimo bis prima di salutare e cominciare a progettare il futuro. Slow Down invece l’avevano già incisa sul lato A di un singolo americano, in quel tumultuoso 1964 in cui avrebbero potuto anche incidere una gara di peti con le ascelle e il disco sarebbe comunque finito in top100. Ristampata nel Regno Unito nell’EP Long Tall Sally, Slow Down è un altro tassello di un’operazione più sentimentale che economica: un revival del rock’n’roll più sanguigno che gli inglesi avevano potuto ascoltare soltanto sulle onde incerte delle radio pirata, e che per qualche coetaneo dei Beatles poteva funzionare da madeleine. Un ritorno ai suoni di una preadolescenza breve e irripetibile: il suono a cui di lì a poco Animals e Rolling Stones avrebbero dato una solenne spolverata. Negli USA invece Slow Down doveva suonare come una mossa precisa di appropriazione culturale: conosciamo il rock’n’roll meglio di voi, siamo qui per riscattare i suoi eroi meno compresi in patria. Ma se qualcuno nel loro entourage si aspettava di ottenere più successo così che con i pezzi smielati e yeah-yeah, si sbagliava. Meglio così, credo. Agli americani interessavano più i Beatles che il rock’n’roll: i Beatles se ne accorsero presto e si regolarono di conseguenza.
159 I’ll Get You (Lennon-McCartney, 1963; lato B del singolo She Loves You).
Immagina che io sia innamorato di te… è facile, perché è vero. Un mese fa sul giornale della Society of Neuroscience statunitense è stata pubblicata una ricerca sul piacere della musica, Prevedibilità e incertezza nel piacere della musica: una ricompensa per l’apprendimento? Per i ricercatori della McGill University (Canada) e della Queen Mary University (Canada) la produzione di dopamina legata all’ascolto di brani musicali dipende anche dai passaggi tra gli accordi, che non devono essere troppo prevedibili, ma sorprendere di tanto in tanto l’ascoltatore. Una conferma a questa ipotesi è arrivata da un gruppo di studiosi tedeschi e norvegesi che ha esaminato 745 brani presi dalle classifiche americane tra il 1958 e il 1991, ed è giunto alla conclusione che il segreto sia la combinazione tra incertezza e sorpresa.
Tutto questo come poteva saperlo il ventenne Paul McCartney mentre componeva I’ll Get You con John Lennon a casa di zia Mimi, sul letto di John, cercando di evitare il manico della chitarra di John col manico della sua? I’ll Get You è quasi un manuale di composizione beatle, un compendio dello stile “yeah yeah”: si comincia con i tre accordi classici, il primo il quarto e il quinto (do, fa e sol), tutti maggiori. Ci puoi cantare Twist and Shout e centinaia di altre canzoni, ma stavolta ci canti “Immagina che io sia innamorato di te”. E a quel punto un altro gruppo sarebbe abbastanza soddisfatto, ma i Beatles no. Il secondo verso aggiunge un accordo ed è un la minore: ed ecco che Twist and Shout si ammolla in un languido giro di Do, talmente legato al doo-wop e ai gruppi vocali degli anni ’50 che in inglese lo chiamano proprio “50s progression“. Anche al microfono Paul e John cominciano ad atteggiarsi a crooner, raddoppiano gli aggettivi “many many many times before”. E la canzone a questo punto potrebbe ritenersi abbastanza originale, per come alterna due progressioni armoniche che rimandano a due stili diversi. Ma Paul vuole qualcosa di più, Paul ha sentito in un brano di Joan Baez un accordo nuovo (un Sol Minore Settima) e ha deciso di usarlo alla prima occasione.
Non importa che la Baez stesse cantando un brano folk delle Bahamas, mentre Paul sta scrivendo una canzone di facile ascolto per le ragazze inglesi: Paul ha voglia di Sol Minore Settima, e Sol Minore Settima sia. Lo sentite nel momento in cui cantano “pretend”, ed è appena un istante, davvero. Non rende la canzone minimamente simile a All My Trials, però… è un accordo insolito, e la dopamina pare che si produca così. Per una pura coincidenza, il Sol Minore Settima cade proprio sulla parola “pretend”: è come un esitazione, un voltarsi indietro, ai segreti della propria coscienza, prima di prendere coraggio e affermare i propri diritti virili: “but I’ll get you, I’ll get you in the end. Yes I will, oh yeah, oh yeah, oh yeah”. Siamo in effetti all’apice della fase “yeah”: I’ll Get You doveva essere il singolo successivo a From Me to You, ma alla fine uscì come lato B di She Loves You, in una versione un po’ tirata via perché tutti gli sforzi si sono concentrati sul lato A. Non c’è nemmeno una chitarra solista udibile (George, dove sei?); in compenso l’armonica di John segue, per quanto può, la progressione armonica, dando al brano quella particolare coloritura che a quel punto sulle frequenze inglesi era immediatamente riconoscibile: il suono dei Beatles (in effetti chi altri sarebbe stato così barbaro da usare l’armonica in quel modo?)
I’ll Get You comincia con la parola “Imagine”, mentre il secondo verso recita “it’s easy”. È facile immaginare un amore, spiegano John e Paul. Qualche anno dopo John avrebbe usato le stesse parole in un’altra canzone – se ci pensate un attimo, l’avete sentita sicuramente.
158. The Continuing Story of Bungalow Bill (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
“Uscì a cacciare con gli elefanti e la pistola. In caso di incidente portava sempre con sé la mamma. È il classico americano bianco, l’orgoglio di sua madre, testa di pallottola…”
Richard A. Cooke III è il co-fondatore di Hui Ho’olana, un centro artistico ed educativo a Kualapu’u nelle Hawaii. È stato a lungo fotografo freelance, collaborando soprattutto col National Geographic e con lo Smithsonian Institute, e pubblicando due libri: America’s Ancient Cities e The Blue Ridge Range. Ma non è il motivo per cui è famoso in tutto il mondo, vero?
Il motivo per cui il mondo lo conosce è che quando era un ragazzo – un ragazzo bianco e ricco, figlio di una potente figura della moda USA, Nancy Cooke de Herrera – andò in India e sparò a una tigre. Una cosa che un sacco di ragazzi bianchi fa ancora oggi senza che nessuno si scandalizzi più di tanto. In certe zone sono proprio gli indiani a chiedere ai cacciatori di abbattere le tigri che creano prevedibili disagi. Richard però dopo aver ucciso una meravigliosa tigre ed essersi fotografato sopra la sua preda (con la mamma fiera al fianco), sentì un turbamento simile a un senso di colpa e andò a parlarne al guru che da qualche anno sua madre seguiva professionalmente – sì, a un certo punto Nancy Cooke era passata da ambasciatrice ufficiale della moda USA ad addetta PR di Maharishi Mahesh Yogi. Il guru fu meno conciliante del solito, e mise in chiaro che “distruggere la vita è distruggere la vita”: come dargli torto. Da quel giorno Richard non sparò più e sostituì la fotocamera al fucile.
Anche tutta questa storia non avrebbe fatto il giro del mondo se all’udienza di Richard non avesse assistito John Lennon. Lennon che in mezzo a tutta quella pace e quella meditazione non riusciva a calmarsi, continuava a pensare a quella ragazza giapponese e non riusciva a impedirsi di trovare buffe le cose, in particolare le cose dei ricchi. Per esempio questo bellimbusto che si prendeva una pausa dalla meditazione trascendentale per andare a fare caccia grossa con gli elefanti e i fucili e la mamma, e poi tornava piangente a corte del Maharishi a sfoggiare un senso di colpa come un trofeo, non si meritava di diventare protagonista di una canzone di John Lennon? E magari Richard avrebbe smesso di fare il cacciatore anche se Lennon non lo avesse messo alla berlina davanti a tutto il mondo. Tra l’altro non lo chiamò nemmeno per nome, nulla di paragonabile anche lontanamente agli autodafé che oggi si innescano quotidianamente sui social network.
The Continuing Story è l’idea lennoniana di farsa, ormai nettamente divergente da quella concepita da McCartney in altri numeri di Sgt Pepper’s e del Disco Bianco. McCartney concepisce la farsa come un mascheramento e lo vorrebbe sempre più preciso, sempre più sofisticato: in Honey Pie vorrebbe ridurre la voce a un graffio sul grammofono. Per Lennon la farsa è libertà: il carnevale non è l’occasione per lavorare a maschere elaborate, ma per andarsene per strada in pigiama o quasi nudi. Malgrado questo, o proprio per questo, è uno dei brani più politici dei Beatles, se non forse l’unico brano politico che abbiano mai realizzato, una satira del consumismo armato meno allucinata di Happines is a Warm Gun. Anche lo strumento più costoso e all’avanguardia (il maledetto mellotron!) viene impiegato come un giocattolo: è davvero come se Lennon giocasse a premere tasti a caso – se ne premi uno esce fuori un assolo di flamenco, bello! Mettiamolo nella canzone. Alla fine fischiettiamo tutti in coro, mi raccomando, un po’ stonati. Ah, e Yoko vuole cantare almeno un verso, perché no? Facciamo che Yoko è la mamma di Bill. (Sigmund Freud scuote la testa in segno di assenso). La mamma di Bill, a detta dei testimoni, era una abbastanza antipatica (Mia Farrow: “una signora di mezza età che si dava un sacco di importanza”). Per entrare a giocare coi maschi, Yoko deve rassegnarsi al ruolo di vecchia bianca ricca e supponente. Che pazienza ci voleva con quei quattro.
157. Act Naturally (Morrison-Russell; incisa dai Beatles in Help!, 1965).
“Spero che mi verrai a vedere al cinema, così saprò che hai potuto vedere il più grande buffone che abbia mai avuto successo; e tutto quello che devo fare… è essere me stesso”. Certo, If You Got Trouble sarebbe stata una scelta più coraggiosa e di rottura. Ma come avrebbero potuto evitare di incidere Act Naturally i Beatles, nel 1965? Come avrebbero potuto impedire a Ringo di cantare una canzone che sembra scritta apposta per lui? Con il film A Hard Day’s Night Ringo aveva dimostrato di avere la faccia adatta per il grande schermo. Tutto quello che doveva fare era comportarsi in modo naturale, appunto. La canzone parla di questo e ci mette esattamente la malinconia e l’autoironia che ci aspettiamo dal personaggio-Ringo. Il country, coi suoi arrangiamenti rigidi e impassibili, funziona qui da corrispettivo musicale al deadpan humour, l’arte di far ridere senza ridere. Non è così facile essere sé stessi – specie se tutti intorno a te stanno impazzendo, cantando suonando e facendo milioni e perdendoli. Ringo ci è quasi sempre riuscito, diamogliene atto.
156. Boys (Dixon-Farrell; registrata dai Beatles in Please Please Me, 1963).
“Shod shu bop, shu bop shod shu bop”. Sto parlando di RAGAZZI, adesso. Se Boys a Liverpool era diventata “il numero del batterista”, la canzone affidata all’ugola dello sfigato nascosto dietro il set dei tamburi, era probabilmente perché veniva incontro alle loro difficoltà: la maggior parte delle parole le canti prima di iniziare a darci dentro con le bacchette; dopodiché il grosso del lavoro lo fanno i cori (“Shod shu bop, shu bop shod shu bop” e tu devi solo lanciare un “hey hey” ogni tanto: si può fare. Quindi per esempio nei Beatles la cantava Pete Best, e negli Hurricanes di Rory Storm era già il pezzo di Ringo. E sia Best sia Ringo urlavano “boys”, come se fosse la cosa più naturale del mondo – salvo che la hit di Luther Dixon e Wes Farrell era stata composta per le Shirelles, le quali cantandola non lasciavano dubbi sul fatto che i RAGAZZI del ritornello fossero un oggetto del desiderio: sì sì va bene i lollilop e i chewingum e tutto quanto, ma noi adesso vogliamo parlare di RAGAZZI (sì, sì, RAGAZZI).
Vale la pena di domandarselo: per quale motivo non una sola band, ma almeno due gruppi di mancati scaricatori del porto di Liverpool non trovavano per nulla imbarazzante che il loro batterista cantasse a squarciagola la gioia che si prova a parlare di RAGAZZI? Gli stessi protagonisti, anni dopo, ammettevano che la cosa avrebbe dovuto sembrare un po’ strana, ma alla fine era come se venisse naturale. Ci sono tre ipotesi.
(1) Ipotesi puristica: Hurricanes e Beatles preferivano il rischio di essere derisi a quello di allontanarsi anche solo di una sillaba dai testi originali. Succedeva nello stesso periodo anche nella scena folk: per Joan Baez era normale cantare testi che facessero riferimento in prima persona a un protagonista maschile.
(2) Ipotesi cacofonica: Il rock’n’roll prosperava in una specie di bolla culturale e linguistica, in cui le parole (cantate con accento americano anche nei sobborghi di Liverpool) mantenevano un legame labilissimo coi loro significati. Quel che contava erano i suoni, e “boys” aveva il suono giusto (eppure anche “girls” è un monosillabo).
(3) Ipotesi bullistica: al batterista veniva imposto di cantare una canzone sui RAGAZZI perché anche nei suoi due minuti di gloria non doveva mai dimenticarsi di essere lo sfigato del gruppo. Sì, beh, potrebbe essere il caso di Ringo. Ma Pete Best non sembrava altrettanto sfigato dopotutto. Anche nel terzo caso, Boys funziona da Dio e da perfetto anello di congiunzione tra il rock’n’roll del ’57 e il pop dei complessi vocali femminili del ’60. Il rock delle origini non era morto: si era solo messo una gonna e lasciato crescere i capelli. Ma sotto quei coretti e quei caschetti continuava a pulsare più sboccato e irriverente che mai. Voglio dire, qui si parla di RAGAZZI. (Sì, sì, RAGAZZI).