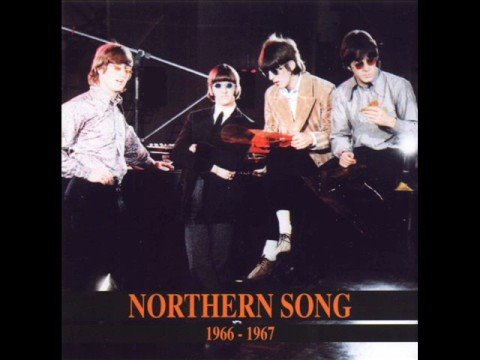Se hai dei problemi, tu hai meno problemi di Ringo
(Cinquant’anni fa usciva Abbey Road, il disco dei Beatles che avrebbe venduto più copie. Da qualche giorno John aveva annunciato ai soci che voleva un “divorzio”, usò proprio quella parola; i compagni lo avevano pregato di non dirlo ai bambini e ai giornalisti ancora per qualche mese; avevano appena rinegoziato il contratto americano con la Capitol e c’erano milioni in ballo, e almeno un film e un altro disco di inediti, insomma, i Beatles avrebbero fatto finto di esistere ancora un po’. Cinquant’anni dopo stiamo ripassando le loro 250 canzoni dalla meno conosciuta alla più apprezzata, a che punto siamo? Più o meno al 220, coraggio).
Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235)
Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#234-225)
224. Like Dreamers Do (Lennon-McCartney, provino Decca, 1/1/1962, ora in Anthology 1).
You, you came just one dream ago… Produttore della Decca, chiunque tu sia, fammi un favore, fatti un favore. Questo ragazzino che canta ancora con un vocione alla Elvis, guardalo bene. Ti sembra un po’ nervoso? Due notti fa suonava a Liverpool, poi si è fatto dieci ore di pullman per fare questo provino. Hai notato che mentre canta solista suona il… basso? E canta bene, e suona abbastanza a tempo, conosci molti altri che alla sua età ne sarebbero capaci? La canzone magari non ti sembra molto originale, in effetti è il tipico sottoprodotto che poteva realizzare un professionista di Tin Pan Alley negli anni ’30-’40, salvo che l’ha scritta proprio questo ragazzo a quindici anni in un sobborgo di Liverpool, senza saper leggere una nota sullo spartito. Poi si è intruppato in una rock’n’roll band, eppure, lo vedi? Riesce lo stesso a imporre il suo materiale fuori dal tempo; in qualche modo riesce a rendere credibile una canzone del genere. Produttore della Decca, andiamo. Se non riconosci un talento in Paul McCartney, in chi?
Ok, è facile col senno del poi. Bisognerebbe trovarcisi, alla Decca, il primo gennaio del 1962, coi postumi della sbornia di capodanno e un certo pregiudizio verso la teppa di Liverpool che si ostina a suonare musica americana con le chitarre – lo sanno tutti che le chitarre hanno fatto il loro tempo. Eppure. L’hai sentita quell’intro? È probabilmente la prima cosa che hanno suonato quel mattino, ancora intontiti e terrorizzati dalla luce rossa che segnala in sala che il registratore sta incidendo. Riavvolgi il nastro. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan… che accordi sono? Hai mai sentito una canzone cominciare così? Lo capisci quanto coraggio hanno questi ragazzi che tra qualche ora ripartiranno sul loro pullman scassato e non li rivedrai più? (Due anni dopo, quando ormai qualsiasi cosa firmata Lennon/McCartney spariva dai negozi di dischi in poche ore, la Decca fece incidere Like Dreamers Do a un gruppo di ex scout di un sobborgo di Birmingham, gli Applejacks. Per sicurezza tolsero l’intro fulminante e aggiunsero un ottuso riff di piano, e così furono gli unici a non entrare in top10 con un brano dei Beatles).
223. Mailman Bring Me No More Blues (Buddy Holly; incisa dai Beatles nel gennaio 1969, ora in Anthology 3).
Di quanti personaggi si dice “senza di lui non sarebbero esistiti i Beatles”, beh, Buddy Holly è uno di pochi per cui possiamo esserne sicuri. La sua influenza su Lennon e McCartney non sta tanto nelle sue intuizioni musicali (che tendevano comunque verso la stessa sintesi di rock e pop che avrebbe fatto la loro fortuna), quanto nella sua immagine pubblica. Il primo nerd del rock’n’roll, con occhiali dalla montatura spessa, un’aria da bravo ragazzo bianco del sud e un approccio sperimentale agli arrangiamenti. Buddy Holly dimostrava che si poteva produrre un rock credibile senza scimmiottare gli afroamericani e senza assumere pose machiste. E soprattutto, Buddy Holly si scriveva le canzoni da solo: nessun altro lo faceva, Lennon e McCartney cominciarono a provarci.
Premesso questo, è un peccato che i Beatles non abbiano prodotto un’interpretazione davvero memorabile di un pezzo di Holly. Quando suonano Mailman durante le sedute del progetto Get Back!, nel gennaio del ’69, non ci stanno nemmeno provando. Forse devono semplicemente scaldarsi le dita, gli studi sono freddi e un blues è sempre la prima cosa che viene loro in mente. L’originale di Holly è una canzone più spensierata e radiofonica, ma i Beatles a inizio 1969 hanno questo problema, tipico di chiunque si metta a frugare nel solaio in caccia di vecchi reperti del passato: vogliono i ricordi, ma non sono pronti ad accettarne gli aspetti più sdolcinati e puerili. Rivogliono l’infanzia, ma senza lo zucchero.

Buddy Holly
222. Rip It Up / Shake Rattle and Roll / Blue Suede Shoes (medley di brani suonati dai Beatles agli Apples Studio il 26/1/1969, ora in Anthology 3).
Qui per esempio ci sono tre istantanee prese da un giorno di prove agli Apple Studios, montate assieme trent’anni dopo in un unica foto ricordo. Sappiamo che quel giorno in particolare stavano frugando nel loro repertorio delle origini, forse nel tentativo di ritrovare il bandolo del progetto Get Back. Oppure lo stavano sabotando e questi vecchi r’n’r erano l’unica cosa che riuscivano a suonare senza litigare, in favore della cinepresa. Queste canzoni per John e Paul sono familiari come le preghiere del mattino e della sera: magari all’inizio le prime parole stentano a saltar fuori, ma basta attaccare e tutto viene da sé.
221. If You’ve Got Trouble (Lennon-McCartney, febbraio 1965, sessioni di Help!, ora in Anthology 2).
“Se hai dei problemi, tu hai meno problemi dei miei”. Solo Ringo poteva dire una cosa del genere. E magari non l’ha mai detta, ma avrebbe potuto cantarla. Ma in realtà non aveva nemmeno una gran voglia di farlo. Eppure If You’ve Got Trouble non è lo scarto orribile che tutti dicono che sia, secondo me. Mi rendo conto di non essere in buona compagnia, anzi in totale solitudine: If You’ve Got Trouble non è gradita nemmeno dai più pazienti degustatori tra i beatologi. Non piace a Mark Lewisohn. Non piace a Ian MacDonald (“l’unico disastro senza mezzi termini in tutto il catalogo Lennon/McCartney”). Non piaceva a George Harrison, che la trovava assurda e pacchiana. Non piaceva a Ringo, che la canta con scarsa convinzione (“rock on anybody!”), e dire che la canzone era concepita come un veicolo per il suo personaggio: un testo tipicamente lagnoso, affidato a poche note e facili. Non piaceva né a Lennon né a McCartney, che alla fine la accantonarono permettendo a Ringo di incidere su Help! l’ennesimo numero di Carl Perkins, Act Naturally. Invece a me If You’ve Got Trouble un po’ piace. Sincero. La canticchio ogni tanto, del resto ognuno ha i suoi problemi (e i tuoi sono meno dei miei).
Sono convinto che sarebbe diventata una buona canzone, se qualcuno ci avesse creduto un po’. O forse no, forse è una buona canzone proprio perché nessuno riusciva a crederci, e così hanno iniziato a giocarci, a rovinarla montandoci sopra un riff di chitarra così spigoloso e insistito che nel 1965 doveva risultare oltre il limite dell’ascoltabile, e invece oggi suona quasi new wave. Per tacere di quel minuscolo coretto, appena un cenno di assenso, “ah-ah“, che parte da una quarta e scivola di un semitono, qualcosa che forse non si era ancora sentito in un pezzo rock. Il testo è uno dei primi a collocarsi fuori dal limitatissimo beatleverso delle canzoni pre-Rubber Soul, popolato esclusivamente da teenager innamorati. Stavolta Ringo è tartassato da una ragazza di buona famiglia che pretende regali, “money and things”, ma i milioni non hanno tolto a Ringo il buon senso e quel briciolo di coscienza di classe: tu ci provi gusto a comportarti male, dice, con tutti i privilegi che hai avuto su di me. Probabilmente non avrebbe reso Help! un disco molto migliore, ma è una canzone che getta un lampo di luce sulle frustrazioni di quattro proletari-milionari immersi in un bel mondo di ricchi veri che fingono di avere più problemi di loro. Probabilmente è di John, che non l’ha mai reclamata.
220. How Do You Do It? (Mitch Murray, incisa a Abbey Road nel settembre 1962; ora in Anthology 1).
Ma come fai a fare le cose che mi fai? Se sapessi come fai te le farei. ReSettima! Una volta messi a contratto i Beatles, George Martin si era messo a cercare un brano adatto a loro, che li mandasse più in alto possibile in classifica. Tutto quel che aveva trovato era How Do You Do It? di tale Mitch Murray, un compositore abbastanza conosciuto nell’ambiente. Il brano che era già stato scartato per esempio dai Tremeloes (il gruppo che la Decca aveva preferito ai Beatles, probabilmente per una considerazione logistica: vivevano più vicino a Londra). Per Martin How Do You Do It avrebbe fatto il botto, i Beatles la odiavano. Il nonsense lievemente malizioso del testo non li intrigava. Come facciamo a tornare a Liverpool dopo aver inciso un brano così, pensava Paul. Avevano suonato pezzi anche più mielosi al provino della Decca, e altri ne avrebbero suonati di lì a poco, ma in quel preciso momento How Do You Do It sembrava davvero troppo teenpop per loro.
Alla fine, com’è noto, George Martin si lasciò convincere dai Beatles a incidere il loro materiale, e in particolare Please Please Me; una decisione che permise a Lennon e McCartney di diventare i compositori di sé stessi, cambiando la storia della musica leggera. Quel che è meno noto, è che prima di abbandonare How Do You Do It i Beatles fecero di tutto per farsela piacere. Non la rispedirono al mittente come bambini capricciosi; tentarono di trasformarla in qualcosa che potevano suonare senza perdere la dignità, aggiungendo le armonie vocali che Murray non aveva previsto, e soprattutto quell’accordo, spiazzante e riconoscibilissimo, che tutte le fonti definiscono un Re7 ma potrebbe già essere qualcosa di più dissonante, a interrompere la placida e banale progressione anni ’50 della strofa (“I’d do it to you. Re7!”). Lo senti già nell’introduzione ed è davvero il punctum di tutto il brano, quello che te lo fa riconoscere al primo colpo e che lo distingue da centinaia di altri brani quasi uguali. Murray quell’accordo nel demo non l’aveva previsto: ha tutta l’aria di una trovata di John, una virgoletta aperta a mezz’aria che trasforma tutta la canzone in una presa in giro di sé stessa. George Martin aveva visto giusto: How Do You Do It, scartata dai Beatles e affidata a Gerry and the Pacemakers sarebbe arrivata in cima alla classifica inglese dei singoli. Ma anche la versione dei Pacemakers riprende l’arrangiamento escogitato dai Beatles, con quel Re7 un po’ meno evidente ma ancora fondamentale. Solo i Beatles sapevano come fare le cose che sapevano fare.
219. Come and Get It (McCartney; incisa il 24/7/1969 durante le session di Abbey Road, ora in Anthology 3).
But you better hurry ‘cause it may not last. Io poi certe cose davvero non le capisco. Nel bel mezzo del terzo volume dell’Anthology, mi imbatto in questo pezzo di Paul che non si capisce cosa ci faccia lì. Non è brutto, no, ma non ha proprio l’aria di un pezzo dei Beatles, e perché poi? Non saprei, ma insomma non ha nulla di… non sembra nemmeno un inedito, ecco, gli inediti hanno sempre qualcosa di irregolare e questo invece sembra il compitino perfetto di un alunno che non eccelle in nulla, non posso credere che l’abbiano davvero suonato i Beatles ad Abbey Road mentre provavano cose folli come Here Comes The Sun o Come Together. Do un’occhiata a Lewisohn, dice che è il miglior inedito dei Beatles. Ma dai. Guardo sulla Beatles Bible, scopro che è un demo di Paul per un gruppo che stava producendo per la Apple, i Badfinger. I Beatles non l’hanno mai suonata; ha fatto tutto Paul in un’oretta mentre aspettava che arrivassero in studio. Doveva servire alla colonna sonora di un film in cui Ringo recitava a fianco di Peter Sellers. Fu un discreto successo, anche negli USA. Ah, vedi che avevo ragione. Non è un pezzo dei Beatles.
Ma poi nei commenti c’è un sacco di gente che viene a dire “Ma dai! La sentivo per radio nel ’70 ed ero convintissimo che fosse una canzone dei Beatles”. “Il mio ragazzo ne era sicuro, ci ho vinto una scommessa”. Allora, ecco, io forse davvero certe cose non le capisco. Io non l’avrei mai scambiato per un pezzo dei Beatles, neanche nella versione demo. Per un pezzo dei Wings magari, ma secondo me neanche Paul se lo immaginava suonato dai Beatles – lui che ai Beatles proponeva di tutto. È indicativo che nello stesso periodo in cui li faceva ammattire provando e riprovando Maxwell’s Silver Hammer, non abbia nemmeno provato a condividere questa canzoncina che in teoria è molto più facile. Non credo neanche che gliel’avrebbero silurata (non gli hanno silurato nemmeno Maxwell), anzi sono convinto che potendo scegliere tra Come and Get It e Maxwell, John e George avrebbero preferito quest’ultima. Ma non c’era niente da scegliere, Come and Get It era un simpatico compitino che Paul aveva deciso di far svolgere ai suoi neoassunti, con la raccomandazione di suonarlo esattamente uguale (l’unico tratto dissonante è il testo, un invito a venirsi a prendere i soldi finché ce ne sono ancora: un probabile riferimento alla sventata gestione della Apple Corps, ma recitato col sorriso a denti stretti di chi si cura l’ansia a benzodiazepine).
Ma insomma nessun rischio, nessuna invenzione, minima spesa massima resa, e quindi secondo me qui i Beatles non ci sono. Come and Get It è quel tipo di brano che dura poco più di due minuti ma è già inutile ascoltarlo dopo il primo; il motivetto nel frattempo ti si è ficcato in testa e non se ne andrà finché non ne ascolti uno più banale. Forse è un saggio di quel tipo di materiale che avrebbero inciso i Beatles nella prima metà dei ’70 se avessero deciso che i soldi erano più importanti che andare d’accordo.
218. All Things Must Pass (demo di George Harrison, incisa il 25/2/1969, in Anthology 3).

Music From the Big Pink, The Band, 1968.
Sunrise doesn’t last all morning. Dopo l’incidente in moto nel ’66 Dylan aveva deciso di ritirarsi un po’ in campagna e tenere impegnata la sua band incidendo demo in cantina. Di lì a poco la band sarebbe diventata la Band, con la maiuscola. Nel 1968 il loro primo disco avrebbe fatto scoprire al mondo un nuovo genere musicale: una terra di mezzo tra il country e il soul, da attraversare armati di pochi strumenti e con un religioso rispetto per i nativi. George Harrison nella primavera del 1968 aveva passato un po’ di tempo con Dylan e la Band, ed era tornato in Inghilterra entusiasta per quello stile rilassato che avevano acquisito suonando assieme senza darsi obiettivi o scadenze. Non litigavano su ogni arrangiamento, non imponevano le loro canzoni come prove di forza, non facevano scenate, non minacciavano di uscire dal gruppo, non si portavano le mogli. Suonavano, fumavano, scherzavano, e ognuno tranquillamente riusciva a dare il meglio di sé. In quei giorni Harrison stava riprendendo gusto a suonare la chitarra, al termine della lunga parentesi col sitar. All Things Must Pass è un brano ambizioso almeno quanto Within You Without You, ma è un ritorno senza rimpianti alla musica occidentale.
Non è che George si sia stancato della spiritualità, ma ha finalmente trovato un modo di esprimerla con la chitarra. È stato Dylan a sbloccarlo, e forse ancora di più Robbie Robertson. All Things non sarebbe esistita senza The Weight: George se l’immaginava cantata proprio da Levon Helm, la voce più soul e angelica della Band. La versione acustica contenuta in Anthology può indurci a pensare che si sia trattato del solito pezzo di George proposto e subito rifiutato, ma le cose non stanno esattamente così: i Beatles ci provarono, a suonare All Things Must Pass, nei primi giorni delle session di Get Back. Ma a Twickenham faceva freddo, John e Yoko si curavano la paranoia con l’eroina, Paul continuava a fare il boss, insomma e un bel giorno George si stancò e se ne tornò a casa. Fu una crisi passeggera, ma a quel punto All Things fu accantonata. Harrison si sarebbe preso la sua rivincita l’anno dopo, surclassando sia Lennon che Mccartney con le vendite del suo primo vero disco solista, battezzato appunto All Things Must Pass. Resta il rimpianto per quella che avrebbe potuto diventare non solo una delle migliori canzoni di Let It Be, ma l’inizio di una fase nuova. Inserito nella stessa scaletta di Across the Universe e The Long and Winding Road, avrebbe fatto parlare i critici di una nuova era dei Beatles, più matura e spirituale. Ma i Beatles non erano la Band, non lo sarebbero mai diventati (anche la Band non sarebbe durata così a lungo).
217. What A Shame Mary Jane (Lennon-McCartney; scarto di lavorazione di The Beatles (1968), ora in Anthology 3; originariamente attribuita anche ad Alex Mardas).
“Riascoltiamola, prima che ci portino via”, dice John alla fine del nastro. Che vergogna che Mary Jane è stata male alla festa… What A Shame Mary Jane è la canzone di Lennon (non dei Beatles) che assomiglia di più alle canzoni di Syd Barrett (non dei Pink Floyd). Il che ci pone alcuni problemi, perché Syd non poteva conoscere l’inedita What A Shame quando incideva i suoi dischi allucinati (’69-’70: What A Shame avrebbe potuto essere inclusa in entrambi), mentre John poteva al massimo avere ascoltato il suo disco coi Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, dove c’era già qualche canzone simile. Era anche impossibile che non lo conoscesse, dal momento che era stato registrato ad Abbey Road nello studio di fianco a quello in cui loro lavoravano a Sgt. Pepper. Certo, in quel periodo John era molto distratto, prendeva acidi anche senza accorgersene eccetera (è anche il periodo in cui secondo le testimonianze Syd Barrett cominciò ad assumere LSD in modo massiccio e a mostrare segnali di disagio mentale). Resta abbastanza impossibile che John non abbia ascoltato The Piper in un qualsiasi momento tra il 1967 e il 1968, quando i Pink Floyd suonavano regolarmente all’UFO di Londra e sembravano davvero la Prossima Cosa Grossa del rock. E allo stesso tempo non abbiamo prove di contatti fra i due, ed è abbastanza incredibile che John Lennon componga e cerchi di incidere una cosa che suona come un esplicito omaggio a un artista più giovane di lui. Non lo aveva mai fatto e non lo rifarà mai più (o forse con David Bowie). I riferimenti di Lennon sono quasi tutti compresi in uno spazio temporale che va dagli anni ’40 al Bob Dylan acustico: Syd Barrett che c’entra? Syd Barrett era un emulo di John, uno dei tanti che ha provato a diventare il nuovo Lennon ed è impazzito nel tentativo. È abbastanza ovvio che alcune canzoncine dei suoi dischi da solista suonino lennoniane; è bizzarro che succeda il contrario.
Una possibilità è che John sia arrivato a scrivere una canzone barrettiana per semplice convergenza evolutiva, ovvero (per tagliarla molto grossa) le strofe di nonsense montate su filastrocche sghembe sono quello che ti capita quando assumi acidi in modo continuativo. Lo stesso Barrett era entrato ad Abbey Road con composizioni da space-opera alla Astronomy Domine, e dopo un po’ se ne esce con cantilene alla Bike. Lennon però non scrive What A Shame in quel periodo, ma nel ’68 quando ormai le cattive allucinazioni lo avevano allontanato dall’LSD: il brano compare per la prima volta nei demo registrati a Esher all’inizio della lavorazione del Disco Bianco, e viene registrata nella versione che ascoltiamo su Anthology da John e Yoko con la collaborazione di George Harrison. What A Shame alla fine si inserisce molto bene sia nel mazzetto di canzoni-filastrocche autoparodiche che Lennon componeva in quel periodo (Cry Baby Cry, Bungalow Bill) sia nel filone delle sperimentazioni sonore (Revolution 9, Unfinished Music). Non è neanche la peggiore del genere, soprattutto se vi piace Barrett e a me da giovane piaceva un sacco, li trovavo divertenti tutti quei patenti sintomi di disagio. Adesso invece lo evito, forse la maturità è quando cominci ad avere paura dei matti. Sul Disco Bianco What A Shame sarebbe stata un numero più godibile di Revolution 9: poco più di un divertimento, ma abbastanza efficace nel creare un’atmosfera. Gli effetti sonori non sono invecchiati male e sono probabilmente da considerare il più grande conseguimento artistico di quel ciarlatano di “Magic” Alex Mardas (tranquilli, si può scrivere che era un ciarlatano. Quando lo scrisse il New York Times e Mardas provò a obiettare, il NYT produsse le prove e Mardas rispose che tutto sommato “ciarlatano” poteva accettarlo). (Invece “truffatore” non va bene, e quindi mi sforzerò di non chiamare Magic Alex “truffatore”). (Si vede, che mi sto sforzando?)
216. Leave My Kitten Alone (Little Willie John, James ‘Jay’ McDougal e Titus Turner; scarto di lavorazione di Beatles For Sale, agosto 1964, ora in Anthology).
That girl is gonna miss you, You gonna wish that you were dead. Nell’estate del 1964 i Beatles stanno picchiando il ferro finché è incandescente, forse ancora convinti che la Beatlemania possa finire da un momento all’altro. Quando non fanno concerti, sono ad Abbey Road a registrare il disco che deve essere nelle case di tutti i beatlemaniaci inglesi e americani entro Natale; quando non sanno cosa registrare (hanno finito le canzoni!) suonano vecchi rock’n’roll che si dimenticheranno in un cassetto o in mancanza di meglio includeranno nel disco che uscirà in dicembre, appunto, intitolato con molta onestà Beatles For Sale. Questa Leave My Kitten Alone è appunto un vecchio pezzo di tal Little Willie John, un inno alla gelosia maschile (“Lascia stare la mia micina!”) che Lennon canta con un afflato quasi omicida – la gelosia è davvero la musa di John. Ora come sempre dobbiamo lamentarci del fatto che un brano del genere sia così in basso nella classifica, visto che è molto meglio di altri pezzi che i Beatles hanno deciso di incidere, e specificatamente molto meglio di altre cover che furono incluse in Beatles For Sale. Forse davvero se la dimenticarono in un cassetto. Oppure era troppo violenta per l’immagine che i Quattro si erano ormai costruiti (ma John aveva già inciso You Can’t Do That). Oppure serviva un assolo di chitarra che reggesse la foga del cantato, e George quella sera davvero non l’aveva. Avrebbe dovuto lavorarci, ma abbiamo già visto che a volte George si piantava. Oppure.
Oppure in ottobre, mentre i lavori per Beatles For Sale continuavano, una band inglese abbastanza sconosciuta pubblicò la sua versione di Leave My Kitten Alone e non sarebbe stato un problema, davvero, in quegli anni tutti pubblicavano i r’n’r di tutti, ma quella versione aveva qualcosa di particolare: un assolo folle, rumorista e virtuosistico insieme, elargito da un giovanissimo session man che si chiamava Jimmy Page. E a quel punto forse i Beatles decisero di non toccare più la micina: qualcun altro l’aveva reclamata, a buon diritto.
215. Christmas Time (Is Here Again) (Lennon-McCartney-Harrison-Starkey; flexi-disc allegato alla rivista del Beatles Fans Club, e nel 1998 sul lato B di Free As A Bird.
A proposito di Natale: è davvero strano che i Beatles non abbiano mai realizzato una canzone natalizia. John ne ha scritta una, Paul un’altra, e non passa un Natale senza che le ascoltiamo entrambe: ma i Beatles niente. Hanno scritto canzoni di compleanno e ninne nanne e filastrocche dell’abc, e insomma tutto quello che ci si aspetta da compositori realmente popolari, tranne la cosa più popolare di tutte Eppure tutti i Natali erano nelle vetrine dei negozi con un disco nuovo, e dopo il 1970 con una nuova ristampa o una nuova antologia. Ma soprattutto, i Beatles sanno di Natale: di zenzero, di cannella, di voglia di restare a casa e di farsi stare simpatici anche i parenti anziani. Cosa c’è più apparentemente universale dei Beatles (e del Natale), anche se a ben vedere è un patchwork postmoderno di tradizioni europee e marketing americano (il Natale) (ma anche i Beatles)? In un certo senso non ne avevano bisogno, i Beatles erano il Natale. Eppure le ‘cose’ più natalizie che hanno inciso sono i 45 giri che arrivavano per posta ai membri del fans club, in cui salutavano, si scusavano di non riuscire a rispondere a tutte le lettere, auguravano buone feste e allungavano il brodo con minuti di buffonate non sempre comprensibili. Non ha senso considerarli veri e propri dischi: in un mondo analogico assolvevano alla stessa funzione che oggi hanno le stories su Instagram. Il più divertente forse è il messaggio del 1965, che si trasforma in una parodia di Yesterday; l’unico che somigli a una vera e propria canzone è quello del 1967, Christmas Time (Is Here Again), e sinceramente non sembra così natalizio. Su un rigidissimo giro di blues i Quattro cantano all’unisono che Natale È Di Nuovo Qui, senza mai cambiare nota: malgrado le buffonate di contorno (demandate per lo più a Ringo), l’effetto dopo un paio di minuti è ipnotico, dopo un altro paio frastornante, proprio come il Natale degli adulti, inesorabile e pieno di incombenze. Si capisce che nell’aria c’è ancora quell’idea di comporre canzoni come raga indiani, canzoni su una sola nota, canzoni infinite e non finite, un’idea che dopo tanti esperimenti nell’anno a venire avrebbe fruttato Hey Jude. Si capisce anche che non avevano più di tanto voglia di scriverla, questa benedetta canzone di Natale, e che sapevano che i fans comunque avrebbero perdonato tutto (nel 1967 poi). Christmas Time riuscì a essere scartato da qualsiasi antologia ufficiale fino al 1995, quando dopo un quarto di secolo i Beatles decisero di tornare nelle vetrine natalizie con un singolo inedito, Free As A Bird. Una versione accorciata di Christmas Time ne divenne il lato B, forse per aggiungere quell’aria natalizia a un’operazione un po’ inquietante. Un tocco di zenzero, appunto, salvo che il mantra di Christmas Time ha ben poco di zenzero. È Di Nuovo Natale, È Di Nuovo Natale, È Di Nuovo Natale, cantano all’unisono, e sembrano manichini imbalsamati. È Di Nuovo Natale, quindi eccoci qua. Siamo qua, quindi È Di Nuovo Natale. Sarà sempre così, anche quando saremo morti. Uno di noi è già morto, ma È Di Nuovo Natale, quindi eccolo qua.