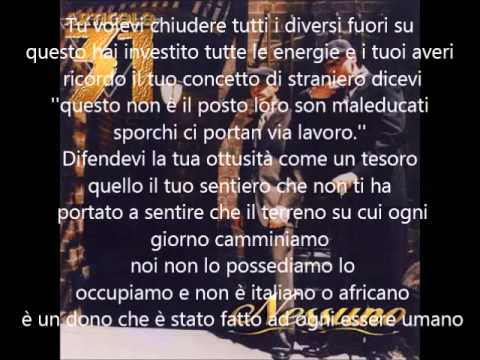Dylan ama, Dylan ruba
“Love and Theft” (2001)
(Il disco precedente: Time Out of Mind
Il disco successivo: Modern Times)
Questi cosiddetti esperti della musica di Bob Dylan… Non credo che ne sappiano nulla, che abbiano la minima idea di chi sono e cosa rappresento. Lo so che credono di avercela, il che è ridicolo, esilarante e triste. Il fatto che gente del genere abbia passato così tanto tempo pensando… a chi? A me? Fatevi una vita, per favore. Nessuno dovrebbe pensare così tanto a qualcun altro. Non state onorando la vostra vita. La state buttando via (Dylan nel 2001 al Times, a proposito di me).
 Il nuovo secolo avrebbe dovuto portarci i telefonini coi tasti più piccoli, Berlusconi di nuovo a palazzo Chigi, e un brutto disco di Dylan. I segni nell’aria c’erano tutti: la gente aveva davvero bisogno di più tasti sui telefoni. Tutti non facevano che messaggiarsi, passavano il tempo a premere anche tre volte un tasto per trovare la lettera giusta (nessuno si fidava del t9, ammesso ci fosse già). Quando non venivano investiti agli incroci erano loro stessi a investire qualcuno, era un’emergenza sociale, i giornalisti erano preoccupatissimi. Quanto a Berlusconi, beh, il suo principale contendente era Rutelli. La vittoria del Polo della Libertà era data per inevitabile, e anche Dylan probabilmente stava per uscire con un brutto disco. Anche solo per una questione di statistica. Berlusconi vince un’elezione su due, Dylan ha mai fatto tre dischi belli di fila? Il dylanita alla soglia del 21esimo secolo ormai lo sapeva: ogni capolavoro ha un suo prezzo. Se il prezzo di Oh Mercy era stato Under the Red Sky, cosa potevamo aspettarci dopo Time Out of Mind?
Il nuovo secolo avrebbe dovuto portarci i telefonini coi tasti più piccoli, Berlusconi di nuovo a palazzo Chigi, e un brutto disco di Dylan. I segni nell’aria c’erano tutti: la gente aveva davvero bisogno di più tasti sui telefoni. Tutti non facevano che messaggiarsi, passavano il tempo a premere anche tre volte un tasto per trovare la lettera giusta (nessuno si fidava del t9, ammesso ci fosse già). Quando non venivano investiti agli incroci erano loro stessi a investire qualcuno, era un’emergenza sociale, i giornalisti erano preoccupatissimi. Quanto a Berlusconi, beh, il suo principale contendente era Rutelli. La vittoria del Polo della Libertà era data per inevitabile, e anche Dylan probabilmente stava per uscire con un brutto disco. Anche solo per una questione di statistica. Berlusconi vince un’elezione su due, Dylan ha mai fatto tre dischi belli di fila? Il dylanita alla soglia del 21esimo secolo ormai lo sapeva: ogni capolavoro ha un suo prezzo. Se il prezzo di Oh Mercy era stato Under the Red Sky, cosa potevamo aspettarci dopo Time Out of Mind?
Aggiungi questa circostanza inquietante: non si trovava più nessuno in giro disposto a parlare male di Bob Dylan. Time Out, col suo Grammy per il Miglior Disco, aveva segnato il discrimine da “solito stronzo” a “venerato maestro”. Improvvisamente stava simpatico a tutti. Quando Curtis Hanson, il regista di LA Confidential, gli chiede una canzone per il suo nuovo film, Dylan non si fa pregare e offre un brano pregevole, Things Have Changed, in cui gioca col suo personaggio con una disinvoltura inedita per lui (se il ritornello è davvero un disincantato riferimento a The Times They Are-A Changin’):
La gente è matta, i tempi son strani,
io sto fuori dal giro, ho legate le mani:
una volta mi sarei preoccupato,
ma è tutto cambiato.
Con Things Have Changed Bob Dylan vince l’Oscar per la miglior canzone. Se lo meritava? In lizza c’era anche Björk, era l’anno di Dancer in the Dark. Può anche darsi che il 2000 non avesse niente di meglio da offrire, ma fa un certo effetto pensare che i giurati dell’Academy trent’anni prima non avessero notato Knockin’ on Heaven’s Door – non dico una statuetta, ma almeno una nomination. È che nel 2000 Dylan, senza sforzo apparente, è diventato molto più premiabile. Ormai è un’icona al di sopra delle polemiche: sfoggiarlo in salotto fa fine e non impegna. A questo punto servirebbe proprio un disco brutto – anzi no, qualcosa di peggio. Qualcosa che, nelle mani di Dylan, fosse una garanzia di disastro: un film.
E infatti ecco il film – anche a questo il dylanita è ormai rassegnato: quando le cose cominciano ad andare troppo bene, di solito Dylan fa un passo più lungo della gamba che spesso si traduce in un film (o un aborto di). Ai tempi di Blonde on Blonde stava cercando di montare Eat the Document (non c’è mai riuscito); la Rolling Thunder Revue terminò col botto di Renaldo and Clara; il primo millennio di Dylan termina con Masked And Anonymous, un film scritto da Dylan in collaborazione con Larry Charles, al suo debutto dietro la macchina da presa. Charles era uno degli autori di Seinfeld: in seguito avrebbe firmato i film di Sacha Baron Cohen. Masked non è purtroppo il film divertente che avremmo potuto aspettarci da lui. Si capisce che Dylan ci ha lavorato davvero – ogni personaggio, più che dialogare, sembra intonare un monologo, attaccare una strofa. Qualsiasi tentativo di alleggerire i contenuti è demandato ai membri dell’incredibile cast: Jeff Bridges (Dylan lo minaccia spaccando una bottiglia di Jack Daniels), Penelope Cruz, John Goodman (sempre il migliore), Jessica Lange, Luke Wilson, Val Kilmer (a un certo punto si dimentica la parte ma Charles continua a girare), Chris Penn, Mickey Rourke, Christian Slater, e ne ho senz’altro dimenticati. Tutta gente che recita al minimo sindacale o quasi, per la gloria di stare sul set col grande Bob Dylan. Quindici anni prima sarebbe stato impensabile. Quel che ricordo meglio di Masked è l’ambientazione caotica, un set che sembra ricavato all’ultimo momento nella periferia di una guerra civile. Se non siamo nel Terzo Mondo, stiamo per entrarci. Bob Dylan è Jack Fate, un burbero cantautore che un tempo era un mito (sì, lo stesso personaggio di Hearts of Fire) che si ritrova senza sapere bene perché sul palco di un equivoco concerto di beneficenza (“Se vuoi far venire un cantante, gli devi dare una Causa o un Premio”, dice l’impresaria Jessica Lange). La storia è un pretesto per contemplare un mondo devastato e dispensare qualche massima di saggezza; c’è anche il tempo per cantare un paio di canzoni con la sua band, ma la maggior parte della colonna sonora è composta da cover dei suoi brani anche in lingue straniere, tra cui una memorabile My Back Pages in giapponese, mentre il contingente dylanita italiano è rappresentato da ben due brani. Uno è di De Gregori, e non sorprende, l’altro è Come una pietra scalciata degli Articolo 31, e sorprende eccome.
Il Dylan dei primi Duemila, tra Things Have Changed e Masked And Anonymous, sembra ormai vivere in una bolla autoreferenziale: tutti gli vogliono bene purché lui continui a interpretare sé stesso, e per una volta lui sembra non volerli deludere. Con Masked si cristallizza anche l’immagine del “vecchio Dylan”, che sul set del video di Things si aggirava ancora un po’ smarrito mentre ora sembra disegnato a tavolino da un team di stylist molto attenti a valorizzare il brand: il cappello Stanton e i baffetti sottili devono diventare rapidamente dettagli iconici, come la bombetta e il baffo di Chaplin. È lo stesso Dylan che ci guarda intenso dalla copertina del nuovo disco (ancora un bianco e nero vintage) che compare finalmente nei negozi nel giorno meno adatto al mondo, l’undici settembre 2001. Immaginatevi i crocchi di gente nei multistore che guardano le Twin Towers crollare in diretta sui primi maxischermi piatti. I dylaniti aggirano la folla, sovrappensiero: devono comprare il nuovo cd, e chissà che ciofeca sarà. Stavolta non c’è scampo – ormai son più di dieci anni che non fa un disco davvero brutto, stavolta dev’essere la volta. Per dire, chi è il produttore? Jack Frost? Jack chi?
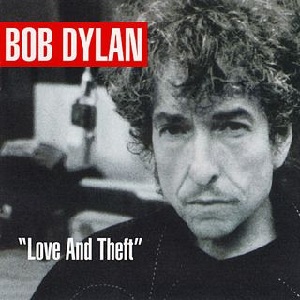
Jack Frost, nel folklore anglosassone, è una specie di folletto della brina, l’entità invernale che disegna cristalli alle finestre. Dylan ha già cominciato a usare questo pseudonimo negli anni Ottanta, ogni qualvolta si è assunto l’onere di produttore – mai da solo però. Bob Dylan, si sa, non è capace di prodursi da solo. A malapena riesce a riascoltarsi. Bob Dylan, meno tempo passa in sala di registrazione, meglio è. Bob Dylan ha bisogno di qualcuno che lo segua passo passo. Bob Dylan è il peggior critico di sé stesso: un disco prodotto da Dylan/Frost non può che essere una catastrofe. E ora che lo sappiamo, coraggio, ascoltiamo “Love and Theft”.
E scopriamo che è uno dei più bei dischi di Bob Dylan.
(Non sto scherzando stavolta).
Tweedle-dee Dum and Tweedle-dee Dee,
they’re throwing knives into the tree.
Two big bags of dead man’s bones,
got their noses to the grindstones…
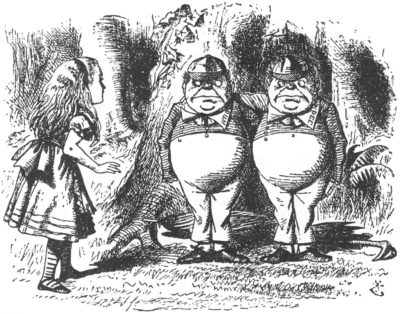
Tweedle Dum e Tweedle Dee.
Magari non si capisce subito – non è neanche la prima volta che un buon disco di Dylan parte un po’ sottotono. Tweedle Dee and Tweedle Dum, un apparente nonsense sui due gemelli delle filastrocche, che potrebbero essere accattoni o industriali, è la versione adulta di Subterranean Homesick Blues (la linea del basso è la stessa, ma adesso Dylan ha imparato ad andare a tempo). Se non altro è il ritorno a un quattro quarti più svelto, tanto più gradito se si ascolta immediatamente dopo l’ultima mezz’ora di Time Out of Mind. Lo stesso Dylan aveva ammesso che il disco precedente era a corto di canzoni ritmate. Questa è già una notizia promettente: invece di addormentarsi sugli allori dopo un disco tanto celebrato, Dylan si sta rimettendo in discussione. Nessuno glielo chiedeva. Al ritmo più che ragionevole di un disco ogni cinque anni, tutti si sarebbero accontentati di un Time Out volume due; Dylan invece in Time Out trovava ancora errori da correggere. Se ai tempi di Oh Mercy aveva dato l’impressione di essere stato usato da Lanois, un veicolo di lusso per reclamizzare il sound che era il suo marchio di fabbrica, con Time Out i ruoli sembrano essersi invertiti: Dylan era tornato da Lanois per imparare qualcosa, anche dai suoi errori. Ma è possibile che alla sua età possa improvvisamente imparare come si produce un disco, dopo 40 anni di disavventure e incomprensioni? Sono quei miracoli che a una certa età non ti aspetti più, e se segui Dylan quell’età probabilmente ce l’hai. Eppure…
Stick with me baby, stick with me anyhow
Things should start to get interestin’ right about now.
Mississippi, il secondo brano, è l’ennesimo caso in cui Dylan e Lanois non si erano trovati: un pezzo che ai tempi di Time Out il secondo aveva cercato di affogare nel suo “calderone vudù” (così almeno ce la racconta Dylan) mentre quest’ultimo cercava un tono più solare e diretto. C’è chi lo considera il vertice del disco, e non c’è dubbio che contribuisca in maniera determinante a fissarne il mood (un cauto ottimismo individuale che fiorisce dalle rovine di una catastrofe; la sensazione che chi canta abbia finalmente fatto la pace con sé stesso). Allo stesso tempo, Mississippi non è davvero un brano di “Love and Theft“, tra i quali spunta come il mattone sporgente in una struttura fin troppo compatta. Credo che stia tra She’s Your Lover Now, Forever Young e Caribbean Wind nella lista delle grandi incompiute di Dylan, quelle canzoni che nella sua testa suonavano molto meglio di come è riuscito a registrarle. L’arrangiamento non ha nulla che distragga dall’esecuzione, ma è comunque qualcosa che si mette tra l’idea e il risultato. È l’unico caso del disco in cui Jack Frost sembra in difficoltà. In tutti gli altri brani non avviene: quella tipica difficoltà di Dylan nell’ottenere quel che vuole in studio sembra completamente superata. Non tutte le canzoni sono all’altezza di Mississippi, anzi forse nessuna: ma sembrano tutte felicemente risolte, contente di essere incise nel modo in cui Frost le ha incise.
Summer Days, per esempio, è una cavalcata blues che ci porta ancor più lontano dalle lagne rancorose di Time Out: è un Dylan completamente diverso, un quasi-sessantenne che ostenta la sua voglia di divertirsi (“I know a place where there’s still somethin’ going on”), che gioca con la metrica come non gli riusciva da anni:
She’s looking into my eyes, she’s holding my hand
She’s looking into my eyes, she’s holding my hand
She says, “You can’t repeat the past.” I say, “You can’t? What do you mean, you can’t? Of course you can.”
(Il terzo verso non è importante soltanto per quel che dice, ma per il modo in cui Dylan riesce a infilare 21 sillabe dove ce ne dovrebbero stare la metà. È un piccolo atto performativo: forse davvero il tempo si può riavvitare, o al limite bloccare, una sillaba alla volta).
Fin qui “Love and Theft” potrebbe essere semplicemente il fratellino allegro di Times Out of Mind – e sarebbe già una buona notizia, se Dylan è davvero riuscito a non abbassare troppo lo standard e a riprendere un po’ di ritmo. La vera sorpresa arriva soltanto col quarto brano, Bye and Bye: quando ormai siamo rassegnati all’ennesimo disco di blues e ballate, magari meno lente del solito, all’improvviso sentiamo un accordo diminuito. Qualcosa che Dylan non usa da vent’anni, ammesso che ne abbia mai usati (va’ a capire certi accordi di Blood on the Tracks). Senza preavvisi, ci ritroviamo di fronte a un nuovo Bob Dylan. Alle soglie di sessant’anni, il nonno ha imparato il jazz. È uno scherzo?
Bye and bye, I’m breathin’ a lover’s sigh
I’m sittin’ on my watch so I can be on time
 È una scelta tutt’altro che illogica, soprattutto se si riflette sul timbro di Dylan, che nei primi brani è particolarmente cavernoso (non mi stupirei se fossero stati incisi in ordine cronologico: man mano che si va avanti il timbro si schiarisce). È un timbro adatto per swingare. Certo, non siamo più nel 1962; non è più concesso a un cantante bianco di affettare un timbro rauco per suonare come un nero. È una pratica da minstrel show, quegli spettacoli itineranti di cent’anni prima, recitati da attori e cantanti bianchi con la faccia dipinta. Pochi anni prima uno studioso americano, Eric Lott, ne aveva spiegato l’importanza in un libro intitolato Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class. È dal libro di Lott che Dylan probabilmente ha preso il titolo del disco – le virgolette potrebbero essere un modo molto discreto di far notare la citazione, o una precauzione suggerita da un avvocato. Lott ovviamente si disse onorato. Dylan non ha mai ammesso di aver letto il libro, e forse voleva solo ribadire il punto: sì, io sono un ladro di cultura. A vent’anni rubavo il blues a Robert Johnson, a trentadue copiavo il reggae a Bob Marley, a quaranta pregavo il Dio dei gospel e mi scopavo le coriste, e ora che ho una voce roca alla Louis Armstrong non avrò nessuna paura a usarla. In guerra e in amore tutto è permesso. Va bene, signor Dylan. Ormai fa blues da quarant’anni, la cosa non scandalizza nessuno.
È una scelta tutt’altro che illogica, soprattutto se si riflette sul timbro di Dylan, che nei primi brani è particolarmente cavernoso (non mi stupirei se fossero stati incisi in ordine cronologico: man mano che si va avanti il timbro si schiarisce). È un timbro adatto per swingare. Certo, non siamo più nel 1962; non è più concesso a un cantante bianco di affettare un timbro rauco per suonare come un nero. È una pratica da minstrel show, quegli spettacoli itineranti di cent’anni prima, recitati da attori e cantanti bianchi con la faccia dipinta. Pochi anni prima uno studioso americano, Eric Lott, ne aveva spiegato l’importanza in un libro intitolato Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class. È dal libro di Lott che Dylan probabilmente ha preso il titolo del disco – le virgolette potrebbero essere un modo molto discreto di far notare la citazione, o una precauzione suggerita da un avvocato. Lott ovviamente si disse onorato. Dylan non ha mai ammesso di aver letto il libro, e forse voleva solo ribadire il punto: sì, io sono un ladro di cultura. A vent’anni rubavo il blues a Robert Johnson, a trentadue copiavo il reggae a Bob Marley, a quaranta pregavo il Dio dei gospel e mi scopavo le coriste, e ora che ho una voce roca alla Louis Armstrong non avrò nessuna paura a usarla. In guerra e in amore tutto è permesso. Va bene, signor Dylan. Ormai fa blues da quarant’anni, la cosa non scandalizza nessuno.
Romeo, he said to Juliet, “You got a poor complexion
It doesn’t give your appearance a very youthful touch”
Juliet said back to Romeo, “Why don’t you just shove off
If it bothers you so much”
Ma il jazz, quello bisogna saperlo fare, via. Non è una cosa che si impara all’ultimo momento. A quasi sessant’anni, poi. “Certe cose è troppo tardi per impararle“, se lo ricorda? Anche solo gli accordi in diminuita, alla sua età, con tutta la mobilità manuale che richiedono… Si rimetta da bravo a suonare i blues, come Lonesome Day, ecco, perfetto (no, sul serio, Lonesome Day è un rock-blues perfetto). Alla sua età non vale la pena di rimettersi in gioco, e per chi poi? Fino a quel momento l’unico vago tentativo di costeggiare il jazz in quarant’anni di carriera era stato If Dogs Run Free, quel bozzetto estemporaneo di New Morning con la corista che faceva scat in sottofondo. Una di quelle cose che fai quando le stai provando tutte. Col senno del poi, sembrava un proto-Tom Waits, forse qualcuno avrebbe dovuto dirgli di insistere. Ma insomma lo swing uno ce l’ha o non ce l’ha, e se ce l’ha non lo può tenere nascosto per trent’anni – è inconcepibile. Ma quando parte Floater, con quell’intermezzo di violino, devi accettare che è proprio così: Dylan nel 2000 ha lo swing. In quegli accordi diminuiti, in quei quattro quarti scanditi coi rastrelli, si muove comodo come in un vecchio pigiama. Sembra aver passato mezza vita in un’orchestra di New Orleans, sembra che tutto quello che sfoggia sia roba sua da sempre. È la migliore sorpresa che ci ha fatto dai tempi in cui attaccò la spina per suonare Subterranean. Proprio quando ci eravamo rassegnati a vederlo invecchiare nel blues – un ottimo blues, eh, ma un po’ ossessivo – Dylan a swingheggiare come non avesse fatto altro nella vita (e dopo la sorpresa subentra l’incazzatura: perché hai fatto altro nella vita?)
A questo punto siamo a metà disco e forse cominciamo a capire la struttura disegnata da Jack Frost, semplice ma efficace: un pezzo veloce (di solito un blues) e uno lento (di solito uno swing). Dopo Floater tocca a High Water, che non è propriamente un jazz ma è dedicata a un grande bluesman del Delta scomparso negli anni Trenta, Charlie Patton. Se lo strumento che colorava il brano precedente era il violino, qui c’è il banjo che da Un tranquillo week-end di paura in poi è diventato uno strumento inquietante. Dylan sente “l’acqua alta dappertutto”, e non sai se sta raccontando la grande alluvione del 1927 o il diluvio prossimo venturo. A questo punto ti aspetti per contrasto un altro swing soffice, e infatti arriva Moonlight, un brano che sotto il suo romanticismo di maniera nasconde il romanticismo autentico – a una certa età forse è l’unico modo per farlo passare, i bigliettini devono essere elaborati, le rime non banali, non basta dire “fiori”, serve il lessico tecnico (“Orchids, poppies, black-eyed Susan”). Ora tocca al blues e si riparte con Honest With Me, lo strumento in evidenza stavolta è la slide guitar, ma in sottofondo si sente una band affiatatissima che si conosce a memoria. Questo accomuna “Love and Theft” a uno dei dischi meno ascoltati di Dylan – un dei pochi registrati con gli stessi musicisti che in quel momento erano in tour con lui, Saved. Non è mai stato chiaro il perché Dylan sentisse il bisogno di lavorare in studio con strumentisti diversi da quelli che usava nei concerti – è una cosa che si porta dietro sin da Blonde On Blonde, e che forse era un modo istintivo per evitare che musicisti più tecnici di lui prendessero il sopravvento. Ma a questo punto della sua esistenza Dylan vive in tour: i suoi uomini sono un’estensione delle sue dita. Anche quando si prendono delle libertà, non fanno nulla che Dylan non approverebbe. Ma è l’ora dello swing: parte Po’ Boy.
Othello told Desdemona, “I’m cold, cover me with a blanket
By the way, what happened to that poison wine?”
She says, “I gave it to you, you drank it”
Poor boy, layin’ ‘em straight pickin’ up the cherries fallin’ off the plate
Cominciamo a far caso al fatto che anche gli swing di Dylan seguono una formula più complessa ma non meno fissa dei blues: sembrano tutte variazioni sullo stesso giro armonico. Ma sai che c’è? Che anche se si assomigliano un po’, Floater, Moonlight e Po’ Boy sono dei pezzi straordinari – basta non ascoltarli uno dopo l’altro, e Jack Frost si è premurato che non accadesse. Po’ Boy è forse anche il vertice lirico dell’album: anche in questo caso ogni strofa è un bozzetto a sé, che combinato con le altre forse racconta una storia o forse no. I bozzetti di Po’ Boy sono i più divertenti.
My mother was a daughter of a wealthy farmer
My father was a traveling salesman, I never met him
Anche qui Dylan dedica almeno una strofa a parlare dei suoi genitori – e nessun racconto sembra coincidere con gli altri, né con la realtà (per esempio in Floater: “My old man, he’s like some feudal lord, got more lives than a cat; I never seen him quarrel with my mother even once”. O in Bye and Bye: “Papa gone mad, mamma, she’s feeling sad”). Sono tutte radici immaginarie che Dylan ha appena finito di piantare nel suolo – è un ladro di passato, un finto nero, un impostore, embè? L’amore è furto. Cry a While ci ricorda che un tempo lo stesso Dylan non sapeva andare a tempo – ora è impossibile, ora ha demandato il suo senso del ritmo a dei professionisti che non sgarrano – eppure, ugualmente, chi potrebbe mai arrangiare una canzone come Cry a While, con la strofa in 2/4 in levare (quasi uno ska spiaggiato in Louisiana) con un ritornello in 4/4? Magari per tutti questi anni Dylan soffriva perché non riusciva a spiegare ai suoi produttori che voleva una cosa del genere (e in effetti, mettetevi in Knopfler/Baker/Lanois: che senso ha una cosa del genere?) Il testo ha ripreso quel tono sbruffone che sembrava essersi dileguato ai tempi di Blonde On Blonde, e serve anche a introdurre il tema finale del disco: io ho sofferto abbastanza; adesso soffri tu, che è ora. L’ultimo brano, Sugar Baby, non fa che ribadire l’argomento, ma su una musica completamente diversa: una melodia ariosa e intima assieme, che se ricorda qualcosa ricorda certe accordature aperte di Blood on the Tracks. Non c’è più niente da ridere, ma la morale è la stessa: sei tu che devi fare a meno di me, adesso.
Zucherino vai per la tua strada
non hai testa, non c’è verso.
Per così tanto tempo hai fatto a meno di me
tanto vale abituarsi.
…che è l’esatto contrario di quel che Dylan ha dimostrato con “Love and Theft”, ovvero che non è mai troppo tardi per imparare qualcosa. Non è troppo tardi per lui, almeno. Lui, quando una tradizione comincia ad andargli stretto, se ne inventa un altra. Ora, non posso dire che sia il suo disco migliore. Alcuni lo trovano inferiore al precedente e beh, è una questione di gusti, di affinità, insomma Time Out mi addormenta e “Love…” mi dà la sveglia. Ma il vero motivo per cui voglio bene a questo disco è che ormai ho passato quella fatidica boa dei quaranta dopo la quale, ogni volta che scopri che esiste qualcosa di nuovo, ti domandi se vale anche solo la pena di perderci tempo per impararla, e la risposta è probabilmente no. “You ain’t got no brains, no how. You went years without me, might as well keep going now”. Meglio concentrarsi sulle poche cose che so fare – a proposito, che cosa so fare? Non un granché? vabbe’, alla mia età se hai imparato a suonare solo otto accordi devi accettare l’idea che il numero di canzoni che puoi suonarci è finito. Ormai è andata così. Anche se.
Anche se Bob Dylan a sessant’anni si è messo a suonare il jazz.
Lo so che è puerile, ma è una cosa che mi riempie di speranza. Se può farcela lui; se dopo tutti i disastri degli anni Ottanta può mettersi a registrare i dischi da solo e farne di ottimi, beh, significa che c’è qualche margine ancora per me, per te, per tutti. Tra i motivi che ho oggi per ringraziare Dylan, forse è il più importante.
(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”, 2006: Modern Times, 2008: Tell Tale Signs…)