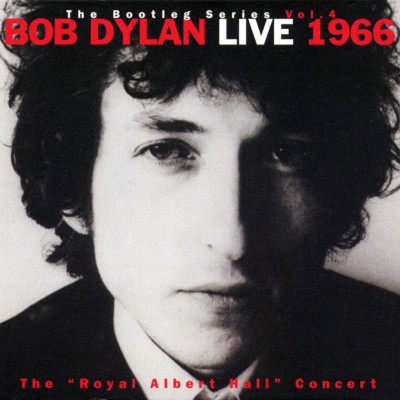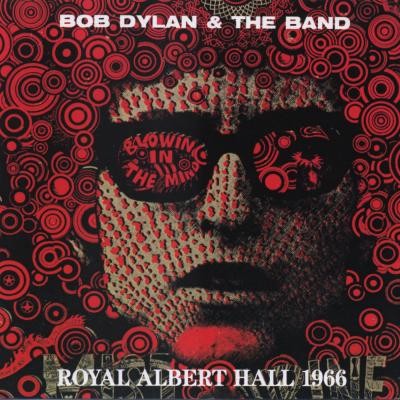L’uomo che urlò “Giuda” a Dylan, forse
Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert” (The Bootleg Series, vol. 4, 1998).
The Real Royal Albert Hall 1966 Concert (2016)
(L’album precedente: Blonde On Blonde.
Il successivo: The Basement Tapes)
Sì, ti vedo sul davanzale della tua finestra, ma non saprei dire quanto tu sia lontana dall’orlo. E comunque, farai solo urlare e saltare un sacco di gente – perché vuoi fare una cosa del genere? Tanto lo so che lo sai che lo so che lo sai che qualcosa ti sta bruciando in testa… dimmi mamma, che cos’è? cosa c’è che non va stavolta? (Tell me, momma).
In un altro universo l’estate dell’anno scorso è stata l’occasione per celebrare la tragica scomparsa di Bob Dylan, il geniale cantautore americano che in poco più di quattro anni si impose come il portavoce della sua generazione prima di sfracellarsi in moto, sul Glasco Turnpike, il 29 luglio del 1966. Il coro dei commossi colleghi superstiti (Joni Mitchell, Joan Baez, Phil Ochs, Neil Young) è stato una volta in più interrotto dalla vecchia linguaccia di John Lennon: Ok, (ha detto, più o meno), era un grande, era persino mio amico, però sarebbe bello se la gente lo ricordasse ascoltandone le canzoni, invece di raccontare le solite storielle – avvistamenti nel Village, era lui! – o rifriggere teorie del complotto. C’è ancora chi dà la caccia agli oltranzisti folk, chi cerca di inchiodarli agli indizi. Confessa! Eri tu che lo fischiavi a Londra, anzi no era Manchester, eri tu che lo chiamavi Giuda, ammettilo! Sei tu che gli hai manomesso la moto! Come se la gente andasse davvero in giro ad ammazzare i cantanti che la deludono. E non è neanche stato Grossman, di certo un figlio di puttana come tanti altri manager: no, non lo mise sotto perché aveva paura che Bob si accorgesse di aver firmato contratti discutibili. Non fu nemmeno la moglie ad avvelenarlo, lo volete sapere davvero perché è morto? Perché guidava di merda, da ragazzino era il terrore di Hibbing Minnesota, una volta aveva quasi ruotato un bambino. E poi, insomma, in quel periodo era continuamente fatto, io me lo ricordo bene. Era un genio, mi fa impazzire pensare a che canzoni avrebbe potuto scrivere dopo Blonde On Blonde, magari avrebbe eclissato pure noi Beatles, non scherzo… ma ogni volta che raccontate di qualche complotto massone-giudaico-folk me lo uccidete per la seconda volta. Tutta quella paranoia che mi è venuta qualche anno dopo – lo sapete, non sono uscito di casa per quindici anni, cazzo – è colpa vostra: prima avete perso Gesù, poi ne avete sentito la mancanza e avete cominciato a cercarlo in noi musicisti. Allora ho una notizia per voi (stronzi): noi non resuscitiamo.
Un mese dopo l’Accademia di Svezia ha dichiarato che intendeva insignire del premio Nobel per la letteratura Leonard Cohen. Nel suo discorso – che non ha fatto in tempo a pronunciare, è morto in novembre anche in quell’universo – Cohen ha citato, tra i suoi ispiratori, anche Dylan: senza di lui sarei rimasto un romanziere qualsiasi, ha spiegato. È stato lui a convincermi che potevo usare una chitarra.
In quell’universo, Dylan è più famoso che nel nostro, anche se non ha mai scritto Knocking on Heavens Door, né Forever Young, né Tangled Up in Blue, né Hurricane. È il primo morto illustre del rock anni ’60 – tre anni in anticipo su Brian Jones. Il primo a mostrare che il gioco si stava facendo difficile, quando ancora molti credevano che si trattasse soltanto di una cosa da ragazzi, pace amore e capelli lunghi. Quel che più affascina gli ascoltatori di ogni età è la consapevolezza con cui Dylan aveva abbracciato il suo destino, corteggiando la morte in tutti i suoi dischi, in tutti i suoi concerti. In quell’universo il live del 17 maggio 1966 al Free Trade Hall di Manchester è di gran lunga il suo disco dal vivo più celebre e venduto. È l’ultimo. Dopo il funerale Grossman era disperato – un tour di quaranta date in giro per il mondo da annullare – non restava che recuperare tutte le registrazioni dei concerti e pubblicarne una all’anno, tenendo viva la fiamma del genio prematuramente scomparso. La registrazione amatoriale di Manchester era quasi migliore di quella supervisionata da Bob Johnston il 26 maggio al Royal Albert Hall di Londra: quando sarebbe comparso il bootleg, nel 1970, Grossman lo avrebbe fatto sequestrare per poi farne ristampare un’edizione un po’ ripulita dalla Columbia qualche anno dopo.
In quell’universo i dylaniti si sarebbero gettati immediatamente sulla testimonianza più drammatica dell’ultimo tour, cercando tra i solchi gli indizi della tragedia imminente. Di cosa parlava l’inedito che non fece in tempo a incidere, Tell Me Momma? Chi è la ragazza sull’orlo del davanzale, incerta se dare un po’ di spettacolo? Era già così stanco della vita, l’uomo che aveva smesso i panni di leader del movimento folk per una Telecaster e due occhiali da sole da rockstar? E perché al tizio che lo chiama “Giuda”!, prima di attaccare la sua ultima Like a Rolling Stone, Dylan rispondeva: “Non ti credo, sei un bugiardo?” Un fanatico, forse, un maleducato, senz’altro, ma perché un bugiardo? A qualcuno che vi accusa di tradimento, rispondereste mai: non ti credo? È quasi un’ammissione, non trovate? C’è gente che ha passato anni a farsi domande del genere – magari anche John Lennon.
Nel nostro universo invece è successo qualcosa, non sapremo mai cosa. Un ripensamento all’ultimo istante, un riflesso condizionato, una svolta, una frenata. Fatto sta che Bob Dylan il 29 luglio 1966 non è morto. Rotta qualche vertebra, dice lui. Secondo alcuni non si è nemmeno fatto male – nessuno lo ha mai visto in ospedale. Ma una serie di concerti programmati negli USA, Grossman dovette cancellarli davvero, e non fu che l’inizio. Dylan non andrà più in tour per otto anni: la seconda fase della sua carriera è finita. Malgrado sia l’epoca classica, quella che più di ogni altra definisce la figura pubblica di Bob Dylan, è durata pochissimo, e a momenti non finiva in tragedia. In effetti, è strano che non sia andata a finire nel modo peggiore. Le premesse c’erano. Dylan è sopravvissuto al suo mito, cresciuto in modo così rapido e incontrollato che rischiava di soffocarlo. Tutto quello che ha fatto da quell’estate in poi in fondo è stato sopravvivere. Ci è riuscito egregiamente.
In questo universo il concerto di Manchester è stato per anni uno dei suoi bootleg più famosi, anche se nessuno lo sapeva. Una registrazione di discreta qualità era stata spacciata, sin dagli anni Settanta, come una testimonianza del concerto al Royal Albert Hall del 26 maggio. Dylan ha acconsentito a pubblicarne una versione ufficiale solo nel 1998 – è stata la seconda uscita della sua Bootleg Series. Persino questa uscita mantiene il nome “The Albert Hall Concert”, anche se tra virgolette, perché ormai i dylaniti lo conoscono così e a tirare in ballo Manchester rischiavano di confondersi. Poi, un paio di mesi fa, quando avevo già cominciato la mia dylaneide, la Columbia ha pubblicato in un’edizione limitatissima tutte le registrazioni di tutti i concerti del 1966, giusto in tempo per evitare che dopo 50 anni i diritti di qualche scoreggia di Dylan e degli Hawks non diventassero di dominio pubblico. Sono 36 cd, di cui almeno uno in edizione non limitata (disponibile anche su Spotify), cioè… il vero concerto alla Royal Albert Hall, che si chiama appunto The Real Royal Albert Hall 1966 Concert. Tutto questo succedeva due mesi fa, dopodiché la Columbia ci ha fatto sapere che Dylan aveva pronto un nuovo disco di cover, triplo. Da quando ho iniziato a scrivere un pezzo su ogni disco di Dylan, lui ne ha pubblicati quasi una quarantina. Comincio a capire come si sente Achille mentre la tartaruga si allunga.
Ricapitolando: quello tra virgolette (“The Albert Hall Concert”) non è quello inciso all’Albert Hall, anche se tutti lo hanno pensato per così tanto tempo che ormai è come se fosse vero; invece quello sottolineato (The Real Royal Albert Hall Concert) è stato inciso davvero all’Albert Hall da Bob Johnston, e infatti la qualità audio è un filo superiore, ma Dylan è anche un po’ più stanco e scazzato: all’inizio più che suonare She Belongs to Me sembra che voglia sbagliarla, che voglia tirarla da una parte o dall’altra finché non diventa un’altra canzone. Quanto agli Hawks, forse erano emozionati perché fino a pochi mesi prima suonavano nelle balere del Jersey, quando andava bene. Ed eccoli al Royal Albert Hall, pieno zeppo di inglesi. Che li fischiano. Con protervia e maleducazione. È una cosa che si vede meglio nei video su youtube, spezzoni di quel documentario che Dylan non riuscì mai a montare. Sembrano proprio intolleranti, e cattivi. Vattene a casa Bob, dicono. Stacca l’amplificatore. Lui è al pianoforte cerca di cominciare Ballad of a Thin Man, ci prova per qualche minuto, ma loro vanno avanti (non è successo né a Londra né a Manchester, ma da qualche parte è successo). Sembra che abbiano pagato il biglietto per quello: per venire a fischiare Dylan. Come ai tempi delle serate futuriste, il pubblico è al contempo il vero artista e il villain della storia che sarà raccontata negli anni a venire: perché la storia la vincono i vincitori e Dylan ha vinto – o perlomeno è sopravvissuto meglio dei suoi detrattori. Già nei primi Settanta, i pionieri della critica rock salutarono l’apparizione del bootleg come un quinto vangelo: il migliore rock dal vivo mai sentito, scrivevano. In effetti ai tempi non è che ci fossero molti live decenti in circolazione – i Beatles, com’è noto, non riuscirono a inciderne uno, troppi urletti: per i Rolling Stones si dovette aspettare il tour del 1970.
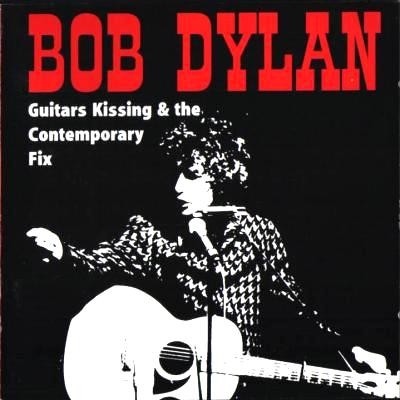
Altra edizione abusiva (sempre del concerto di Manchester), il rock e il pied-de-poule mai così vicini.
Ma Dylan suonava in ambienti più raccolti, per un pubblico, almeno in teoria, più qualificato: gente abituata a sciropparsi tre quarti d’ora di set acustico applaudendo soltanto a fine canzone, cioè in media ogni otto minuti. Questo fece di lui da subito l’artista più piratato, quando ancora portarsi in teatro un registratore a bobine non doveva esser poi così semplice: ma finché si trattava di registrare voce e chitarra, il risultato valeva quasi sempre la pena. Anche i set elettrici a modo loro funzionavano, e proprio per il motivo opposto: fischi e applausi andavano a fondersi con gli arpeggi di Robertson e le scariche di Mickey Jones, in un rudimentale muro del suono che l’edizione ufficiale del 1998 ha parzialmente sgretolato. Ora voce e strumenti si sentono meglio e forse anche un po’ di mito è venuto via col rumore di fondo – mi chiedo chi oggi ascoltando “The Royal Albert Hall” per la prima volta oserebbe ancora definirlo il miglior disco rock dal vivo. Voglio dire: è ancora roba di prima qualità, brillante, pioneristica. Non assomiglia a nessun gruppo rock inglese, e nemmeno al blues americano – con una mossa autolesionistica, man mano che procedevano nel tour, Dylan e gli Hawks avevano accantonato tutti i blues facili degli ultimi due dischi. Quella che viene eseguita è una musica con solide radici nella tradizione musicale americana, ma con fiori e frutti completamente nuovi. Più duttile del blues, meno immediata del nuovo rock. Non molti erano pronti ad ascoltarla nel 1966: senz’altro non i cultori folk che avevano comprato il biglietto nella speranza di riascoltare The Times They Are A-Changin’ o Hattie Carroll. Ma sul serio era il migliore rock in circolazione? Il punto di arrivo della carriera di Dylan? I critici riascoltano i dischi rimasterizzati e dicono di sì, il pubblico pagante fischiava, gli Hawks tornarono a casa piuttosto avviliti (Levon Helm, il batterista e leader, era stato il primo a dare forfait), Dylan pur di non proseguire combinò un incidente in moto. E se il pubblico non avesse avuto tutti i torti? Se la strada era davvero quella giusta, perché Dylan non ha proseguito in quella direzione?
Nel 1999 un giornalista è riuscito a scovare il cattivo di tante leggende dylanite, l’Accusatore di Manchester: l’uomo che fu registrato e filmato mentre gridava: “Judas”. Si chiama John Cordwell, faceva l’insegnante e allevava api nel tempo libero. L’intervista è un esempio interessante di come la memoria e la leggenda dello stesso fatto prendano strade diverse. Tutti i dylaniti conoscono a memoria lo scambio:
“GIUDA!”
“Non ti credo. Sei un BUGIARDO! (Alla band:) Suoniamola forte, cazzo”.
(Parte Like a Rolling Stone).
 |
| In spagnolo “Play it fucking loud” si riesce a tradurre, in italiano mah. |
Per anni tutti l’hanno ascoltata così. Persino Cordwell l’ha probabilmente ascoltata così, senza riconoscersi, perché il disco si chiamava “Royal Albert Hall” e lui non aveva mai visto un concerto di Dylan alla Royal Albert Hall. Poi un giorno ha scoperto che invece era un concerto a Manchester, e soprattutto che in giro c’era un altro signore che raccontava di aver gridato GIUDA a Bob Dylan quella sera. Ma anche lui, a pensarci bene, gli aveva dato del GIUDA. Chissà quanti stavano urlando cose del genere. Riascoltando il disco, Cordwell si è accorto che la voce era la sua. Dopo trent’anni! che storia. Magari è falsa: Cordwell sarebbe morto pochi mesi dopo l’intervista, forse per la puntura di un’ape. Ma sembra una storia vera perché è deludente. La verità ha sempre quell’inconfondibile fragranza di delusione. Nella leggenda, a Dylan viene data l’opportunità di rispondere, e nel modo più cinematografico: non ti credo, bugiardo!, e poi via con un rock smagliante che lascia al tappeto ogni polemica. Nella memoria di Cordwell, Dylan non riesce a rispondergli, non riesce a farsi sentire, c’è troppo baccano e in fondo non c’è niente da dire. E il rock non è affatto smagliante: dalla sua postazione Cordwell udiva soltanto una cacofonia incomprensibile. Lo stesso equivoco di Newport: a innervosire il pubblico non sarebbe stata la svolta elettrica, ma la cattiva qualità del risultato. “Non riuscivo a sentire le parole… credo che sia stato quello a farmi arrabbiare. Pensavo: quest’uomo sta buttando via la parte migliore di quello che fa”.
Un altro aspirante al ruolo di uomo-che-urlò-Giuda, Keith Butler, sostiene che era indignato per come gli Hawks avevano trattato One Too Many Mornings: uno dei due pezzi intimisti di The Times They Are A-Changin’, un delicato numero per voce e chitarra su quel problema di coppia che in quegli anni si cominciava a chiamare Incomunicabilità, su quel senso di nausea che ti prende dopo ore di discussioni riassumibili in niente. È chiaro che il brano ispirato alla storia con Suze Rotolo poteva servire anche a descrivere il rapporto conflittuale tra Dylan e fan: ma nel frattempo gli Hawks l’avevano ingabbiata in una struttura pesante, un vagone sferragliante e neanche così veloce: cosa aveva guadagnato in questa versione elettrica? Diciamocelo: poco o niente. Se aggiungiamo che la melodia di One Too Many è uno scarto di lavorazione di The Times They Are A-Changin’, la canzone di protesta che Dylan aveva smesso di cantare proprio nell’anno dell’escalation militare in Vietnam, forse per un attimo riusciamo a capire come doveva girare il mondo nel 1966 dal punto di vista del giovane appassionato di folk come Keith Butler o John Cordwell. È da mesi che aspetti il ritorno in città di Bob Dylan: hai sentito dire che adesso suona con una band, almeno per metà concerto: che fai, non ci vai? Sai già che non canterà Blowin’ in the Wind, sono anni che non la fa più. Ma The Times They Are A-changin’ non dovrebbe essere una richiesta illegittima. E Hard Rain? Hollis Brown? My Back Pages? It Ain’t Me? Ce ne sarebbero di canzoni da pretendere. Dylan ovviamente non le suonerà. Sta già promuovendo il suo prossimo doppio album, che uscirà tra una manciata di giorni. Comincia con la versione acustica di uno dei suoi primi brani elettrici, She Belongs to Me. Rispetto a Londra, sembra più rilassato, meno impaziente. Un anno prima era stato proprio il tour inglese a mandarlo in crisi. Era tornato a casa deciso a piantare il folk, forse la musica in generale – poi si era messo alla macchina da scrivere e aveva pestato come un dannato finché non ne era uscita Like a Rolling Stone, ma tu queste cose ancora non le sai. Quello che vedi – per adesso – è il caro vecchio menestrello folk che ti ricordi.
 |
| Oh, vi amo proprio eh? (Qui è ironico davvero). |
Seguono due inediti: una storiella strampalata che sembra una presa in giro dei Beatles che imitano Dylan (Fourth Time Around) e poi un’altra composizione torrenziale su di una certa Louise e una certa Johanna, non si capisce molto. In seguito magari diventerà una delle tue canzoni preferite, ma al primo ascolto è difficile concentrarsi. Seguono, finalmente, due pezzi del repertorio, It’s All Over Now e Desolation Row, e un inedito che però si aggancia al primo ascolto, Just Like a Woman pare che si chiami (non ti stupisce affatto che sia in quattro quarti: è la prima volta che l’ascolti), e finalmente Mr Tambourine Man, anche lei cantata un po’ sottotono, in un’intonazione un po’ confidenziale, se non è semplicemente stanca. E tre quarti d’ora sono passati, e magari cominci a capire come andrà a finire, e quanti pezzi ancora ti piacerebbe riascoltare – che ne so, Don’t Think Twice. Spanish Harlem Incident. O magari Chimes of Freedom. E invece da dietro al sipario senti che stanno montando gli amplificatori – sta cominciando la pagliacciata rock. Ma almeno The Times They Are A-Changin’ la suonerà, no? Come fa a mandarci a casa senza The Times They Are A-Changin’?
Il sipario si alza, Dylan e il suo amico chitarrista stanno ancora accordando. Sembra quasi uno scherzo, finché basso e batteria non cominciano a pestare davvero. È un brano che non hai mai sentito, una specie di combinazione di una serie di cose che Dylan ha scoperto funzionare particolarmente dal vivo. La strofa è un blues in re; il ritornello è una scala simile a Like a Rolling Stone, ma alla fine manca un gradino e la voce di Dylan precipita nella tromba delle scale con quella blue note caratteristica: What’s wrong with you this tiiiiiiiiiiime? Non puoi sapere che tra qualche anno Greil Marcus la definirà così:
“Tell Me, Momma, una nuova canzone emersa durante il tour, apre ogni show e non ci sono mai fischi per lei. È troppo forte, arriva troppo velocemente. Dylan cavalca il frastuono che la band gli produce attorno come un surfer nell’incavo dell’onda, come se la sua unica via d’uscita fosse il desiderio di assorbire ogni goccia di energia dalla fisicità del momento per poi darci dentro di più. Una manciata di testi beffardi, divertenti, sconcertanti, enfatici non sembrano altro che una scusa per provare che questa è la miglior band del mondo. Garth Hudson sembra far suonare una fornace esplosiva, Rick Danko sempre lo stesso accordo [col basso?], Robbie Robertson una chitarra che dev’essere ancora inventata”.
Ma tu sei lì, Marcus ancora non lo conosci (magari è dietro di te che si fa una canna), e tutte queste cose non le senti, anche perché di solito non ascolti rock dal vivo, poi l’acustica è quello che è, insomma, ti sembra soltanto un caos non troppo organizzato. Però è vero, Tell Me Momma non dà fastidio. Almeno non è quella roba ridicola che fanno le boyband di adesso, come i Beatles. Certo, Dylan li sta imitando, nel look e in certe pose, ma probabilmente è tutta una cosa ironica, vero? (Capiterà sempre più spesso, da qui in poi, che a Dylan venga assegnata d’ufficio un’ironia di cui forse non è nemmeno capace. Un giornalista, tra gli altri, confesserà il suo smarrimento nell’attimo in cui si rese conto che Dylan non stava prendendo in giro Mick Jagger, Dylan lo copiava perché lo ammirava davvero).
Questa è… questa è… una vecchia canzone. Mi piacciono tutte le mie vecchie canzoni… non so chi ha detto che non mi piacciono… ma questa, questa è una vecchia canzone, ehm… questa, questa si chiama I don’t believe you, una volta faceva in un modo, ma adesso fa così, i tempi cambiano… influenzano questa canzone (dal vero concerto all’Albert Hall).
Il problema è che dopo Tell Me Momma c’è I Don’t Believe You, e qui se sei un estimatore del Dylan acustico cominci a soffrire. Perché quello che in Another Side era uno scherzo rapido, una delusione amorosa già rivoltata in parodia, adesso ha questa carenatura rock che imbarca acqua da tutte le parti, questi arpeggi professionali ma ripetitivi, questo passo leeeento, e non finisce mai! Cinque minuti e mezzo di I Don’t Believe You, perché? Non c’è davvero niente di più importante al mondo da dire? “Eddai, non vi accorgete che anche queste sono canzoni di protesta”, aveva detto Dylan una sera al pubblico rumoreggiante. “La solita roba di sempre, non sentite?” No. Con tutta la buona volontà del mondo non riesci a riconoscere una qualche forma di protesta nel rancore di I Don’t Believe You, o nel rantolo frustrato di Baby Let Me Follow You Down, che però, ammettilo, funziona molto meglio. Anche perché probabilmente non ti ricordi più la versione acustica, sta nel primo misconosciutissimo disco. Così in profondità dovette cercare Dylan, quando finalmente capì cosa poteva funzionare davvero nel set elettrico. Un certo modo di spostare con la voce ogni accordo sulla settima, di oscillare sull’orlo della stonatura. Quella blue note urlata, parte dal petto e gli scoppia nel seno nasale. Baby Let Me Follow You Down è una festa, ogni strumento fa il suo lavoro e lascia il suo segno – salvo che non era la festa che volevi festeggiare tu – non ti senti nemmeno preso in considerazione. Dylan non ci guardava più, raccontò anni dopo una spettatrice, aveva occhi solo per Robertson. Just Like Tom Thumb’s Blues si prende altri cinque minuti senza troppi scossoni, ma forse tu stai cominciando a guardare l’orologio e a pensare a tutti i vecchi pezzi acustici che sicuramente non ascolterai. Riparte un altro blues mai sentito, su una tizia che si mette in testa un cappello leopardato, qualcosa del genere. L’ex folksinger con la sua giacchetta pied-de-poule ci tiene a farci sapere che frequenta la scena di hip di Manhattan, ma se sei uno studente di Manchester appassionato di musica tradizionale, magari non te ne frega un granché, e poi? E poi… One Too Many Mornings, profanata così. Invece di suonare The Times They Are A-Changin’, ha optato per la canzone più simile e meno politica, e anche questa l’ha suonata elettrica, pesante, interminabile. Dieci minuti dopo, al termine di Ballad of a Thin Man, non ti è ancora passata la rabbia. Se Dylan voleva divertirsi a fare la rockstar, bene – ma perché doveva rovinare i pezzi vecchi, perché doveva immerdare i ricordi che si portavano dietro? Sei un Giuda, Bob.
“Non ti credo”.
“Non hai risposto di no”.
“Sei un bugiardo”.
“Che significa? Che non mi credi sincero? Credi che io non possa preferire gli originali acustici di I Don’t Believe You e One Too Many Mornings? Che debba subire il giudizio di critici ragazzini che in quanto a concerti rock avevano più o meno la mia stessa esperienza? E se ti dicessi che gli arrangiamenti elettrici sono invecchiati peggio dei brani acustici? Qualcosa non va. Lo so. Lo so che tu lo sai. E tu lo sai che noi non lo sappiamo. C’è qualcosa che si sta strappando nella tua testa e..”
“Suoniamola fottutamente forte”.
“Vai pure, tira giù il teatro. Ma cos’è che non vuoi sentirti dire?”
Nell’altro universo, John Cordwell ha fatto perdere le sue tracce. Qualche giornalista in cerca dello scoop del secolo era riuscito a identificare e rintracciare “l’uomo che urlò Giuda” sin dagli anni Ottanta, offrendogli denaro in cambio di un’esclusiva. Cordwell non aveva la minima idea del vespaio in cui si andava a cacciare. Cominciarono a dargli la caccia sciroccati d’ogni tipo, perlopiù detective improvvisati decisi a risolvere il caso del misterioso incidente di Dylan, avvenuto appena due mesi dopo. Cordwell aveva un ottimo alibi – un oceano di distanza dalla scena del presunto delitto – ma vallo a spiegare ai matti che ascoltano i dischi al contrario. Uno in particolare lo spaventò a morte, aggredendolo a un semaforo. Brandiva una pistola ed emetteva frasi sconnesse. Rimproverava a Cordwell praticamente tutto, dal Vietnam ai fatti di Altamont alla strage di Charles Manson. Tutto quanto era andato storto dagli anni Sessanta, non sarebbe avvenuto, se solo, se solo ci fosse stato ancora Bob Dylan sulla terra, a mostrare la via. Nulla era andato storto finché Dylan era su questa terra, ma poi tu, tu! lo hai chiamato Giuda, e lui è morto, e adesso guarda in che casino siamo. Guarda la corsa agli armamenti, guarda l’inquinamento, guarda i Bee Gees in classifica. È stata tutta colpa tua. In un qualche modo i passanti lo avevano immobilizzato, e il tizio in seguito era stato inviato a un ricovero coatto. Certe sere, nascosto dov’è, Cordwell se lo ricorda, quel coetaneo spiritato, lo rivede rigirarsi in mano la pistola, incerto se ammazzare o finire il suo discorso. E com’è che si chiamava, già? Mark qualcosa. Chapman, ecco, Mark qualcosa Chapman. Un matto. Probabilmente inoffensivo.
(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes…)