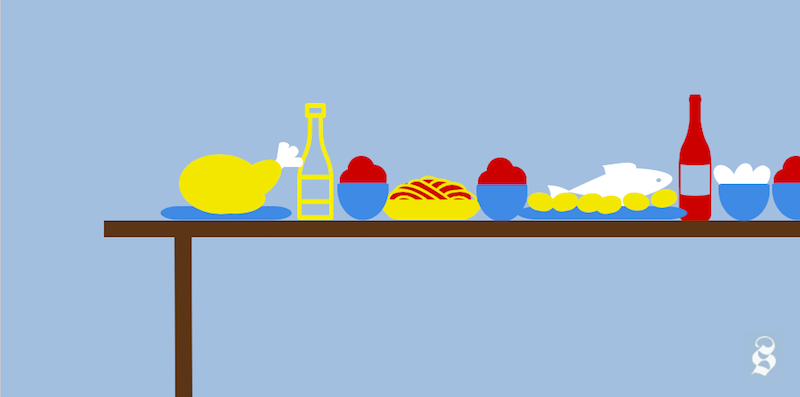L’importanza di chiamarsi Jeeg Robot
Ci sono volute nove settimane prima che Lo chiamavano Jeeg Robot, il film di esordio di Gabriele Mainetti, fosse finito. Nove settimane perché “cinque per un film del genere sono decisamente poche” e perché “serve tempo per certe scene d’azione”. È stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, pochi giorni fa, ed è tornato ieri a Lucca Comics & Games. Ed è andata bene: molte recensioni positive, tanti complimenti e qualcuno che – forse esagerando, forse no – ha urlato al miracolo, “finalmente il cinecomic è arrivato in Italia!”. In realtà Lo chiamavano Jeeg Robot non è un vero e proprio cinecomic. Non tecnicamente, almeno. È un film d’azione, con una storia d’amore e una componente – piuttosto importante, aggiungerei – di gangster movie. C’è un richiamo piuttosto evidente e profondo alla tradizione fumettistica classica (la genesi dell’eroe, la lotta contro il male, la chiamata alle responsabilità) ma non c’è una base unica da cui Mainetti si è lasciato ispirare – nessun graphic novel, nessuna tavola, niente di niente; l’idea e il soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti sono originali, e tanti complimenti anche su questo.
Il protagonista, interpretato da un crucciatissimo Claudio Santamaria, una via di mezzo tra il Matthias Schoenaerts di Un sapore di ruggine e ossa e il Tom Hardy di Bronson per la sua fisicità (ha messo su 20 kg prima di poter girare), è un criminale della periferia romana che per una serie di coincidenze – eviteremo gli spoiler troppo evidenti, promesso – ottiene dei superpoteri. Nel film, immancabile, c’è anche la nemesi dell’eroe, interpretata da Luca Marinelli (Non essere cattivo di Claudio Caligari): un personaggio ribattezzato simbolicamente “Lo zingaro”, che vuole avere successo e fortuna, e che in più di una sequenza, merito anche della regia di Mainetti, ricorda – citandolo, imitandolo, prendendone spunto – il Joker di Heath Ledger (i capelli lunghi, il tic compulsivo di passarsi la lingua sulle labbra, gli occhi stralunati, e i colori sgargianti di completi e vestiti). Quindi c’è anche “la” ragazza: Ilenia Pastorelli. È lei il centro del film, in un certo senso: il collante tra la prima e la seconda (e la terza) parte, l’anello “mancante” nella storia del protagonista, eroe per scelta e criminale per dovere (di sopravvivenza).
La storia, in sé, è piuttosto semplice e gira attorno al quesito fondamentale “che cosa faresti se avessi dei poteri?”. Trovandoci nella periferia romana ed essendo il personaggio principale un criminale, la risposta è: rubare. E rubare non per migliorare, andarsene, per avere qualcosa di diverso; ma rubare per avere il necessario, senza grandi pretese. La semplicità pasoliniana degli ultimi.
Nel corso del film gli obiettivi e le intenzioni del protagonista cambiano, si evolvono e si sviluppano. Lo spunto iniziale si trasforma in qualcosa di più, in una trama articolata e originale. Che ha tutte le carte in regola per poter convincere non solo la critica – e l’ha già fatto: girate un po’ in rete, troverete recensioni non solo entusiaste ma addirittura speranzose – ma anche e soprattutto il pubblico.
La capacità di Mainetti di alternare sequenze di azione a lunghi silenzi introspettivi, e la sua curiosità nell’indagare la vita quotidiana dei personaggi, rendendoli tutti interessanti e coerenti, lasciano poco spazio ai dubbi o alle perplessità (in più: è un cinefilo cronico, quasi patologico; e la sua abilità di inserire elementi e citazioni ha il gusto del dolce migliore, saporito ma che non disgusta).
Il film funziona. Dall’inizio alla fine, anche con i suoi momenti di lentezza ostentata (e su questo, probabilmente, c’è ancora da lavorare). L’azione è misurata con il contagocce. Né poca, né tanta: è quella che serve. In questo modo non ci sono solo combattimenti o scontri, e non sono combattimenti o scontri fini a sé stessi. C’è anche un po’ di quella vita vera che ultimamente sta tornando al cinema, di nuovo il pasoliniano Non essere cattivo.
È questo il cinema di cui abbiamo bisogno, e da qui il titolo di questo post “L’importanza di chiamarsi Jeeg Robot”: un cinema che non si limiti a citare o a ricreare immaginari già lungamente approfonditi, ma che vada oltre, che aggiunga elementi di originalità a storie a cui siamo abituati, che renda una storia impossibile accettabile, coerente e funzionale. Questo è il cinema dei giovani, quello nuovo, che ha la faccia e la visione di Mainetti e di tanti altri come lui; è il cinema dei supereroi che non vengono dai fumetti ma dalla nostra immaginazione – l’immaginazione di quando eravamo bambini, quando sognare non era così strano. In più: è quel cinema che costa poco, pensato e non fine a sé stesso.
Fino a febbraio, mese in cui Lo chiamavano Jeeg Robot arriverà nelle sale, il rischio che il filo comunicativo si perda è piuttosto alto. Il film, però, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un suo spazio al cinema, nella grande distribuzione (affidata alla Lucky Red), e per istruire un nuovo pubblico: non uno di appassionati convinti ma di spettatori medi, interessati tanto alla commedia quanto al dramma e al crime inglese.
Lo chiamavano Jeeg Robot è un esperimento; un esperimento su cui ci potrà dire meglio il tempo: se resisterà oppure no, se finirà nel dimenticatoio o se continuerà a vivere, diventando un piccolo cult come l’anime da cui prende il nome – e che rappresenta la base e le fondamenta di tutto il film. Vale la pena di guardarlo: il finale lascia aperte tutte le possibilità per un sequel.