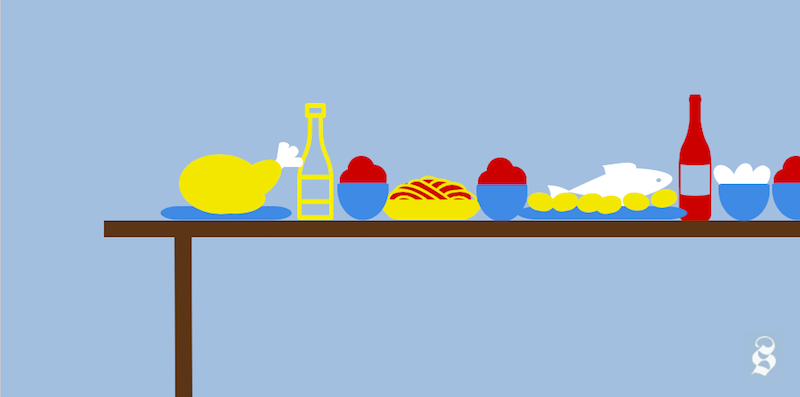A proposito di pane, fantasie e bugie
Sergio Saia è professore associato di Agronomia e Coltivazioni Erbacee all’Università di Pisa. Da anni si occupa di sostenibilità (diciamo di come misurare la sostenibilità, in pratica mette dei numeri accanto agli aggettivi). Ha pubblicato molti lavori sul grano e dunque, a proposito di pasta, pane e glutine, anzi, meglio, a proposito di pane, fantasie e bugie, abbiamo fatto due chiacchiere.
Allora partiamo dall’abc, il pane si fa col grano tenero e la pasta con la grano duro, quali sono le caratteristiche di un buon pane, quando l’assaggi cosa devi guardare, cosa annusare, cosa gustare?
Beh, non a rigor di termini il pane è solo di farina (lo sfarinato del grano tenero) e la pasta di semola (lo sfarinato del duro). La prassi è quella, ma al sud si usa molta semola per fare il pane e comunque la pasta fresca si fa anche con la farina. La pasta secca va fatta per legge con semola.
Va bene, andiamo con le caratteristiche di un buon pane.
Difficile dire, con il tempo sono molto cambiate. E variano anche in funzione della popolazione. Inoltre, dovremmo distinguere tra “buon pane” e “pane valutato come buono”. Spesso, infatti, il contenuto edonistico di un prodotto ha un forte peso nella valutazione del suo sapore.
Cioè?
In altre parole, attribuiamo a un prodotto il sapore che ci aspettiamo che abbia. Le valutazioni in cui l’assaggiatore è ignaro di quello che sta assaggiando sono radicalmente diverse rispetto a quando ne è cosciente.
Se paghi tutto sembra più buono…e venendo alle prove di assaggio?
Non solo se paghi sembra più buono, ma se lo hai scelto sembra più buono. Sulle prove di assaggio, è difficile poter dire, a un normale consumatore, cosa si debba guardare, annusare e gustare. Ma esistono le prove di assaggio (i cosiddetti “panel test”). Tali prove possono essere condotte da persone comuni o esperti assaggiatori, addestrati per riconoscere i sapori e i profumi, proprio come si fa con il vino o l’olio. Ovviamente il responso di un gruppo di assaggiatori professionisti ha un significato diverso rispetto a quello di una popolazione non addestrata.
Un esempio?
Spesso i primi vengono usati per identificare caratteristiche chiave relazionate con il sapore (ad esempio il contenuto in determinati composti o la “grana” del pane, etc.) mentre i secondi sono utilizzati per sincerarsi che tali caratteri, se presenti in un pane, portino effettivamente a una scelta. In altre parole, i panel diffusi da non esperti nella tecnica servono appunto a valutare quanto un utente medio sia in grado di percepire.
Quindi i criteri che seguono gli assaggiatori professionali sono più definiti?
In sede di assaggio professionale ci sono diversi criteri da seguire e questi vanno dalla conservazione del pane prima dell’assaggio (generalmente non lo si assaggia subito appena tirato fuori dal forno), al numero di pani che è possibile assaggiare in una sola occasione (generalmente pochi, 3 o in rari casi 5), ai momenti in cui può essere eseguita (lontano dai pasti, non si deve aver mangiato troppo né troppo salato), alla sequenza delle fasi dell’assaggio (percezione dell’odore prima e dopo del taglio, osservazione della crosta e della mollica, osservazione dell’alveolatura di questa, assaggio della mollica, della crosta, tempo di permanenza nella bocca), etc. E nulla toglie che qualcuno di questi aspetti possa essere valutato indipendentemente dagli altri (es. da assaggiatori bendati, che non vedano il pane).
Quante persone assaggiano prima di emettere un giudizio?
Gli assaggi professionali possono essere svolti anche da (solo) 10-12 assaggiatori, mentre quelli da parte di consumatori non caratterizzati previamente dovrebbero essere svolti da non meno di un centinaio di persone, tuttavia il numero minimo può variare moltissimo in funzione delle differenze attese: per ampie differenze, è possibile impiegare anche un centinaio di persone, per differenze attese più contenute ne possono servire anche diverse migliaia e ci sono procedure statistiche per determinare il numero minimo necessario. Da ciò si comprende facilmente che valutare una serie di pani molto diversi tra di loro ha un significato, mentre valutare pani analoghi ne ha un altro.
Spiega…
Valutare alcuni pani che differiscono per tipologia di sfarinato impiegato (integrale o meno) o anche la stessa specie usata (di frumento duro o tenero, di orzo, segale, etc.) o ottenuto con agenti lievitanti diversi, è meno complesso che valutare pani ottenuti tutti con lo stesso tipo di sfarinato della stessa specie e agente lievitante e che differiscano, ad esempio, solo per qualche cofattore o qualche tempo di lievitazione o per la dimensione del pane stesso.
Ma i lieviti contano per fare un buon pane? Perché parliamo sempre del lievito madre?
I lieviti contano eccome. Generalmente con il termine “lievito” ci si riferisce a diversi agenti lievitanti. Quello ormai più conosciuto è il cosiddetto lievito di birra, che è un fungo (e in effetti dal punto di vista scientifico i lieviti sono funghi), mentre quelli che vengono chiamati “lievito madre” o “pasta madre” o “pasta acida” solitamente non sono funghi, ma batteri che possono assolvere alla stessa funzione, appunto far lievitare gli impasti.
Cambia il risultato?
Certo, non lo fanno mica allo stesso modo. Funghi e batteri sono organismi molto diversi tra di loro e anche a parità di carica microbica (si, si possono anche contare e non è nemmeno difficile in laboratorio) hanno esigenze e tempi diversi. Inoltre producono composti diversi. Il motivo per cui si parla tanto di lievito madre (che solitamente non è un fungo) è che in determinate condizioni il lievito madre produce sapori e odori (beh, composti volatili, ma i colleghi chimici mi perdoneranno) diversi dal lievito di birra. Ma diversi non vuol dire migliori. In alcuni casi sono migliori, in altri no.
E perché dunque si parla tanto del lievito madre?
Spesso si attribuisce al lievito madre il “sapore dell’antico” e al lievito di birra i connotati della “perfida modernità”, perché il lievito madre necessita di più tempo rispetto al lievito di birra per far lievitare gli impasti. Spesso ne necessita di più perché se ne mette di meno. Il lievito di birra, per questa e altre ragioni, si è appunto affermato negli usi correnti in larga scala. Comunque sia, ci sono altre caratteristiche del processo di panificazione che possono influenzare il sapore del pane anche più dell’agente lievitante.
Parliamo della pasta. Per prima cosa, se non sbaglio, siamo i primi consumatori, ma abbiamo abbastanza grano? Qual è la situazione?
Quando si dice che “siamo i primi consumatori” spesso non si caratterizza l’unità di misura. Siamo i primi consumatori procapite, ossia ne consumiamo più di altri stati per persona e per anno.
Ok, numeri?
In Italia ne consumiamo, in media, tra 23 e 24 kg all’anno a persona. Ovviamente nazioni più popolose della nostra possono comunque consumarne di più (a scala nazionale) sebbene abbiano un consumo procapite inferiore ed entrambe le variabili hanno un diverso significato dal punto di vista economico, della salute e ambientale. Nei fatti, mangiamo in larga maggioranza pasta secca, che come già detto è fatta per legge con la semola (lo sfarinato del frumento duro). Ma usiamo il frumento duro anche per la panificazione e per altri prodotti da forno. Posso essere prolisso?
Proviamo sì.
Voglio anche sottolineare che con un kg di frumento duro non è possibile fare un kg di pasta. Nei fatti il frumento e la pasta secca hanno circa la stessa umidità, ma normalmente per la consueta pasta non integrale utilizziamo solo una quota del chicco del frumento. Circa il 60-70%, quindi con un kg di frumento, generalmente, viene fatto al massimo 600-700 g di pasta secca. Ovviamente la parte non utilizzata (prevalentemente crusca) viene destinata ad altri usi alimentari umani o, prevalentemente, zootecnici (e di mangimi e foraggi abbiamo pure una forte importazione dall’estero).
Nulla viene sprecato, va bene, per quanto riguarda invece la questione grano italiano?
Beh, il ritornello del “grano italiano” è bello (io stesso vengo da una famiglia di produttori di grano duro), ma piaccia o meno agli agricoltori, non abbiamo affatto tutto il frumento duro (e nemmeno il tenero!) che ci serve per i nostri usi: pastificazione, panificazione, altri prodotti da forno e anche per la semina. E da qualche tempo, esistono anche varietà di frumento tenero da biomassa, quindi le esigenze potrebbero aumentare magari a discapito di altre colture.
Qualche numero?
La superficie di tutta l’Italia è circa 30 Milioni di ha, di cui poco meno di 18 è agricola (detta SAU, quasi il 60% del totale, un valore elevatissimo!). Circa 1.2-1.4 milioni di ha (ossia oltre il 7% della SAU) sono coltivati a frumento duro e tale superficie, attualmente, fornisce da 4.0 e 4.5 milioni di tonnellate di frumento. Ma la filiera italiana della pasta ne assorbe quasi 6 milioni, quindi, dal punto di vista puramente matematico, siamo in forte deficit. Di circa 2 milioni di tonnellate, appunto.
Puramente matematico…
Beh, in primis come dicevamo una parte del frumento va ad usi diversi dalla pastificazione. In secondo luogo, non tutto il frumento che produciamo, purtroppo, ha una buona attitudine alla pastificazione e quindi non può essere usato per questo scopo. In particolare, è relativamente complesso per una grande industria utilizzare semola con basso tenore proteico. E purtroppo il frumento duro che produciamo ha forti carenze in proteine.
In linea di massima, è possibile fare una discreta pasta con un grano poco proteico?
Da più cori si sente dire in giro “è possibilissimo fare buona pasta con frumento poco proteico, a maggior ragione adesso che le varietà di frumento hanno una elevata tenacità del glutine”. Comunque si, è possibile fare buona pasta con frumento poco proteico.
Spieghiamo un po’ i termini? Tenace?
In parole povere, la tenacità del glutine è il carattere che fa mantenere la cottura o, se preferite, che fa scuocere difficilmente la pasta. Poco glutine molto tenace può mantenere la cottura come molto glutine poco tenace. E il glutine, negli sfarinati, è la quasi totalità delle proteine.
Tornando alla questione del basso tenore proteico del nostro frumento, se è possibile fare buona pasta, perché non lo possiamo usare?
Come dicevo, è possibilissimo fare pasta con frumento poco proteico, anche buona pasta. Ma un conto è fare un piccolo lotto di pasta, magari spendendo non poche energie per mettere a punto la metodica di pastificazione e un altro conto (ben diverso), è impiantare un sistema di produzione industriale, quindi in vasta scala, il quale è stato standardizzato (per ragioni che non serve spiegare) e che si fonda, per la sua buona riuscita, su caratteristiche ben precise della semola, tra cui appunto il tenore proteico.
Quindi nella sostanza è una questione di metodologia produttiva?
Si, c’è in primis il problema della metodologia, che per una grossa azienda spesso richiede diversi anni per esser messa a punto. L’industria che volesse cambiare la propria strategia di pastificazione, dovrebbe quindi mettere a punto una metodica adatta alle proprie macchine e cambiarla e soprattutto riuscire a fornire un prodotto che sia ugualmente apprezzato dal proprio consumatore, pena una forte riduzione delle vendite.
Visto tutto questo e considerato la bassa quantità di frumento, lo dobbiamo importare, giusto?
Non solo dobbiamo importare frumento (quasi la metà di quello che in tutto lavoriamo su scala nazionale), ma come se non bastasse, dobbiamo, con il frumento importato, compensare le mancanze qualitative di quello dalla produzione interna. Ciò non implica dire che il “nostro” frumento non sia buono. Sicuramente ha aspetti di pregio ma non ci si può fissare su aspetti che sono irrilevanti per l’acquirente e che non hanno nemmeno alcuna implicazione per la salute.
La salute?
E sì, purtroppo quello è un ritornello che si sente spesso, a gran voce, da diversi disinformatori professionisti. Il frumento duro di origine italiana ha spesso bassissimi residui (sia di principi attivi, sia di micotossine), soprattutto se di origine meridionale in cui le condizioni ambientali sfavoriscono l’attività dei funghi patogeni e la bassa intensificazione colturale porta a modeste applicazioni di principi attivi nella fase finale del ciclo. Ma il frumento di importazione deve rispettare (per legge) i limiti imposti a quello di origine nazionale. Converrai che se qualcosa fa male, appunto, non importa dove sia stata prodotta, ma quanta ce ne sia.
Concordo sì.
Tali limiti escludono che possano esserci rischi per la salute derivanti dal contenuto in residui. In altre parole, se anche tutto il frumento (o semola o suoi prodotti) che consumiamo avesse un tenore in residui identico al limite massimo, non sarebbe possibile ravvisare rischi per la salute. In gergo tecnico: non ci sono rischi concreti.
Studi in tal senso ci sono, vero?
Studi che escludano i rischi sì, tanti. E sono debitamente considerati dalle autorità preposte, come l’agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Studi che dimostrino i rischi no. E nessuno dei disinformatori seriali che propalano bufale sui rischi per la salute ha mai dimostrato l’esistenza di tali rischi concreti. Al contempo, lo Stato e l’Unione Europea hanno comunque messo in essere un sistema di indagini per valutare che tali rischi non sussistano nel frumento in commercio. E infatti è successo, in alcuni casi, che partite non conformi alle leggi vigenti siano state rifiutate. Purtroppo non è altrettanto facile controllare la miriade di agricoltori italiani perché, appunto, hanno molti piccoli lotti.
Questo è un aspetto importante, in genere siamo più propensi a consumare cibo prodotto dal piccolo e siamo scettici verso la produzione industriale, e tuttavia…
…E tuttavia, i piccoli agricoltori hanno meno possibilità di controllare quel che ottengono. La produzione italiana di frumento duro è in larga parte proveniente da una miriade di piccoli agricoltori, spesso con poca capacità di organizzare al meglio i fattori della produzione (e ciò comporta perdite di resa), con poca capacità o, nelle migliori delle ipotesi, possibilità di accedere alle innovazioni. Peraltro, l’età media di tali agricoltori è relativamente alta e la scolarizzazione bassa. Non voglio farne una tragedia, ma abbiamo un bisogno sfegatato sia di innovazione, sia della capacità di recepirla, sia di aumentare la dimensione media delle aziende e l’aggregazione degli imprenditori. Quest’ultimo punto è fondamentale anche per poter collocare al meglio la produzione sul mercato. Gli acquirenti del frumento (i molitori) sono pochi rispetto agli agricoltori e desiderano poter interagire con meno attori della filiera. E se ciò non accade, il potere contrattuale dei molti viene compromesso. E nei fatti lo è.
Un’ultima cosa, ci sono studi riguardo l’intolleranza al glutine? Per esempio, i cosiddetti frumenti antichi contengono meno glutine rispetto ai moderni? Cosa ci dice la letteratura scientifica?
Certo che ci sono studi nel settore. Come sai, una patologia alquanto famosa, la celiachia, ha a che fare con il glutine e attualmente l’unica strategia affinché un celiaco non abbia problemi è quella di escludere il glutine (e anche alcune altre proteine) dalla propria dieta. Per fortuna, solo una piccolissima frazione della popolazione è affetta da celiachia. La percentuale è in media intorno all’1% in Italia ma si stima possa essere più alta. Ad ogni modo, per poter diventare celiaci, serve avere dei geni di predisposizione e meno del 40% degli italiani ha questi geni. Peraltro, avere i geni di predisposizione non è affatto sufficiente per diventare celiaci e gli effetti scatenanti non sono del tutto chiari.
Ci sono intolleranze generiche, no?
Sì, se da un canto la celiachia è una condizione patologica ben definita, lo stesso non si può dire del marasma di intolleranze o sensibilità al glutine riferite da più parti. In effetti potrebbe esistere un’intolleranza di tipo non celiaco al glutine, ma nella stragrande maggioranza dei casi riferiti dalle persone, tale intolleranza è autodiagnosticata. Spesso le persone credono di avere malattie e le attribuiscono erroneamente a una o l’altra causa. Nei fatti, comunque, tale intolleranza è molto difficile da diagnosticare.
Come si diagnostica?
Si deve prima escludere la celiachia e poi riuscire a escludere, con dieta ferrea, l’ingestione di glutine. E non è per niente semplice. È interessante notare che in una ricerca in cui i pazienti riferivano di essere intolleranti, ma non celiaci (e sincerato che non lo fossero) avessero avuto più problemi quando non ingerivano glutine rispetto a quando lo ingerivano (ovviamente erano ignari di cosa ingerivano). Peraltro, l’esistenza della sindrome di sensibilità al glutine di tipo non celiaco è anche in dubbio, proprio perché una patologia deve poter essere riconosciuta chiaramente e tale eventualità, al momento (e purtroppo) non sussiste. Ovviamente nel settore c’è stata molta disinformazione, visto che diverse persone (ahinoi, perfino medici, talvolta) hanno cominciato a supportare, pur senza evidenze scientifiche, che se il glutine fa male a qualcuno, allora fa male a tutti. Credo sia facile capire che la preposizione è infondata, visto che qualcosa che fa male a una persona non per forza fa male ad altri.
Torniamo ai grani antichi?
I grani antichi sono una moda: il nome stesso fa attribuire agli stessi poteri taumaturgici. Le persone si innamorano spesso del nome “antichi” e grazie a quel nome sentono sapori e profumi che quel prodotto non ha affatto. Anche in questo caso, non sto certo dicendo che i grani antichi siano da buttare. Anzi, tutt’altro. Sono un’importante riserva di “geni” per il miglioramento genetico e aiutano a aumentare la variabilità genetica dei frumenti coltivati. Inoltre possono anche avere particolari caratteristiche. Ma spesso, di fronte a un panel test in cui i panelisti sono ignari di cosa stiano assaggiando, non vengono affatto ritrovati tali sapori. Anzi, spesso risultano meno graditi dei pani o pasta di grani moderni.
E il glutine?
Il glutine dei grani antichi è quasi sempre meno tenace di quello dei grani moderni. Anche in questo caso, qualcuno ha sollevato l’ipotesi, del tutto infondata, che un glutine meno tenace sia più digeribile, ma non esiste alcuna evidenza di ciò.
Ma la tenacità si misurerà in qualche modo?
La tenacità è una misura strumentale che si fa con impasti (farina o semola, acqua, sale), mentre la digeribilità dipende dalle condizioni del tubo digerente: un processo di masticazione, un pH molto basso nello stomaco, presenza di enzimi nell’intestino, senza contare che spesso mangiamo il pane o la pasta insieme a condimenti vari che possono intervenire molto nella digeribilità del prodotto. E in tutto ciò c’è lo zampino (d’elefante) della dieta nel complesso e dello stile di vita. Il glutine dei grani antichi quindi non è per niente più digeribile di quello dei grani moderni.
Ma aldilà di queste sfumature importanti, che mi dici della quantità di glutine nei grani antichi?
Non voglio ancora risponderti. Voglio dirti un’altra cosa sui grani antichi. I celiaci non reagiscono a tutto il glutine (ossia a tutta la sequenza degli amminoacidi che lo formano), ma solo ad alcuni “pezzi”. Tali pezzi sono stati chiamati “epitopi tossici” (un pessimo termine per un pezzo di proteina) in quanto in prove in vitro è stato osservato che sono questi pezzi a cui la mucosa intestinale reagisce. E occhio, questo vale per i celiaci, non per tutti. Coi grani antichi è arrivata anche un’altra bufala: ossia sostenere che siano meno “allergenici” rispetto ai moderni. Ma ironia della sorte, il glutine è un complesso formato da due proteine, le glutenine e gliadine.
Differenze tra le due famiglie?
La tenacità dipende molto dalle glutenine e nel miglioramento genetico il rapporto tra glutenine e gliadine è aumentato, ma gli epitopi tossici sono contenuti prevalentemente nelle gliadine, che sono più presenti nei grani antichi. Come dicevo, non c’è una differenza di salubrità tra antichi e moderni, ma se tale differenza dovesse essere desunta solo dal contenuto in epitopi tossici, beh, allora gli antichi sarebbero meno salubri. Adesso posso rispondere alla tua domanda.
Dai..
I grani antichi non hanno meno glutine dei moderni, ne hanno di più, spesso molto di più.
Come mai?
Il frumento, come ogni specie, cresce grazie alla fotosintesi. La fotosintesi dipende da molti caratteri (esempio la disponibilità di acqua e nutrienti, le temperature, la durata della stagione di crescita e ovviamente anche il genotipo). Il contenuto proteico della granella (e in ultima analisi di glutine, essendo questo una frazione abbastanza stabile delle proteine della granella) dipende da quanto azoto la coltura riesce ad assorbire e portare nella granella. L’azoto viene poi “convertito” in proteine (ok, chiedo perdono ai biochimici).
Va bene, ti perdoneranno…
I due processi (fotosintesi e accumulo di azoto) possono quindi avere decorsi diversi. Con il miglioramento genetico abbiamo aumentato moltissimo il potenziale produttivo delle varietà di frumento (e non solo), ma non siamo riusciti a intervenire molto sulla sua capacità di assorbire l’azoto e traslocarlo alla granella. Risultato? I grani antichi assorbono circa la stessa quantità di azoto rispetto ai moderni, ma spesso hanno una produzione inferiore del 30-70%. Ergo, i grani antichi “concentrano” meglio l’azoto nella granella e infatti hanno per questa ragione molte più proteine e quindi più glutine rispetto ai moderni. E tale glutine è meno tenace e con maggiore presenza relativa di gliadine (e quindi epitopi tossici). Risultato?
Risultato?
Chi vende o vuol promuovere prodotti senza glutine dirà che il glutine fa male a tutti, chi vende o vuol promuovere i grani antichi dirà che questi siano più salubri, ed entrambe le affermazioni sono false.