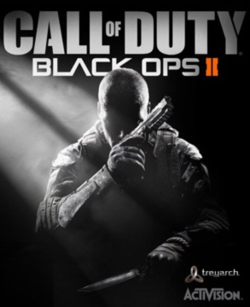Call of Duty: la guerra che molti stavano aspettando
Questa è quella stagione dell’anno in cui — io me li immagino così — cominciano a radunarsi e a venire verso valle. Escono da soli, salutano la famiglia, si infilano gli stivali e i mantelli, calcano i cappelli e s’incamminano sotto una pioggia fitta e leggera. Si incontrano ai crocevia, davanti a qualche rustico semi abbattuto, attorno a sorgenti ormai abbandonate da anni. Sono piccoli gruppetti che crescono mentre scendono e che anche di notte li distingui da lontano perché continuano a camminare, illuminati da torce improvvisate che ardono anche sotto la pioggia.
Io me li immagino così, come se il carrello arretrasse, la cinepresa aprisse il campo sempre più e potessimo vedere che sono decine, centinaia, migliaia, forse milioni. Aumentano, si incamminano come le formiche, come una migrazione epocale, come soldati di un esercito infinito.
Sono gli acquirenti di Call of Duty.
Perché tutti gli anni, attorno a questa stagione, torna puntuale come l’inverno il nuovo capitolo della saga dedicata ai combattimenti iper-realistici in soggettiva. Quest’anno siamo arrivati al nono appuntamento, la versione due di Black Ops, le “operazioni coperte” lanciate a fine 2010, e che fanno da intervallo alla serie dei tre “Modern Warfare”, la prima deviazione (datata novembre 2008) dal canone dei primi capitoli (tre per la precisione) di Call of Duty, che invece erano giochi religiosamente ambientati durante la Seconda guerra mondiale, nel teatro europeo e nordafricano del conflitto.
Confusi? Sapeste come ci si deve sentire se si prende in considerazione il numero di supporti che il franchise di Activision utilizza: Xbox, Playstation, Windows, Mac, Nintendo DS, Wii, iOS e un’altra mezza dozzina (incluso il mitico Nokia N-Gage, se vi ricordate di cosa stiamo parlando, e il Blackberry). E se poi guardiamo agli sviluppatori coinvolti da Activision per realizzare materialmente i videogiochi troviamo, oltre ai due super-studios Infinity Ward e Treyarch, anche il un bel pezzo del gaming americano: quelli di Gray Matter Interactive, poi Spark Unlimited, Pi Studios, Amaze Entertainment, Rebellion Developments, e infine la n-Space.
Un vero delirio, o meglio: un pieno orchestrale. Che viene però ripagato dall’esperienza di gioco: perlomeno, se piace il gioco sparatutto in soggettiva, e soprattutto se piacciono le avventure epiche e i multiplayer spettacolari, con mappe studiate al millimetro per offrire ambientazioni realistiche ed effetti non male. I questo caso Call of Duty è veramente un piccolo capolavoro. Prima che alziate gli scudi e tagliate il filo di questa mia elegia di Call of Duty (a proposito, rieccomi: ho avuto un po’ da fare, ma adesso ho pianificato una serie di novità per questo blog, non abbiate paura) perché dopotutto stiamo qui a parlare di videogiochi, forse è meglio che vi avverta. Ne parliamo sul serio, mica per scherzo. Nel senso che i videogiochi sono una cosa seria. Altro che telefilm: Aldo Grasso ancora va a giro dicendo che il telefilm e la serialità americana sono l’erede di quelle grandi narrazioni che rispecchiavano e insieme criticavano la società che noi chiamiamo convenzionalmente romanzo. Ma se continuiamo a cercare qualcosa in cui l’autore, attraverso dei personaggi, prende in esame alcuni grandi temi dell’esistenza, c’è di meglio. È il videogioco, e soprattutto il grande videogioco seriale costruito attraverso complesse saghe e ricchi franchising che spaziano attraverso l’ultimo decennio, il vero romanzo della contemporaneità. È Call of Duty che ha il ruolo del Il nome della rosa. Qualcosa a riguardo lo posso dire, visto che quelli di Call of Duty negli anni li ho conosciuti, sono venuti a trovarmi a Milano, sono andato io a Las Vegas a vedere come se la passavano. E soprattutto, visto che ho giocato a tutti i capitoli usciti fino ad ora.
La capacità narrativa degli autori di Call of Duty, che rimangono dietro le quinte né più né meno della maggior parte degli autori e produttori di telefilm seriali americani, salve poche eccezioni, è straordinaria e plasticamente adattata al mezzo. Non ci sono solo gli intermezzi in computer grafica a dare la sensazione del filmone per chi si avventura dentro un videogioco come Call of Duty: c’è tutto un mondo ludologico di interazione, di ricerca ed esplorazione, di cambiamento radicale nel rapporto tra il lettore e il testo (che in questo caso è il gioco stesso) da far impazzire qualche professore di semiotica. Ma sono cose di cui pochissimi parlano e ancora meno leggono. Bambinate, le chiamano.
Se invece vi invitassi a leggere la storia del “dietro le quinte” del più grosso kolossal che Hollywood possa creare oggi, un ipotetico mega-film realizzato da James Cameron, George Lucas e Steve Spielberg tutti assieme, avrei catturato la vostra attenzione? Penso proprio di sì. Basterebbe probabilmente che vi raccontassi il dietro le quinte dell’ultimo 007, Skyfall, per tenervi ipnotizzato. Dopotutto, carichiamo anche i film di un significato abbastanza complesso e ricco: manca la serialità; ma, mi sorprendo a pensare, come si fa a sostenere una cosa del genere anche nel caso di 007, ad esempio, che sta al giro di boa proprio quest’anno del suo sessantesimo anniversario con il film numero 23, il terzo interpretato dalla Bond girl più fisicamente dotata di tutte, cioè Daniel Craig.
Ecco, possiamo metterci d’accordo su questo: quel che state per leggere succede davvero, Call of Duty è il kolossal dei kolossal. Non solo nel settore dei videogiochi, ma anche relativamente al cinema: girano più soldi e ci vogliono più mesi di lavorazione, più professionalità e più destrezza per mettere assieme un Call of Duty che il 99% dei grandi film che vedete al cinema.
Il pensiero unito al ricordo di varie esperienze mi è venuto alla mente da poco. L’altro giorno mi è arrivato infatti il comunicato stampa di Activision: nelle prime 24 ore di distribuzione mondiale (il 13 novembre scorso) il nostro buon CoD Black Ops II, come lo indicano i cognoscenti del genere, ha totalizzato un fatturato di mezzo miliardo di dollari. Superando allegramente il miglior Harry Potter e il miglior Guerre Stellari. E non intendo i videogiochi di Harry Potter (orrendi) e quelli di Guerre Stellari (alcuni straordinari), bensì i rispettivi migliori film. Son cose.
Torniamo indietro nel tempo. Torniamo a quel lontano 2005: come tutti gli utenti Mac ho aspettato un annetto e mezzo che il primo CoD venisse convertito per la mia piattaforma dalla buona Aspyr (spot gratuito: una specie di crocerossa che converte tutti i principali giochi nati nel mondo PC per Mac, e che sono adesso per la maggior parte disponibili su App Store: fine dello spot gratuito). Ed è stata una vera esplosione. Perché di giochi in soggettiva se ne conoscevano parecchi dai tempi di Doom e di Quake. Anche un buon numero di “militari”, ambientati immancabilmente durante la Seconda guerra mondiale. Persino il mitologico Wolfenstein 3D aveva a che fare con nazisti, almeno durante le sue prime fasi. E c’è da chiedersi come si senta un tedesco d’oggi a fare la parte del cattivo per definizione da più di sessant’anni, peraltro. Comunque: di giochi in soggettiva se ne conoscevano parecchi, ma come questo ancora nessuno. La storia di un soldato semplice, anzi quattro, che vivono il loro piccolo angolo di guerra: battaglie ricostruite con un certo gusto per le ambientazioni, passione per i dettagli, grande lavoro sulle armi, che sono poi la vera “arma segreta” del gioco (se mi perdonate la cacofonia).
Cosa succede: succede che al terzo segmento del gioco, la campagna sovietica che segue quella americana e britannica, impersoniamo il caporale Alexei Ivanovich Voronin il 18 settembre 1942: ci danno una pallottola mentre il fucile (scarico) lo danno a un altro contadino comunista come noi e ci caricano su un mezzo da sbarco. Obiettivo: impedire che Stalingrado cada in mano ai tedeschi. A metà del guado rischiamo di essere ammazzati dagli Stuka e quando arriviamo a terra siamo sotto il tiro delle mitragliatrici tedesche. La collina è un massacro, lo scenario per l’epoca gigantesco e completamente aperto. Non siamo ai livelli di GTA, ma comunque se vogliamo “perderci” c’è solo l’imbarazzo della scelta per la direzione.
Questo grumo di sensazioni: essere un piccolo ingranaggio che vede in soggettiva totale la grande macchina della storia muoversi e cercare di stritolarlo; l’attenzione alle ambientazioni; il senso di libertà nel gioco sempre bilanciato dal fatto che non si finisce mai in angoli morti dove non succede niente; la storia che va avanti implacabile; le citazioni che s’incrociano (c’è una parte in cui si combatte tra rovine industriali e metropolitane abbandonate e scoperchiate dalle bombe con un cecchino nazista, e sembra di essere “dentro” Il nemico alle porte); la ricchezza di mezzi e di soluzioni “di regia” per gestire non solo l’avanzamento della storia ma anche l’impatto delle ambientazioni; ebbene tutto questo fa davvero impressione. Sconvolge. Emoziona.
L’esordio di CoD aveva anche un’altra cosa che era davvero unica, per la prima volta fattore rilevante in un gioco di questo tipo. E veniva dichiarata molto chiaramente fin dal liner del gioco stesso: “In war, no one fights alone”. Questo semplice messaggio era rivoluzionario: si andava avanti assieme, c’erano alleati (piccole unità tattiche, fino a interi squadroni di carri e plotoni interi) che avanzavano con noi, al nostro passo. La sensazione di immersione nella realtà, in alcune campagne particolarmente ben studiate, era davvero potente. Senza contare che CoD ha aiutato a definire anche lo stile nel montaggio di questo tipo di giochi: avventure e sequenze rapide, passaggi di campo articolati da filmati di trama pre-renderizzati o in tempo reale che conducono il giocatore attraverso una serie di passaggi come un cavallo da corsa: si morde il freno per partire, aspettando solo che vengano sciolte le briglie della scena di raccordo.
Affascinato dalla trama, dalla storia e dall’azione, non vi nascondo che sono diventato un fan di CoD: sono pochi i franchise così “antichi” che continuo a seguire con la stessa assiduità. Forse solo Halo, Tomb Raider e qualche altro che non mi viene in mente perché sul momento è fermo o non ha più attirato la mia attenzione (Shigeru Miyamoto, sto parlando con te!). Nel tempo ho continuato a giocarli: due puntate su Mac e le altre su Xbox 360. Un paradiso. Perché è venuta fuori la novità che è poi il vero punto di forza di Xbox 360: la parte Live. Il multiplayer online.
Ho passato un numero di notti spaventoso “dentro” al primo Modern Warfare, secondo me uno dei giochi più equilibrati di sempre. E io sono un giocatore più che mediocre, sono troppo vecchio e lento, la linea a casa ha una latenza eccessiva (ok, non è per quello che sono lento, ma la latenza c’è davvero), insomma non sono mai arrivato al livello 70, il più alto. Figuriamoci fare il giro completo altre due o tre volte, come una serie di alcune decine di centinaia di migliaia di ragazzini hanno fatto. E sono una minoranza.
Sì, perché l’altro fenomeno impressionante di CoD è stata la nascita di una comunità online gigantesca. La sera si poteva guardare l’indicatore delle partite assegnate e vedere due o tre milioni di persone connesse contemporaneamente. Poi giocavi “solo” contro altre sette persone, quindici nella modalità “battaglia totale”, però la sensazione era di fare parte di quell’armata enorme che vi dicevo all’inizio. Ognuno che viene dalla sua casetta persa sui monti, scende a valle, cammina nella notte e sotto la pioggia, diventa marea con milioni di altri giocatori, tutti si armano e vanno alla guerra. Gli utenti unici mensili calcolati sui giochi di CoD sono 40 milioni, la serie finora ha venduti 100 milioni di pezzi. Impressionante. In totale si sono portati a casa sei miliardi di dollari.
I primi tre CoD erano ambientati nella guerra mondiale europea. Il quinto titolo CoD: WaW (Call of Duty: World at War) era ambientato invece anche sul teatro del Pacifico, oltre che in Normandia, di nuovo fronte russo e vari altri scenari. Ma ormai il genio era fuori dalla bottiglia: l’uscita l’anno prima di CoD 4: Modern Warfare aveva aperto scenari inediti. Ambientato ai giorni nostri, anzi leggermente nel futuro, CoD4:MW ha dalla sua una trama molto più nera, acida e fantapolitica, con scene di violenza gratuite e una progressione, tra terroristi, russi che dichiarano guerra agli Stati Uniti e invasione dell’America, da lucido delirio. Sempre ottimamente realizzato.
Proprio l’anno dopo prendo l’aereo e me ne vado come di consueto a San Francisco per lavoro, a visitare alcune aziende interessanti. Sono nella valley quando mi viene proposto di fare un salto “un po’ più a sud”, cioè a Los Angeles. Obiettivo, gli studios che stanno finalizzando la realizzazione di CoD Black Ops, il titolo di quell’anno che come storia si colloca a metà fra i classici ambientati nella Seconda guerra mondiale e i “modern warfare” ambientati ai giorni nostri. Qui parliamo di “operazioni coperte” dei corpi speciali americani a cavallo tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Lo scenario è molto interessante perché c’è la scusa per tornare a Saigon e da quelle parti, la Guerra fredda è il mantello che copre tutto sotto una coltre di neve gelida, capace di fermare anche le navi rompighiaccio più agguerrite.
Per me vedere alcune centinaia di persone che lavorano alla realizzazione di questi giganteschi blockbuster è impressionante, una fonte di costante meraviglia. Gli addetti stampa snocciolano cifre da capogiro: a ogni uscita vengono superati record su record: CoD: MW3, uscito l’anno scorso, mette assieme mezzo miliardo di dollari in 16 giorni, uno meno di quanto non ci metta Avatar di James Cameron a totalizzare la stessa cifra. E i paragoni con il cinema continuano, soprattutto dopo aver visto il lavoro fatto di motion capture (una tecnologia alquanto singolare e bizzarra che permette di registrare i movimenti di una silhouette umana per poterli utilizzare come base per sintetizzare i movimenti dei vari personaggi primari e secondari del gioco) vengo travolto da un particolare che non avevo considerato. Nella localizzazione italiana del gioco si perdono ovviamente le voci americane dei doppiatori originali. Ma la lista di nomi tirati dentro fa impressione: Gary Oldman, Sam Worthington, Ed Harris, a cui si accompagnano i personaggi “in-game”: fanno la parte di loro stessi “zombizzati” nella serie di popolarissime mappe aggiuntive e alquanto ironiche della serie dei MW il buon George Romero, Denny Trejo, Sarah Michelle Gellar e Michael Rooker. Una sorta di lunapark per bambini cresciuti, che vedono nomi mitologici muoversi ai comandi del loro joypad (o quasi, insomma).
L’ultimo CoD, quello appena uscito che ha “tritato” via mezzo miliardo di dollari in 24 ore, ancora me lo devo giocare. La trama e i personaggi di questo Black Ops II sono noti: ambientato a metà fra gli anni Ottanta e il 2025, riprende la storia Alex Mason, rispunta il vecchio (e apparentemente morto) Frank Woods, e il figlio — perché qualcuno che corra, salti e spara ci vuole sempre — di Alex, David Mason. Si passa dall’America Centrale all’Afghanistan, da Los Angeles a Singapore fino allo Yemen. Ecco, a leggere le faq sui vari siti di appassionati poi finisce che uno si becca uno spoiler grosso come una casa, che non è quello che voglio fare io. La trama dei vari CoD è godibile come mediamente quella di uno 007 o di un film con Jason Bourne: azione, storia che guida e dà senso ai vari snodi che permettono di saltare da una mappa all’altra. Il primo Black Ops aveva un che di lisergico, chimicamente sconvolto come qualche passaggio di Apocalypse Now. In quei tratti la trama si assottigliava ma l’effetto scenico era davvero ragguardevole. Ho ancora negli occhi una Hong Kong da favola, uscita da un film d’azione degli anni Settanta, inquadrata dai tetti con la mitraglia che sventaglia e sventra le lamiere di improbabili condomini. Il nuovo potrà sicuramente fare di più, ma certe esperienze prendono colore con il passato.
Come quella mappa, in cui praticamente ho vissuto a lungo. È ambientata in Brasile, a Rio de Janeiro, in una delle favelas. Alternativamente piove o fa tempo abbastanza bello. Ormai la mappa l’ho girata tutta, c’è stato un tempo che la “sentivo” mia, mi ci muovevo quasi al buio come se stessi camminando in casa la notte, come che stessi percorrendo con la punta di un dito le scanalature del palmo dell’altra mano, dietro la schiena. Una mappa che ho adorato e odiato, in cui ho sofferto, esplorato, scoperto e commesso uccisioni spettacolari, assolutamente virali e catartiche, oppure in cui sono stato fulminato all’improvviso, apparentemente senza ragione, innumerevole vittima del Grande Conflitto.
Dopo un po’ che vivi nelle mappe, che sei nel multiplayer, infatti, cominci a “sentire” il gioco. Non c’è bisogno di passare le canoniche diecimila ore degli Outlier di Malcolm Gladwell, ma insomma ci si avvicina a un’effetto prostatico del joypad in relazione al contesto di CoD. Non manipolo più una interfaccia, vivi là dentro. È a quel punto che succedono cose divertenti anche nel mondo reale: quando ti muovi in zone sconosciute della città segui pattern simili a quello che uso a CoD, all’improvviso ti scopri a guardare i palazzi cercando di scorgere i cecchini, pianifichi le vie di fuga, prendi nota mentalmente dei passaggi attraverso i quali tornare per fare irruzione, mentalmente passi in rassegna le armi che ti servirebbero per abbattere un nemico su un tetto, in fondo alla strada, dietro l’angolo. Se entri in questa “zona” della mente, scopri una città molto diversa da quella a cui sei abituato di solito.
CoD: MW non solo ha creato una notevole trilogia fantapolitica, ma ha anche definito uno degli spazi virtuali più frequentati e appassionanti, più intensamente vissuti da milioni di persone come me. Un immaginario che, se potesse generare energia psichica registrabile, avrebbe ammutolito la maggior parte dei prodotti mediali degli ultimi cinquant’anni. Incredibile vero? E pensare che nei giornali non se ne occupa quasi mai nessuno, che si parla sempre di videogiochi e violenza, videogiochi e bambini, videogiochi e verdura mista. Adesso, invece, non vedo l’ora di giocarmi il mio prossimo CoD.