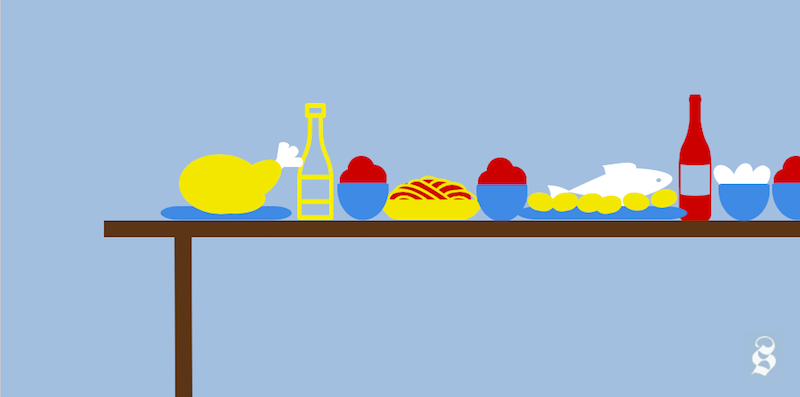Ma se il libro non è una merce, che cos’è?
In Italia si legge pochissimo. Solo il 46% popolazione dichiara di aver letto almeno un libro nell’ultimo anno per motivi non strettamente scolastici e/o professionali. Che significa: più di metà di un Paese non apre nemmeno un libro all’anno.
Di recente Newton Compton ha lanciato i nuovi “Lilliput” a 99 centesimi, per “combattere la crisi” e soprattutto provare ad ampliare un poco questo mercato così strutturalmente e desolatamente rachitico.
Serena Sileoni ha spiegato bene come questa novità abbia messo in crisi l’ansia di protezione di alcuni, che speravano di aver trovato un porto sicuro dagli “sconti selvaggi” grazie alla Legge Levi, che regolamenta – di fatto – il prezzo dei libri.
Si capisce che il libraio preferisce prodotti di prezzo più alto, sui quali il suo margine è più cospicuo. Difficile fargliene una colpa, soprattutto quando le librerie on line sono in crescita e guadagnano clienti a spese dei punti vendita tradizionali. Sorprendenti sono piuttosto i partigiani del libro costoso, privi di un interesse facilmente identificabile.
“Il libro non è una merce”, dicono costoro, e la cosa dovrebbe più o meno chiudere il discorso. Ma se il libro non è una merce, allora che cos’è?
Nessuno nega che il libro possa soddisfare i bisogni i più diversi. È un oggetto versatile come pochi. Un libro, un buon libro, non è un bicchiere di Coca Cola, che disseta e basta. Ci regala suggestioni e pensieri che ritroveremo magari fra chissà quanti anni. E’ a lunga conversazione. Ma per la verità esistono pure libri pessimi, mal scritti e peggio curati, superficiali, sciatti, quelli che non danno nulla e rubano solo tempo, e buona norma sarebbe chiuderli il prima possibile.
Gli uni e gli altri sono merci, si comprano e si vendono, e dacché si comprano e si vendono hanno un prezzo. Chi protesta contro un prezzo eccessivamente basso, par di capire ne vorrebbe uno più elevato. E allora non è che pensi che “il libro non è una merce”. Crede soltanto che il prezzo dovrebbe trasmetterne più correttamente il valore. Per una copia della Divina Commedia, siete pregati di recarvi in banca ed accendere un mutuo.
Noi assorbiamo il sapere, godiamo la prosa, piangiamo con la poesia – ma compriamo l’oggetto, la carta, l’impaginazione, il tempo e la passione dell’editore.
Come in qualsiasi commercio, i prezzi non sono né giusti né sbagliati e nemmeno “per sempre”. Cambiano nel tempo, come esito di un’asta perenne, nella quale chi vende e chi compra si confrontano di continuo, nel tentativo di indovinare gli uni le condizioni più appropriate per altri.
Coi prezzi si fanno esperimenti. Ogni tanto perché vi sono prodotti nuovi: guardate l’estrema variabilità di prezzo degli eBook. Gli editori debbono ancora capire, in tutt’evidenza, quant’è che il loro pubblico è disposto a spendere, e vanno per tentativi ed errori. Ma si può anche sperimentare, vendendo classici a prezzo scontatissimo, contando che Francis Scott Fitzgerald e Italo Svevo guadagnino all’editore legioni di nuovi lettori paganti, come tutti noi che li abbiamo letti riteniamo sia verosimile e giusto che sia.
Questo significa “mercificare la cultura”? Può darsi. Ma meglio che la cultura sia un commercio vivo, piuttosto che un reperto da museo.