Come Spotify usa gli artisti “finti” per riempire le sue playlist e pagare meno diritti
Un'indagine pubblicata da Harper's racconta la strategia della piattaforma per abituare gli utenti a un ascolto passivo e di sottofondo
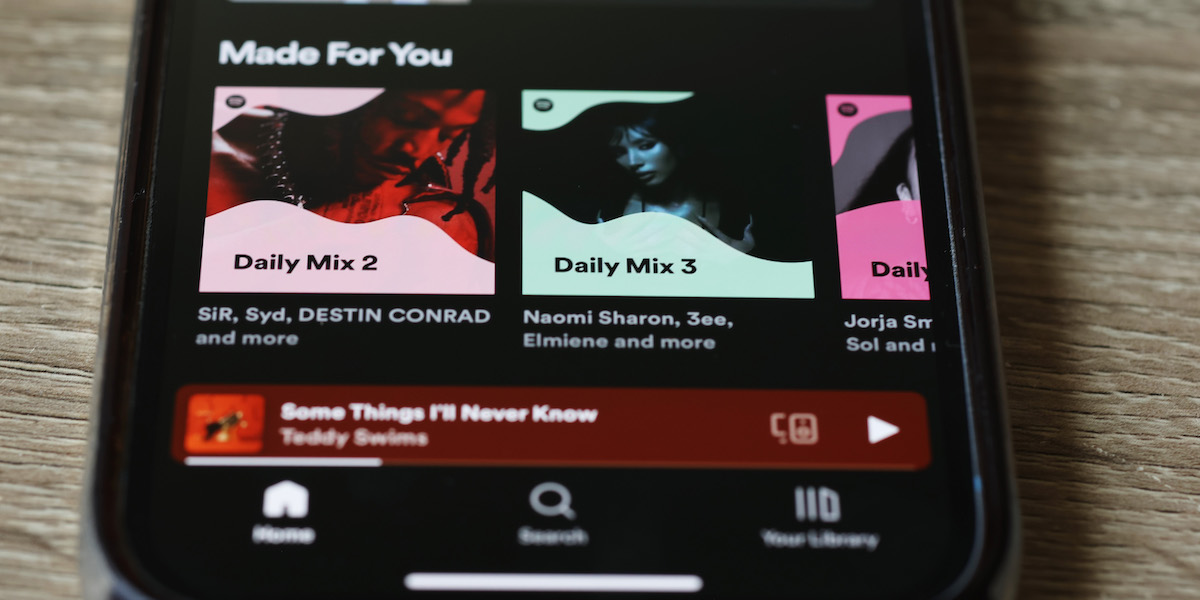
Nel 2016 alcune inchieste giornalistiche raccontarono la diffusione di canzoni sconosciute in alcune delle playlist più ascoltate di Spotify, soprattutto quelle dedicate a generi come il jazz e la musica ambient o pianistica. La rivista specializzata Music Business Worldwide scrisse che Spotify «stava chiedendo ai produttori di creare tracce, tipicamente senza voci» affini a questi generi, e l’azienda fu accusata di «creare contenuti di intrattenimento propri» con cui riempire playlist da milioni di ascolti mensili. Il presunto obiettivo era quello di versare meno diritti d’autore ai veri musicisti, grazie a degli accordi particolari con quelli “finti” incaricati di comporre queste tracce.
Questo mese la rivista Harper’s ha pubblicato una lunga inchiesta della giornalista Liz Pelly che sembra confermare molti dei sospetti e delle accuse più gravi rivolte alla piattaforma. L’articolo è un estratto da un libro che Pelly ha scritto sull’argomento, Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, in uscita negli Stati Uniti a gennaio, nel quale l’autrice racconta il dilagare di artisti “finti” sulle principali playlist del servizio.
La strategia di Spotify, secondo Pelly, è stata per anni quella di influenzare i gusti degli utenti in modo da abituarli a usare le sue playlist come sottofondo per le proprie attività, scegliendole sulla base del genere, dell’atmosfera e del “mood” suggerito più che per gli artisti e le canzoni. In questo modo, Spotify ha potuto riempirle di canzoni “finte” commissionate appositamente, evitando in questo modo di pagare i diritti d’autore a compositori, band e cantanti realmente esistenti. Diritti che sono comunque molto bassi, nell’ordine di una frazione di centesimo per ogni riproduzione.
Spotify non ha risposto all’inchiesta di Pelly, che nel frattempo è stata ripresa da giornali e testate specializzate in tutto il mondo.
Già nel 2022 il giornale svedese Dagens Nyheter aveva indagato il fenomeno, scoprendo che dietro a circa cinquecento artisti – la cui identità era spesso verificata da Spotify stessa con un bollino blu – si celavano in realtà poco più di venti autori, che producevano brani di ogni tipo raccogliendo milioni di ascolti nella piattaforma. Uno di questi, Efkat, risulta attivo dal 2019 e ha prodotto una manciata di canzoni apparse su playlist molto seguite, come “Lo-Fi House” e “Chill Instrumental Beats”. Una delle sue tracce, “Polar Circle”, ha quasi quattro milioni e mezzo di ascolti. Secondo un giornalista di Dagens Nyheter, però, la biografia dell’artista presente su Spotify è «completamente inventata» e contiene dettagli pensati «per farlo sembrare il produttore più cool del mondo».
– Leggi anche: Il musicista sconosciuto più ascoltato su Spotify
Dietro a questa strategia c’è un programma interno a Spotify che si chiama “Perfect Fit Content” (indicato anche con la sigla PFC), con cui l’azienda mira ad aumentare la percentuale di musica che costa meno alla piattaforma stessa. In molti casi, infatti, chi produce canzoni per questo programma viene pagato al momento e rinuncia a una buona parte dei suoi diritti d’autore, specie nel caso i suoi brani diventino popolari (cosa molto probabile, visto il successo delle playlist in questione).
Per capire come Spotify sia arrivata a ospitare sulle sue playlist canzoni di artisti inventati occorre capire la genesi dell’azienda stessa, nata nel 2008, in Svezia, con la promessa di essere uno strumento «migliore della pirateria», che permettesse di avere accesso a un enorme archivio musicale pagando un modico abbonamento mensile. Inizialmente il suo CEO e fondatore, lo svedese Daniel Ek, era addirittura avverso all’idea di un servizio che consigliasse brani o playlist: la prima versione del sito di Spotify dava ampio spazio alla barra di ricerca, e quindi alla scelta personale dell’utente.
Nel corso degli anni Spotify è cambiata molto, soprattutto per aumentare le proprie entrate. Nel 2012 in particolare si rilanciò come un servizio di «musica per ogni momento», cominciando a dare consigli d’ascolto in base all’umore, alla giornata e alle attività svolte.
Nel 2014 intensificò gli investimenti nelle tecnologie di personalizzazione algoritmica con cui consigliare contenuti agli utenti in base ai loro ascolti. All’epoca Spotify presentò questa tecnologia come una grande occasione per i musicisti, che potevano finalmente ridurre il peso e l’influenza delle etichette, della radio e del sistema musicale in generale. Una grande promessa di meritocrazia artistica basata sui dati e sulla presunta neutralità dell’algoritmo di personalizzazione.
In realtà, Spotify è stata da sempre influenzata da alcune delle principali case discografiche del mondo: Sony, Universal e Warner, che ad oggi controllano circa il 75% del mercato discografico mondiale, possedevano il 17% di Spotify stessa al momento del suo lancio. Sin dall’inizio, le major discografiche ebbero notevole potere contrattuale con l’azienda e guadagnarono più di tutti dal suo successo. Spotify, infatti, versa a case discografiche ed editori circa il 70% delle sue entrate e per molti anni non ha mai generato profitti.
– Leggi anche: Spotify Wrapped ha stufato?
Anche per questo Spotify ha più volte aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti, e a partire dal 2019 ha iniziato a espandersi nel settore dei podcast e degli audiolibri, stringendo accordi anche molto costosi e criticati come quello con il podcaster Joe Rogan. A convincerla a puntare sempre di più sulle playlist fu invece una scoperta interna resa possibile dalla grande mole di dati sugli utenti di cui dispone, da cui è risultato evidente che una buona parte del pubblico non accede alla piattaforma per ascoltare qualcosa di specifico, ma per cercare una colonna sonora per un momento della giornata.
È dall’idea di incentivare questo tipo di ascolto passivo e poco impegnato, in cui le singole band e i singoli album hanno scarsa importanza, che è nato il programma Perfect Fit Content.
Dopo un primo periodo di prova, il programma di musica commissionata PFC fu presentato agli editor e ai curatori di playlist di Spotify nel 2017. Pochi mesi dopo il sistema interno con cui i dipendenti dell’azienda possono vedere le statistiche relative alle canzoni (quanto vengono ascoltate, in quante playlist sono state aggiunte, quanti like hanno e così via) cominciò a mostrare la performance di questo tipo di contenuti.
Per il suo saggio pubblicato parzialmente in anteprima su Harper’s, Pelly ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti di Spotify secondo cui la spinta ad aggiungere questi contenuti alle varie playlist aumentò nel corso degli anni fino a diventare «aggressiva». Entro il 2023 la squadra che si occupa delle canzoni PFC monitorava diverse centinaia di playlist: di queste, circa 150 erano composte quasi del tutto da canzoni commissionate in questo modo (tra cui “Ambient Relaxation”, “Deep Focus”, “Cocktail Jazz” e “Deep Sleep”).
Da alcuni anni, del resto, alcuni giornalisti e critici avevano notato come la playlist “Ambient Chill” di Spotify fosse stata privata di artisti riconosciuti, come Brian Eno e Jon Hopkins, in favore di tracce realizzate da Epidemic Sound, uno studio svedese che fornisce canzoni e colonne sonore su abbonamento. Spotify ed Epidemic Sound hanno in comune anche gli investimenti ricevuti da un’azienda di venture capital, Creandum, che fu tra le prime a investire sulla piattaforma di streaming. Con gli anni l’interesse degli investitori in aziende come Epidemic Sound è aumentato, tanto che nel 2021 l’azienda ha ricevuto 450 milioni da Blackstone Growth e EQT Growth, due fondi di investimento. Oggi ha una valutazione di quasi un miliardo e mezzo di dollari.
Tra le aziende che forniscono canzoni a Spotify c’è Queenstreet Content AB, società di produzione del duo svedese Andreas Romdhane e Josef Svedlund (noti come Quiz & Larossi), che guadagnerebbe dal programma PFC più di dieci milioni di dollari all’anno secondo la ricostruzione di Pelly. Un altro fornitore, Industria Works, è parte di Mood Works, un distributore che pubblica canzoni anche su altri servizi di streaming, come Apple Music e Amazon Music: particolare che fa pensare che forse Spotify non sia l’unico servizio a promuovere musica di questo tipo per risparmiare in diritti d’autore.
Pelly racconta anche di aver incontrato un musicista jazz che ha firmato un contratto annuale con una società per registrare anonimamente canzoni che vengono poi distribuite su Spotify. Pur non conoscendo l’entità del rapporto tra l’azienda per cui lavora e Spotify, il musicista ha subito notato che le sue canzoni finivano su playlist con milioni di follower. Per produrre un brano di tipo PFC, ha spiegato il musicista, occorre però studiare questo tipo di contenuti: l’azienda produttrice gli indica spesso delle playlist da usare come riferimento, prima di iniziare una sessione.
Il consiglio che riceve in questo tipo di lavoro è sempre lo stesso: deve suonare facile. «Nulla che risulti anche solo minimamente complesso o controverso», ha spiegato. «L’obiettivo è di sicuro quello di essere il più anonimo possibile».



