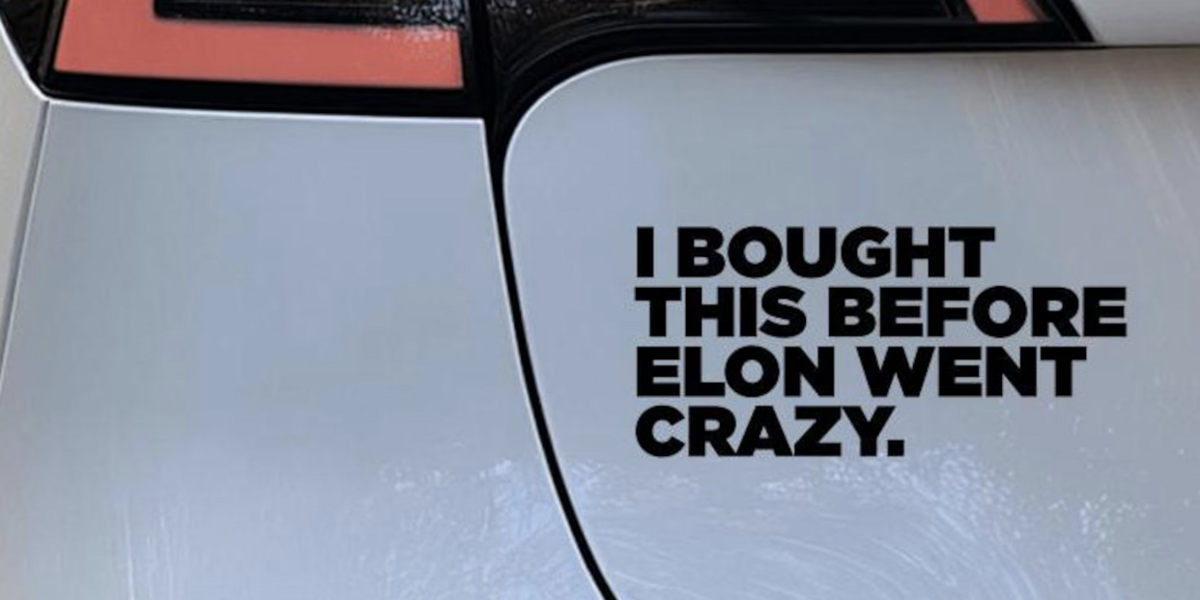Dentro alla prigione di Sednaya
Le torture, le umiliazioni e le esecuzioni raccontate dai detenuti del carcere simbolo del sistema repressivo di Assad, dove oggi migliaia di siriani cercano i propri cari fatti sparire dal regime
di Daniele Raineri

Sednaya è una prigione costruita 37 anni fa per umiliare e torturare gli oppositori del regime siriano di Bashar al Assad. È stata in funzione fino alla notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, quando i quattrocento militari che la controllavano si sono tolti le divise e sono scappati per non essere catturati dagli insorti che stavano occupando la capitale Damasco, distante mezz’ora in automobile.
Nel settembre del 2011, sei mesi dopo l’inizio delle proteste e delle rivolte in Siria, il regime decise di eliminare una parte dei suoi oppositori che stava arrestando a migliaia, e Sednaya divenne un luogo per le uccisioni di massa.
Secondo un rapporto di Amnesty International pubblicato nel 2017, tra la fine del 2011 e il 2015 il regime siriano impiccò circa trecento prigionieri al mese a Sednaya e ne uccise molti altri con pestaggi e causando loro malattie dovute a malnutrizione e denutrizione. Non c’è motivo di pensare che abbia smesso di fare la stessa cosa anche dopo. Amnesty trovò e intervistò 84 fonti per ricostruire che cosa succedeva nella prigione. Il titolo del rapporto era «Il mattatoio umano» e riprendeva la parola usata da un ex detenuto in un’intervista, che diceva di avere visto una notte «una fila di prigionieri condotta al mattatoio».

Una donna cerca nelle celle della prigione di Sednaya (AP Photo/Hussein Malla)
Mercoledì 11 dicembre, quattro giorni dopo la liberazione, persone arrivate da tutta la Siria affollano i corridoi e le stanze buie al piano terra della prigione. In molti alla luce di telefoni e pile tascabili frugano il tappeto di fogli, a volte fradici, che ricopre il pavimento e che è stato già calpestato da migliaia di piedi per cercare informazioni sui propri cari. Raccolgono un foglio, lo rigettano a terra e ne prendono un altro, mentre il foglio che avevano gettato viene raccolto da qualcun altro.
Il regime il più delle volte non dava informazioni alle famiglie della morte dei detenuti. La loro sparizione e l’incertezza che si lasciavano dietro facevano parte della punizione. Il luogo dove tutti vengono a cercare le circa 96mila persone scomparse in questi anni in Siria è Sednaya.
A volte la piccola folla si precipita tutta assieme in una direzione, si schiaccia alle inferriate di una sezione del carcere, c’è un gran vociare, urla, colpi di martello, mani che si passano tubi e piedi di porco per fare leva. Qualcuno dice di avere sentito colpi provenire da un muro o da un pavimento e sarebbe il segno che esiste una cella segreta, ancora non trovata, che rinchiude prigionieri ancora vivi. Succede una volta ogni ora. È sempre una delusione. Non esiste alcuna cella segreta. Non ci sono più prigionieri che aspettano di essere liberati.
I maschi di una famiglia vestiti in modo tradizionale dicono che un pezzo del pavimento è diverso dal resto, battono con i piedi, sostengono che è cavo, si sente dal rumore. Bisogna cominciare a scavare, dicono.
La gente sciama tra le varie ali della prigione e a volte passa attraverso buchi aperti nelle pareti. I primi ad arrivare non sono riusciti ad aprire tutte le porte e le inferriate e hanno sfondato i muri.

Dentro una stanza della prigione di Sednaya (Ali Haj Suleiman/Getty Images)
Sednaya è un trauma per la Siria e assieme ad altri traumi ha da molti anni un posto fisso nella testa dei siriani. La gente disperata che ora entra ed esce dai cancelli è preda di isterie collettive.
Nei sotterranei bui e puzzolenti di gasolio qualcuno dice «ecco i forni crematori», ma si tratta di un normale impianto di riscaldamento. Altri giurano che esista una stanza per dissolvere i corpi nell’acido, ma non c’è. Una sega circolare trovata in uno stanzone invaso da tre centimetri di liquami di fogna è subito considerata uno strumento per fare a pezzi e occultare i cadaveri. E poi c’è la pressa idraulica, che in molti dicono servisse ai guardiani della prigione per uccidere i detenuti schiacciandoli tra due lastre di metallo. Il metodo, dicono gli astanti con un brusio atterrito, serviva a comprimere i corpi e a renderli più idonei al trasporto.
La pressa è enorme ed è poggiata su un pavimento in una stanza vicina a quella che la gente indica come la cucina, con il locale dove si faceva il pane. È coperta da ragnatele e da un sottile strato di polvere finissima e chiara. Non ci sono macchie di sangue, alle pareti non ci sono manichette per l’acqua per lavare per terra, non ci sono canali di scolo, non c’è nulla.

La pressa trovata nella prigione di Sednaya (Chris McGrath/Getty Images)
L’orrore di Sednaya non andrebbe raccontato attraverso queste congetture al limite della leggenda metropolitana istantanea, perché non ci sono conferme e non ci sono prove fattuali; andrebbe raccontato attraverso alcuni, pochi concetti che risultano dalle testimonianze e dalle prove.
Il primo di questi concetti è l’inerzia degli assadisti. Sednaya era una grande macchina per l’eliminazione dei dissidenti e doveva funzionare con il minor sforzo possibile. Nessuno, tra la soldataglia del regime addetta a questa operazione, aveva voglia di faticare molto. Il metodo scelto per l’esecuzione era l’impiccagione di massa, con corde rosse già annodate a cappio che sono ancora nella prigione. La corda al collo è silenziosa, può essere usata senza che nel resto del carcere che conteneva migliaia di detenuti ci si accorgesse di qualcosa. È economica e infine restituisce corpi in condizioni buone per essere subito caricati sui camion e trasportati via, e non la poltiglia umana che presumibilmente uscirebbe dalla pressa idraulica.

Cappi usati per le impiccagioni nella prigione di Sednaya (AP Photo/Hussein Malla)
L’impiccagione è anche un richiamo all’arma più terribile dell’arsenale del regime siriano, l’agente chimico sarin, che blocca i muscoli respiratori delle vittime e le soffoca.
I soldati impiccavano tra i venti e i cinquanta siriani per volta, di solito il lunedì notte, a volte anche il mercoledì notte. Quando nel pomeriggio passavano di cella in cella a prendere gli uomini che dovevano essere uccisi dicevano che li stavano trasferendo a una prigione civile, per evitare reazioni. Li obbligavano a camminare nella posizione cosiddetta «del treno», ciascuno aggrappato con una mano al detenuto davanti, chino a toccare con la fronte la sua schiena e con la maglietta alzata sulla testa a coprire gli occhi.
I soldati li pestavano, li bendavano e fino a un minuto prima dell’esecuzione non dicevano nulla. Il detenuto bendato capiva che stava per essere impiccato soltanto mentre gli mettevano il cappio al collo, ma a quel punto era tardi per opporre resistenza. Gli assadisti avevano un nome per le impiccagioni di massa: «il party».
Il secondo concetto che regolava il funzionamento di Sednaya era la volontà sadica di umiliare i detenuti. Ogni procedura quotidiana era progettata per annullare la loro capacità di volere, di pensare e di resistere.
La suola della scarpa è considerata il massimo della sporcizia, non deve toccare il pavimento di casa e non dev’essere mostrata perché è un insulto. I sopravvissuti di Sednaya raccontano che durante le torture i soldati mettevano loro un sandalo in bocca e dicevano di stringere i denti, perché i torturatori non volevano sentire i lamenti. Nei giorni della fine del regime si sono viste molte immagini di siriani che mettono le scarpe sulla testa delle statue di Hafez al Assad oppure che calpestano con le scarpe i ritratti del figlio Bashar.

Siriani toccano con la suola delle scarpe la testa di una statua di Hafez al Assad abbattuta dopo la fine del regime del figlio, Bashar. Damasco, 8 dicembre 2024 (Ali Haj Suleiman/Getty Images)
Khaled Mohammed, un ex prigioniero di 23 anni, fa vedere al Post dentro al carcere di Sednaya come avveniva la distribuzione del cibo nelle celle e si fa aiutare da un adolescente che si presta a fare lo shawish, che era il detenuto designato capo della cella.
Un inserviente, che era un altro detenuto con un incarico privilegiato perché la famiglia aveva pagato una somma di denaro per corrompere i carcerieri, batteva sulla porta della cella accompagnato da una guardia e portava il cibo dentro a un mastello da bucato di plastica. I detenuti dovevano sdraiarsi faccia al pavimento con le mani intrecciate sulla nuca, perché per nessun motivo era permesso loro di guardare anche soltanto con la coda dell’occhio un guardiano.
La guardia chiamava lo shawish con il suo numero. Khaled inventa un numero: “raqqam uahed!”, “Numero uno!”. Lo shawish doveva strisciare faccia a terra verso il mastello, prenderlo con una mano e strisciare indietro.
«Se la guardia vedeva qualcosa fuori posto o sentiva una parola da parte dei detenuti, prendeva il mastello e lo rovesciava sul pavimento». Poi la guardia chiamava una squadra di quattro picchiatori e cominciava un pestaggio a oltranza dello shawish, così duro da ucciderlo. A quel punto i picchiatori dicevano ai detenuti di rannicchiarsi su un lato solo della stanza, continua l’ex detenuto, e picchiavano anche loro e anche in questo caso era possibile che ammazzassero qualcuno. Quando il pestaggio finiva, mettevano il corpo oppure i corpi al centro della cella e obbligavano i detenuti a mangiare dal pavimento e a usare i corpi insanguinati dei compagni ammazzati come tavolo da cui prendere il cibo.
Khaled è un ex soldato, è finito in carcere perché da sunnita aveva picchiato un soldato alawita, quindi appartenente alla setta religiosa minoritaria del presidente Assad e che era vista come la più vicina al regime. La sua famiglia al processo gli ha passato una somma di denaro che lui ha usato per corrompere i guardiani e non farsi torturare. Dice che le morti per pestaggi erano comuni e accadevano ogni settimana. Due altri detenuti confermano il suo racconto. I picchiatori usavano mazze di gomma dura che ricavavano tagliando pneumatici di trattore.
Ora se vede una telecamera Khaled si mette una mascherina chirurgica sulla faccia perché, dice, «ho paura del regime di Assad». Non si fida che sia finito.
Dentro le celle c’era la regola del silenzio assoluto e questo obbligava i detenuti di Sednaya a comunicare fra loro con le mani. Ogni detenuto aveva un numero, era vietato usare i nomi. L’esistenza a Sednaya era stare zitti nelle celle senza lampadine e senza finestre, vedere la luce del sole aumentare nei corridoi fuori dalla porta di metallo della cella e poi scemare, non essere chiamati per le impiccagioni e aspettare la distribuzione del cibo, per anni.
Khaled ricorda che ogni qualche settimana c’era la doccia. Il detenuto doveva mettersi sotto al getto d’acqua, contare ad alta voce fino a tre e lasciare il posto al detenuto successivo sotto l’occhio delle guardie.

Scritte sulle pareti di una cella nella prigione di Sednaya (Chris McGrath/Getty Images)
Le razioni erano minime. All’ospedale al Mujtahid di Damasco in questi giorni c’è una cella che ospita una decina di corpi di detenuti trovati in un ospedale militare che gli assadisti usavano come punto di transito per i cadaveri portati fuori da Sednaya. Sono magrissimi, hanno le braccia e le gambe sottili, le guance attaccate al teschio e le costole che sporgono.
Il primo giorno la pila era formata da quaranta cadaveri, che si sono ridotti man mano che le famiglie li hanno riconosciuti. Fra loro c’era anche Mazen al Hamada, un attivista che era fuggito in esilio in Europa e poi era rientrato in Siria, amareggiato dal fatto che le sue testimonianze sull’orrore della repressione assadista non fossero considerate interessanti. Fuori, su un muro dell’ospedale, qualcuno ha appeso le foto delle facce dei morti in modo che le famiglie possano riconoscerli senza entrare dentro alla cella dell’obitorio.

Foto delle persone morte nella prigione di Sednaya, appese fuori dai muri dell’ospedale al Mujtahid Mohamed (Azakir/Reuters)
Un terzo concetto che regolava la gestione di Sednaya era l’estrema e vuota burocratizzazione delle procedure. È uno dei motivi che spiegano perché il regime era chiamato “al nidham”, il Sistema. L’idea era che il Sistema sa tutto, procede in automatico, non può essere battuto e non è possibile uscirne, bisogna soltanto rigare dritti e pregare di non finire presi dal settore del Sistema addetto alla repressione.
Tutti i detenuti dovevano passare attraverso un processo senza avvocato davanti a una corte militare, che a volte durava soltanto un minuto e non ammetteva ricorsi. I giudici militari, secondo la legge, potevano procedere senza tenere conto della legge. La sentenza passava al ministero della Difesa e doveva essere controfirmata dal ministro o dai suoi aiutanti. Poi era trasmessa di nuovo al carcere. Ci metteva due settimane a fare questo giro.
La sera delle esecuzioni arrivavano tre rappresentanti del ministero, assieme al direttore di Sednaya. Ogni detenuto doveva firmare un modulo prima dell’esecuzione, e gli veniva chiesto quale fosse il suo ultimo desiderio: ma era una formula senza senso perché nessuno aspettava davvero una risposta. Ma ancora, a quel punto, il detenuto non sapeva come sarebbe stato ucciso e quanto tempo avesse ancora. Mancavano pochi minuti, ma non ne era consapevole.
Nel 2023, in cambio della riammissione nella Lega araba, il regime siriano accettò fra le altre cose di eliminare i tribunali militari, ma le esecuzioni sono continuate.
Dopo le impiccagioni di massa gli assadisti caricavano i corpi su camion e li portavano all’ospedale militare Tishreen di Damasco. Lì si compilavano dei certificati di morte vaghi, con due sole cause di morte: «il detenuto ha smesso di respirare» o «il cuore del detenuto ha smesso di battere». Ogni morto era fotografato, con il suo numero scritto a pennarello sulla fronte, ma i documenti con le foto restavano negli archivi militari e non c’erano quasi mai comunicazioni alle famiglie.
Un soldato addetto a fotografare i morti a un certo punto aveva salvato su alcune schede di memoria migliaia di file. Aveva fatto in modo di portare la sua famiglia all’estero e poi era scappato in Francia con l’aiuto dell’intelligence francese. Il suo nome in codice era Caesar, alla francese. Soltanto adesso ha rivelato la sua vera identità. I suoi file sono una delle prove di come funzionava il sistema di repressione assadista.
Nelle foto si vede che a volte i corpi tra un trasporto e l’altro da Sednaya erano accatastati in uno spazio all’aperto dentro al perimetro dell’ospedale. Dal palazzo del presidente Assad sul monte Qassioun, che domina su tutta Damasco e dal quale era possibile vedere la vita apparentemente normale nel centro della capitale, era possibile osservare anche l’ospedale Tishreen. Durante gli anni della guerra civile, fino al 2018, si potevano vedere in lontananza le colonne di fumo dei bombardamenti alzarsi dai sobborghi ribelli dell’hinterland di Damasco, come Daraya, Zemalke e Douma.

La prigione di Sednaya vista dall’alto (Ammar Awad/Reuters)
Il carcere è formato da due edifici. Il cosiddetto edificio rosso ha un corpo centrale massiccio dal quale partono tre rami di lunghezza uguale, alti tre piani, e in questi rami ci sono i corridoi con le celle. Nel corpo centrale c’è una scala a chiocciola, protetta da un’inferriata, che permetteva alle guardie di salire e scendere. A cinque minuti a piedi c’è l’edificio bianco, dove erano rinchiusi altri prigionieri, di solito i militari. Al pian terreno ci sono le munfaridat, le celle d’isolamento: c’è una porta di metallo nero che blocca la luce, pareti, pavimento e soffitto in cemento liscio e dentro lo spazio sufficiente a sdraiarsi in diagonale.
Il padre di Bashar al Assad, Hafez al Assad, costruì il carcere alla fine degli anni Ottanta per i suoi militari. Il regime di Hafez era nato grazie a un colpo di stato militare e lui aveva paura che altri militari potessero fare lo stesso.
Poi Sednaya è diventata una prigione speciale per gli estremisti islamici. All’inizio dell’invasione americana in Iraq, nel 2003, il regime incoraggiò molti siriani ad andare a combattere assieme ai gruppi terroristici iracheni. Qualche anno dopo i siriani che erano partiti volontari tornarono con la testa piena di idee estremiste e una grande esperienza nella guerriglia. Per evitare che cominciassero a combattere in casa come avevano fatto in Iraq, il regime li imprigionò.
Poi nel maggio 2011, quando iniziarono le proteste in Siria contro il regime, Assad decise di liberare tutti gli estremisti di Sednaya. Le proteste e le ribellioni dei siriani nelle piazze di tutte le città erano cominciate da poche settimane e il regime aveva bisogno di spazio. Inoltre rimettere in libertà gli estremisti voleva dire cambiare la direzione delle rivolte, che erano viste con simpatia in Occidente, e facilitare il sorgere di gruppi islamisti. Lo spazio lasciato vuoto dentro Sednaya fu riempito dagli oppositori della società civile.
– Leggi anche: Breve storia della guerra civile in Siria
Fuori da un ramo del carcere Hassan Mohamed cerca suo figlio, catturato nel 2013 quando aveva diciassette anni a Homs dopo una manifestazione e sparito da allora. Dice che è stato preso «soltanto perché cantava che il presidente doveva smettere di fare il presidente. A voi in Italia, in Francia, negli altri paesi: a voi succede questa cosa?».