Anonima calligrafi
«Le mie lettere avevano qualcosa che non andava: troppo rudi, approssimative, irregolari e senza ritmo. Avevo cercato online la parola “calligraphy” per tentare di correggerle. Cinque ore dopo ero ancora davanti allo schermo, a guardare video di calligrafia su YouTube. Ho iniziato così, da autodidatta, accumulando tecniche e conoscenze casuali per quasi tre anni. E poi la mia fidanzata mi ha fatto un regalo. Altri sette anni, decine di corsi, centinaia di blocchi e migliaia di penne dopo, continuo a studiare e praticare. Ho dedicato alla calligrafia una quantità di soldi, tempo, energia, passione e ore di sonno che fa impallidire qualunque altra passione. E in cambio non ci ho ancora guadagnato manco di riuscire a scrivere bene la lettera “u”»

altre
foto
È il 17 ottobre del 2017 e sono seduto a un tavolo nello scantinato di uno studio di tatuatori, ho in mano un portapennino obliquo che fino al giorno prima non avevo mai visto dal vero e sto macchiando di inchiostro un foglio di carta costosissimo. La mia presenza in questo scantinato è dovuta a un regalo di compleanno della mia fidanzata: un corso di due giorni di corsivo inglese per principianti, con un’insegnante di nome Barbara Calzolari. È il mio primo corso di calligrafia. È il mio primo corso, a dire il vero, di qualunque cosa da quando mi sono laureato. La mia compagna di tavolo è una barista in lacrime. Ha una decina di anni meno di me e si è iscritta per imparare a scrivere i menu sulle lavagne del bar, ma non riesce a eseguire nulla di quello che vede fare all’insegnante.
Conosco quel senso d’impotenza, ben illustrato dalle patacche d’inchiostro sul mio foglio; reagisco con più aplomb, ma la capisco. Alla mia sinistra, una signora quasi settantenne coi capelli cotonati sta sussurrando qualche segreto a un tizio di trent’anni con una ragnatela tatuata sul cranio rasato, anche lui in difficoltà. Lei è una pensionata che sbarca il lunario realizzando partecipazioni a matrimoni e biglietti d’auguri, lui ha uno studio di tatuaggi in una città vicina. Non riesco a immaginare nessun altro contesto in cui queste due persone possano stare sedute a fissare lo stesso foglio, una accanto all’altra, con quest’aria di complicità. C’è un clima ovattato, una specie di silenzio che (se non udissi le bestemmie sussurrate dal tatuatore) definirei monastico. È una specie di tensione condivisa, con un sottofondo musicale tutt’altro che disprezzabile – downbeat, IDM, dreampop e roba così. Gli insegnanti di calligrafia, imparerò, sono abbastanza adamantini sulle loro scelte musicali. Dicevo, cosa sono venuto a fare qui?
Per semplificare, direi che questo è il luogo in cui si vanno a schiantare tre anni di frustrazione e studi infruttuosi. Tutto è iniziato una sera dell’autunno del 2014. Davanti a me c’era un foglio bianco, su cui avevo disegnato il corpo di una ragazza con un pennarello nero. Disegnare è sempre stato uno dei miei principali passatempi, ma in quel momento stavo attraversando una sorta di fase Roy Lichtenstein e cercavo di aggiungere testi alle immagini, a mo’ di fumetto. Ma le mie lettere avevano qualcosa che non andava: troppo rudi, approssimative, irregolari e senza ritmo. Avevo cercato online la parola “calligraphy” per tentare di correggerle. Cinque ore dopo ero ancora davanti allo schermo, a guardare video di calligrafia su YouTube: strumenti mai visti che scorrevano su fogli immacolati, l’inchiostro che fluiva in maniere che di volta in volta erano controllatissime o piene di schizzi, lettere perfette che comparivano lentamente sui fogli, accompagnate da canzoni strumentali di quelle che hanno fatto la fortuna di Ludovico Einaudi. Forse non era la prima volta che vedevo un maestro calligrafo mostrare la sua arte, ma mi sentivo come se per me, fino a quella sera, quella cosa non fosse semplicemente mai esistita.
Avevo passato ore, e poi giorni, cercando di, non so, imparare la calligrafia. Non sapevo da dove iniziare, ma per qualche motivo, in quei giorni, sentivo di dover diventare bravo a scrivere a mano. Avevo tirato fuori fogli e pennelli e provato a ritracciare su un foglio di carta gli stessi segni che vedevo in quei video: un disastro assoluto, mai visto niente di così brutto. Nelle lettere che comparivano sui miei fogli c’era qualcosa di inguardabile, di orrendo. Per qualche motivo, questo non mi aveva scoraggiato.
Com’è possibile che io non sia in grado di scrivere una normalissima lettera “u”? Riproviamo un altro paio di mila volte. Ho iniziato così, da autodidatta, accumulando tecniche e conoscenze casuali per quasi tre anni. E poi la mia fidanzata mi ha fatto un regalo. Altri sette anni, decine di corsi, centinaia di blocchi e migliaia di penne dopo, continuo a studiare e praticare. Ho dedicato alla calligrafia una quantità di soldi, tempo, energia, passione e ore di sonno che fa impallidire qualunque altra passione. E in cambio non ci ho ancora guadagnato manco di riuscire a scrivere bene la lettera “u”.
La calligrafia è, semplificando molto, l’arte dello scrivere. Tutti sanno che la parola deriva dal greco e significa “bella scrittura”, ma nell’uso comune il suo significato è esteso alla scrittura manuale in generale, e quindi si parla comunemente di “brutta calligrafia”, e quindi di “brutta bella scrittura”. Intorno a questa banalità si costruisce un paradosso eccitante della calligrafia, un intero universo cognitivo: ognuno di noi ha passato anni e anni a imparare a scrivere, dedicando alla calligrafia più tempo di quello che ha dedicato a qualunque altra tecnica espressiva, e tutti abbiamo sviluppato uno stile personale che ci definisce tanto quanto i nostri tratti somatici; al contempo, quasi nessuno in Occidente la riconosce davvero come una forma d’arte.
Anche la persona meno interessata alla pittura di questo paese ha sentito il nome di Pablo Picasso; se chiedessi a cento persone il nome di un maestro calligrafo del passato o del presente è probabile invece che non risponderebbero in più di sette o otto. Di tanto in tanto è possibile trovare interviste a maestre e maestri calligrafi su quotidiani e riviste, di solito nel contesto di articoli introduttivi di riscoperta; quasi sempre alla persona intervistata viene fatta una domanda sul senso della calligrafia. «Ha ancora senso scrivere a mano nell’epoca dei computer e dei font?»
Immaginatevi un cronista sportivo che intervisti Tadej Pogačar e gli chieda che senso abbia continuare ad andare in bicicletta. Insegnanti e artisti hanno imparato un modo educato e funzionale di rispondere, citare certi studi di pedagogia o l’amore per ogni forma di artigianato; il tono della risposta è parte organica di un sistema di pensiero a cui chi studia calligrafia da una vita ha fatto l’abitudine, e contro cui – a certi livelli – combatte da tutta la vita. Basti pensare alla questione didattica: chi insegna alle elementari non è tenuto a imparare la corretta grafia prima di insegnarla. Gli istituti possono organizzare corsi di aggiornamento per il personale docente, tenuti da specialisti e (a volte) anche da nomi di spicco della calligrafia italiana; ma spesso questo non avviene e lo studio dei fondamentali della calligrafia è lasciato a chi insegna senza che venga fatta loro una formazione precisa.
Il risultato può essere un percorso accidentato e a volte traumatico, anche per gli alunni e le alunne. Una cosa che ho imparato io per primo: per tutta la scuola dell’obbligo sono stato spesso corretto, ripreso e a volte punito per la scarsa qualità della mia grafia, oggettivamente inferiore rispetto alla media della mia classe, in un’epoca in cui concetti come la disgrafia erano molto di là da venire.
La mia generazione, intendo i nati alla fine degli anni Settanta, ha avuto una prospettiva privilegiata in questo: quelli venuti dopo hanno inglobato computer e telefonini in tenera età, quelli venuti prima possono vivere la loro vita senza doversi preoccupare di imparare a digitare su una tastiera. Noi abbiamo dovuto affrontare un cambio di paradigma. Per quanto mi riguarda, la scoperta di Microsoft Word ha avuto il sapore di un’amara rivalsa, un po’ tipo finale di Barry Lyndon (“They’re all equal now”): le lamentele dei miei insegnanti erano diventate improvvisamente vuote e inutili. Nel mondo di oggi perfino le ricette dei medici (quello a cui tutti pensiamo quando si parla di “brutta calligrafia”) arrivano sul fascicolo sanitario elettronico e non siamo più tenuti a meravigliarci che il farmacista capisca cosa c’è scritto sul foglio.
È in questo contesto che nasce quel millenarismo di cui ci arriva qualche eco di tanto in tanto: studiosi e politici che auspicano di tagliare ore che oggi si passano ad insegnare a scrivere a mano, per introdurre corsi base di informatica. Ma per certi versi è da questo ideale apocalittico che, a sua volta, lo studio della calligrafia è risorto dalle sue ceneri. Forse questa percezione diffusa di non-necessità ci ha spinto ad immaginare un mondo senza scrittura a mano; qualcuno non ha gradito quel mondo e ha deciso di costruirne uno diverso.
Lo studio della calligrafia può essere guardato anche come un percorso all’indietro sulla via che ti ha portato alla tua scrittura, quello stile personale di cui si parlava sopra. Ti porta a cercare un ideale momento nel passato in cui hai iniziato a infrangere le regole e creato la tua grafia, invece che continuare a seguirle e diventare un calligrafo. Iscriversi a un corso serve anche a questo: mettere in dubbio e disimparare alcuni punti fermi della tua manualità, correggere centinaia di “errori” che si sono sedimentati nella tua memoria muscolare.
Tra le prime cose che Calzolari mi ha fatto notare c’è che, a pochi giorni dal mio quarantesimo compleanno, non ero in grado di tenere in mano una penna in modo corretto. Ho poi scoperto, per questioni legate all’educazione dei miei figli, di possedere quella che gli specialisti di settore chiamano impugnatura a mantide, un modo istintivo di avvolgere le dita attorno a matita e penna che nessun insegnante ha mai corretto. Per un adulto non è un grosso problema: si scrive come si è imparato a farlo e senza correggere l’impugnatura. A meno che non ci si metta in testa di imparare il copperplate, il corsivo inglese a punta sottile. Alla fine della prima giornata di corso sono tornato a casa distrutto, con fitte lancinanti a muscoli della mano e dell’avambraccio che non sospettavo nemmeno di avere, e, più di ogni altra cosa, il bisogno implacabile di sedermi al tavolo e ricominciare a tracciare ovali per il resto della notte.
Da allora ho continuato a studiare e frequentare corsi. Vivo la calligrafia con un atteggiamento adolescenziale: è la cosa che faccio, e quindi voglio farla sempre. La mia famiglia mi sopporta con l’eleganza e il non-biasimo che mi aspetto da loro. La mia fidanzata sa che se non riesco a fare almeno un’ora di pratica mi sento di aver vissuto invano quella giornata. Tengo sempre con me un piccolo set di strumenti per esercitarmi: blocchi, penne, pennelli, colori e inchiostri. Scrivo sulle tovagliette di carta dei ristoranti, scrivo nelle sale d’attesa di uffici ed ambulatori, scrivo mentre risolvo problemi al telefono in ufficio. L’impatto della calligrafia ha sconvolto il mio quotidiano in maniera irreversibile: non guardo più film o serie TV, leggo molto meno di un tempo, non discuto quasi più di musica sui social. Ascolto molti più dischi, questo sì – la musica accompagna sempre gli esercizi, aiuta con il ritmo e i pattern, toglie un po’ di peso alla testa. Ma quasi tutti gli altri bisogni culturali che consideravo una parte fondamentale del mio essere sono semplicemente scomparsi, sostituiti dal desiderio di saper tracciare una S maiuscola decente con un pennello a punta piatta.
Guardo con attenzione tutte le lettere a mano che vedo scritte nel mondo vero. Butto un occhio alle liste della spesa nei carrelli accanto al mio, controllo i biglietti sul banco del bar e i menu scritti sulle lavagne – perizio i risultati, cerco imperfezioni, prendo nota di alcune variazioni inaspettate di certi corsivi, mi prendo il tempo per ripeterle e reinterpretarle. Questa voracità un po’ autodistruttiva è un tratto comune a molti studenti di calligrafia. Il senso di frustrazione generato dalla mole di conoscenze e abilità che non possediamo ci rende parte di un informale gruppo di ascolto con il quale abbiamo poche possibilità di interagire nel mondo reale. Le persone con cui condividiamo questa passione sono dislocate in giro per il territorio, e quelli che come me vivono in città da centomila abitanti incontrano gli altri quasi solo in occasione di corsi, workshop e giornate a tema.
La più importante associazione che si occupa di calligrafia nel nostro paese è l’ACI, Associazione Calligrafica Italiana, fondata a Milano nel 1991 da sei soci: Anna Ronchi, Giovanni De Faccio e la moglie Karin Weichselbaumer, Francesco Ascoli, Anna Schettin e James Clough, persone che provenivano da esperienze diverse, ma avevano questa passione comune. L’eterogeneità del parco studenti è la prima cosa di cui ci si accorge quando si entra nel giro. La signora cotonata e il tatuatore con la ragnatela sono l’assoluta normalità, e in generale la fauna umana è abbastanza variopinta da poterci scrivere tre o quattro stagioni di una buona sitcom. Non è infrequente iscriversi a un corso di capitali romane a pennello per principianti e trovarsi al banco assieme a un maestro internazionale – il numero di aneddoti che può raccontarti compensa la grandissima frustrazione che genera vederlo all’opera. Calzolari mi ha raccontato di aver avuto come studente Vincent Connare, l’inventore del Comic Sans (ovvero il carattere tipografico che più di tutti, negli anni Novanta, sembrava essere sul punto di rimpiazzare la scrittura a mano).
Francesca Biasetton, presidente dell’ACI e insegnante dal 1997, racconta di un’anomalia tutta italiana: l’età anagrafica degli studenti. Ai corsi in Italia è facile vedere studenti sotto i venti o trent’anni, una cosa che notano molti maestri stranieri che vengono a insegnare. Forse la ragione è anche il successo della principale star della calligrafia nazionale, Luca Barcellona, rapper/dj/writer attivo nella scena hip hop fin dai primi anni Novanta col nome di Lord Bean, oggi calligrafo di fama mondiale (che tra l’altro cura la calligrafia e lettering in gran parte dei titoli di dischi hip hop in commercio oggi in Italia). È lui stesso a registrare la differenza di pubblico tra oggi e gli inizi: «negli anni Novanta ai workshop ero l’unico sotto i vent’anni. C’erano giornalisti, appassionati di manoscritti antichi, scrittori, qualche grafico, persino chi faceva incisioni funerarie. Il clima era decisamente più austero. Oggi invece è normale vedere writer, tatuatori e artisti a un workshop di scrittura gotica». L’altra forza dirompente che ha segnato lo spartiacque tra due epoche è stata ovviamente internet: la calligrafia spopola su social come Instagram, in cui alcuni praticanti arrivano in tranquillità alle centinaia di migliaia di follower.
Come per ogni altra cosa che succede su Instagram, non è detto che quelli con più seguito siano i migliori, e questo causa spesso qualche grattacapo ai corsi – soprattutto maestri e maestre con lunga esperienza raccontano di problemi di comunicazione con certi neofiti, dovuta al fatto che una maggior esposizione non si sia portata necessariamente dietro una maggior curiosità verso la tradizione calligrafica e il lavoro dei padri fondatori, né tantomeno su cosa comporti in termini di tempo e dedizione iniziare un percorso di studio. Sarebbe una questione di lana caprina, ma questa mancanza di coscienza ha contribuito a scavare il solco ideologico tra i due principali approcci di chi studia oggi.
Da una parte c’è quella che potremmo chiamare calligrafia classica, che comprende tutti gli stili che possono essere identificati come tradizionali: corsivo inglese, corsivo americano, blackletter, onciale, cancelleresca, italico, spencerian e tantissimi altri. La definizione di “bello” legata a questi stili equivale all’idea di “bello” di tutti gli approcci tradizionali all’arte, e ognuno di essi viene studiato sulla base di una tradizione spesso millenaria (la forma compiuta delle maiuscole romane, che sono un po’ il Sacro Graal della calligrafia, è ancora l’epigrafe alla base della Colonna Traiana). Ma il fatto che abbiano una storia così lunga non significa che non si tratti di stili che vivono e prosperano nel presente, in usi molto più quotidiani di quello che potrebbe sembrare nell’epoca dei font: bottiglie di vino, insegne di negozi, biglietti d’auguri, logotipi, partecipazioni, certificati di laurea, tatuaggi, cartigli. Per ognuno di questi stili ogni maestro rimane studente a vita, inseguendo un ideale di mastering, di padronanza, che ha sempre margini di miglioramento. Nessuno ha mai assaporato quel genere di sazietà, la coscienza di essere arrivato alla fine del percorso, ma ogni nuova lettera tracciata sul foglio è un altro centimetro percorso lungo la strada, e il miglioramento nutre l’illusione di poter arrivare un giorno alla perfezione assoluta, un buon carburante per proseguire lungo il cammino (mi rendo conto che l’ultimo capoverso sembri un diluvio di retorica new age, ma del resto la calligrafia classica è spesso praticata copiando aforismi e citazioni dal peso specifico inaffrontabile). Dall’altra c’è quella che molti chiamano calligrafia moderna, definizione-ombrello piuttosto approssimativa e detestata sia da chi la pratica che – soprattutto, direi – da chi pratica calligrafia classica.
Nelle sue forme più illuminate questa branca segue un percorso ideologico simile a quello di tutte le arti figurative nel passato recente, e quindi molto spesso è calligrafia che ha poco a che fare con la leggibilità e le regole, e molto a che fare con la scrittura come espressione di personalità – che quindi si distacca dai canoni. Viene spesso praticata su superfici inusuali, con strumenti inusuali e inchiostri inusuali, come nel lavoro di Brody Neuenschwander, forse l’intellettuale più in vista di questo microcosmo. Ha sempre più a che fare con le teorie/pratiche di scrittura asemica che hanno tenuto banco nel secolo scorso, e ruba spesso elementi da calligrafia orientale, performance art ed espressionismo astratto (nomi come Franz Kline e Mark Tobey sono ideali padri putativi di questo approccio), oltre che ovviamente il writing. Tra l’approccio classico e quello moderno è in corso una piccola scaramuccia ideologica. Entrambi possono fare affidamento su maestri dalla reputazione inossidabile, ed entrambi possono recriminare qualcosa sui lati negativi dell’approccio opposto – troppo passatisti gli uni, troppo approssimativi e anarchici gli altri. È uno scontro bonario: i lavori interessanti tradiscono in entrambi i casi una ricerca e uno studio enormi. Nel momento in cui si entra a far parte della comunità, si riconoscono alle controparti più i pregi e le qualità espressive che i difetti.
Internet si è inserita in questo contesto con una brutalità che ha scosso l’ambiente. È diventato possibile tenere corsi online, che da una parte riducono i costi e aumentano a dismisura le occasioni di frequentare, ma che rispetto a un corso in presenza tolgono ossigeno al senso di comunità che ha animato la scena fino a qui. L’aumento dell’interesse ha portato a un aumento dei clienti, ma molti insegnanti riconoscono che anche tra i committenti non sono in tantissimi a distinguere un buon calligrafo da un calligrafo mediocre ma con molto seguito, e che spesso sono favoriti i secondi. Di solito ci si affida a un processo di selezione naturale: non sono i fotografi improvvisati di Pinterest a togliere il lavoro a David LaChapelle, ma d’altra parte i LaChapelle della calligrafia non sono particolarmente richiesti dal mercato. In questo lo studio dell’arte calligrafica sta vivendo una fase adolescenziale che è piuttosto eccitante: sta diventando una cosa diversa da quel che è sempre stata, nessuno è davvero in grado di prevedere cosa sia; qualcuno è spaventato, qualcun altro non vede l’ora.
In questi giorni, in ogni caso, la mia passione per la calligrafia compie dieci anni. Ho imparato qualche cosa ma mi sento ancora al piano terra di un edificio di un milione di piani. La mia percezione del mondo è cambiata: dove prima vedevo case e negozi ora vedo scritte, cartelli, lavagne, iscrizioni, dorature e sign painting. Continuo a tracciare lettere sui fogli, bilancio l’impazienza di arrivare un giorno a tracciare le prime lettere decenti con la pazienza accumulata con milioni di lettere orrende. Il numero di ore di sonno che ho sacrificato alla causa dell’italico e del copperplate è incalcolabile, e in cambio non ho ancora ottenuto una singola “u” minuscola che possa mostrare al prossimo senza vergogna. Probabilmente non ci arriverò mai, ma il viaggio è suggestivo e mi ci imbarcherei altre diecimila volte. Non sono mai riuscito a sistemare le parole in quel disegno – lo conservo ancora, sai mai che un giorno mi senta pronto a metterle giù.
(E comunque ho fatto questo:)
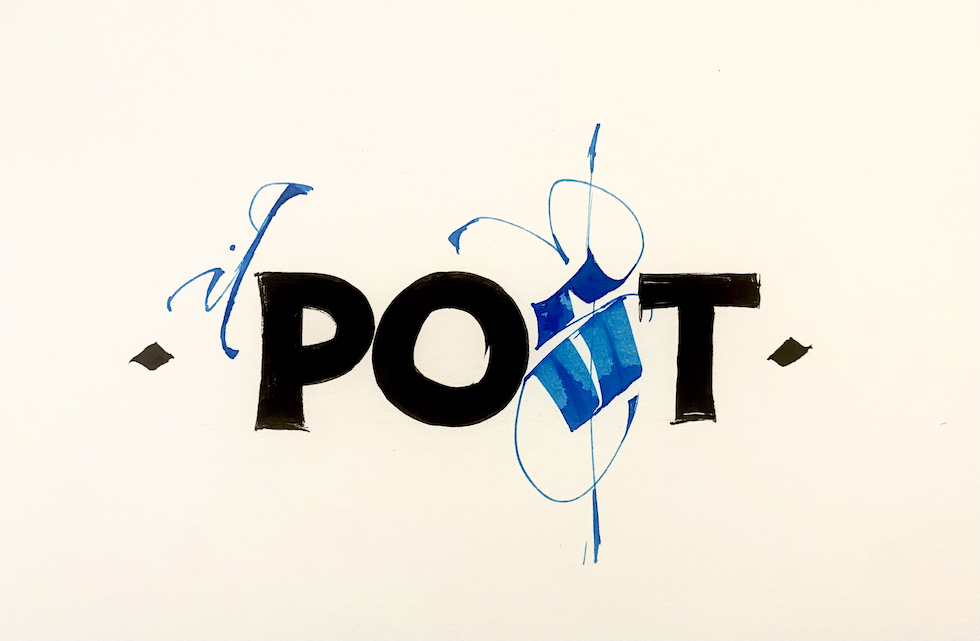
(Francesco Farabegoli)
– Leggi anche: Com’è una gara di calligrafia giapponese



















