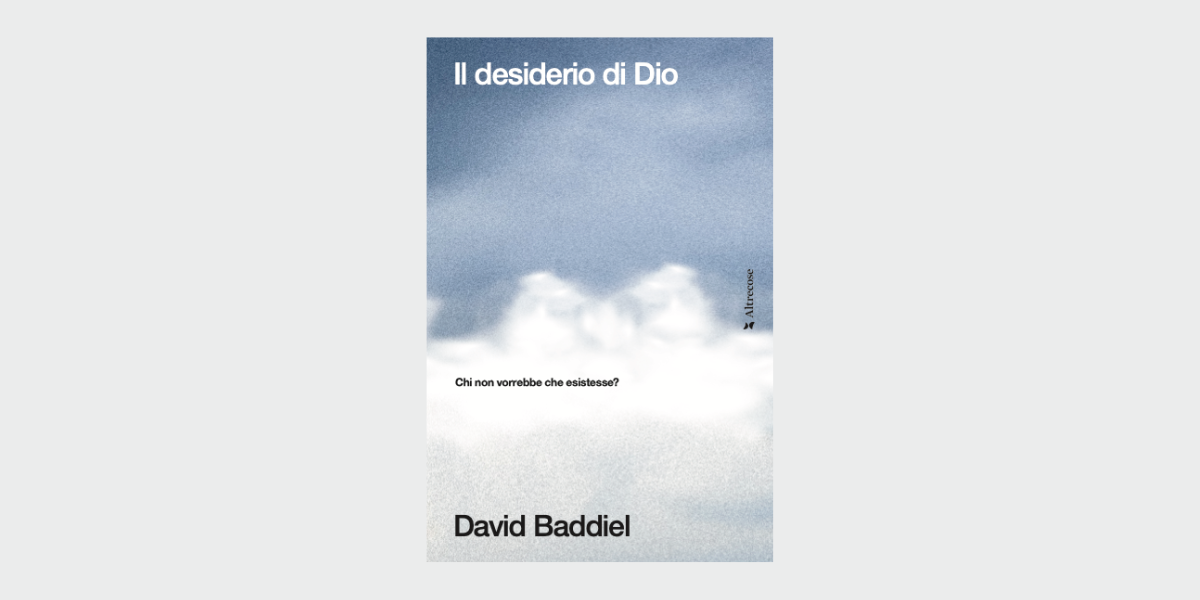I tempi critici ispirano nuove idee?
Secondo una lunga tradizione di pensiero, periodi di avversità e forti spinte conservatrici possono favorire riflessioni, prospettive e modelli alternativi

La vittoria del candidato Repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi è stata preceduta da lunghe campagne politiche e mediatiche in parte incentrate sulle conseguenze prevedibili di un suo eventuale successo sulla tenuta delle istituzioni e della democrazia. Una delle prime interpretazioni del risultato elettorale è che rifletta, come in altri paesi del mondo, il desiderio di uno stile di governo autoritario: «una conquista del paese non con la forza, ma con un permesso», l’ha definita la giornalista del New York Times Lisa Lerer.
Un’altra interpretazione, citata dal giornalista Ezra Klein, è che la percezione delle politiche dell’amministrazione del presidente Joe Biden sia stata pesantemente condizionata dagli effetti della pandemia, dell’inflazione e di altri fattori critici sovranazionali. Una conferma di questa teoria, secondo Klein, sarebbe il fatto che le amministrazioni in carica tra il 2021 e il 2022 in altre parti del mondo, sia di destra che di sinistra, hanno poi perso o straperso le elezioni.
Secondo diverse interpretazioni la vittoria di Trump non sarebbe quindi un fatto straordinario: certificherebbe anzi uno status quo in molti paesi accomunati da un’apparente incapacità di superare le crisi globali esistenti e dalla tendenza a cercare di risolverle applicando schemi e modelli noti, e assecondando spinte reazionarie. Quello di Trump sarà del resto il suo secondo mandato, dopo quello concluso tumultuosamente all’inizio del 2021: cosa che rende Trump stesso non più un’«aberrazione» o una deviazione, ma la normale estensione degli attuali orientamenti politici ed economici, ha detto Lerer, riprendendo peraltro un concetto espresso nel 2017 dalla giornalista e attivista canadese Naomi Klein nel libro Shock Politics.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle analisi del voto, il risultato delle elezioni statunitensi potrebbe contribuire ad accrescere – quantomeno in una parte significativa della popolazione, non soltanto statunitense – l’impressione di una sostanziale crisi dei modelli politici esistenti: una crisi tra altre crisi. Nel 2022, prima degli sviluppi più recenti della crisi in Medio Oriente, lo storico inglese Adam Tooze aveva utilizzato e reso popolare la parola «policrisi» per definire le complesse relazioni tra l’economia mondiale, la pandemia, il cambiamento climatico, la guerra tra Russia e Ucraina, e varie altre crisi capaci – proprio perché intrecciate tra loro – di provocare danni mondiali maggiori della somma dei danni che provocherebbero individualmente.
– Leggi anche: Adam Tooze e i suoi “Tooze Boys”
Riprendendo riflessioni di storici, economisti e filosofi del XIX e del XX secolo, diversi studiosi e ricercatori negli ultimi anni si sono chiesti se periodi di avversità e minacce globali interconnesse siano considerabili come parte di processi storici ciclici e, nello specifico, una premessa necessaria per la formazione di nuovi approcci, nuove idee, nuove prospettive e spinte positive. La parola stessa “crisi” ha una connotazione non per forza negativa, sia etimologicamente (deriva dal verbo greco κρίνω, che significa “separare”, “decidere” in un momento cruciale), sia per come si è evoluto nel tempo il concetto che esprime.
Lo storico svizzero Jacob Burckhardt, tra i più importanti del XIX secolo, attribuì alla crisi una duplice connotazione, sia negativa che positiva, descrivendone la capacità di accelerare lo sviluppo storico e di determinare cambiamenti radicali. Per una serie di convegni da lui tenuti a Basilea tra il 1870 e il 1871 scrisse che «le crisi e persino i fanatismi che le accompagnano» dovrebbero essere considerati «genuini segni di vitalità» e prove dell’esistenza di cose che le persone «apprezzano più della vita e della proprietà». I grandi sconvolgimenti della storia, aggiunse, possono «sgombrare il terreno» da idee e istituzioni decadenti.
Nelle riflessioni del filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la percezione se non proprio della crisi quantomeno della fine di una certa realtà storica è il presupposto necessario per comprenderla. La filosofia, scriveva, è infatti possibile «soltanto dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s’è bell’e assestata». Per il filosofo tedesco Karl Marx, coetaneo di Burckhardt, le crisi economiche, politiche e sociali ricorrenti sono ciò che permette di cogliere le contraddizioni del capitalismo, di cui sono non un effetto disfunzionale ma una parte necessaria e inevitabile tanto quanto lo sfruttamento del lavoro.
La principale difficoltà nell’interpretazione della storia nel suo insieme, inclusi i suoi avvallamenti, è che la coscienza storica muta con la storia, scriveva nel libro Origine e senso della storia il filosofo e psichiatra tedesco Karl Jaspers. Ma è indubbio che, considerandolo come una successione di eventi, «il passato ha cime e valli nel suo significato. Ci sono epoche tranquille che sembrano contenere ciò che sarà per sempre, e che si sentono definitive. E ci sono epoche di svolta in cui avvengono rivolgimenti che, nel caso estremo, sembrano toccare le radici dello stesso essere-umano».
– Leggi anche: Sta tornando la storia?
Nel 2023 Jerome Roos, ricercatore olandese in economia politica internazionale alla London School of Economics (LSE), citando autori come Burckhardt e Jaspers scrisse sul New York Times che per comprendere la natura complessa del nostro tempo è necessario prima di tutto accoglierne «il suo aspetto più terrificante»: l’incertezza radicale, non sapere dove siamo e cosa ci aspetta.
Una delle più citate situazioni di crisi e di emergenza, secondo diversi esperti mitigabile solo attraverso decisioni drastiche che tardano ad arrivare, è la crisi climatica. Per descriverne da un lato la gravità e dall’altro l’apparente indifferenza umana rispetto alle conseguenze più imminenti, l’economista statunitense Nathan John Hagens la raccontava così in un articolo pubblicato nel 2020 sulla rivista Ecological Economics:
Un gruppo di scimmie mediamente intelligenti ed estremamente socievoli ha forzato un barattolo di biscotti pieno di energia fossile e sta dando una festa da 150 anni. Le condizioni della festa sono incompatibili con le realtà biofisiche del pianeta. La festa sta per finire, e quando arriverà il giorno saranno imposti cambiamenti radicali al nostro stile di vita.
Per Hagens ci stiamo rapidamente avvicinando a un punto di svolta critico: quando il divario tra il denaro che si accumula nel sistema finanziario e le risorse fisiche del pianeta ricavabili in modo sostenibile sarà diventato troppo ampio. Affinché la crisi, come ogni altra crisi, porti a un cambiamento fondamentale delle politiche servono però condizioni particolari.
Secondo il filosofo australiano Roman Krznaric, autore del recente libro History for Tomorrow: Inspiration from the Past for the Future of Humanity, il contesto più comune in cui i governi attuano risposte efficaci alle crisi è durante la guerra. Cita l’esempio degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale, che dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor nel 1941 avviarono una profonda ristrutturazione dell’economia per entrare in guerra.
La produzione di auto per il mercato privato fu interrotta, nonostante la feroce opposizione dell’industria, e i rifornimenti di carburante razionati settimanalmente. Il presidente Franklin Delano Roosevelt autorizzò l’introduzione di un’imposta federale sul reddito, la cui aliquota massima sarebbe salita al 94 per cento nel 1944. E il governo contrasse numerosi prestiti, per sostenere spese che furono maggiori tra il 1942 e il 1945 che nei 150 anni precedenti. «E tutto questo in una delle economie di libero mercato più ipercapitaliste della storia umana», mentre il paese si alleava peraltro con un acerrimo paese nemico, l’Unione Sovietica: «Di fronte alla crisi, il libro delle regole politiche fu buttato fuori dalla finestra».
– Leggi anche: Produrre sia pianoforti sia motociclette
Un’altra situazione in cui i governi tipicamente tendono ad adottare misure drastiche, secondo Krznaric, è in seguito a una catastrofe. Dopo una devastante inondazione provocata dal mare del Nord nel 1953, che causò la morte di oltre 1.800 persone, il governo olandese avviò il Piano Delta, un programma di costruzione di opere pubbliche per proteggere il paese da futuri rischi di alluvione. Fu uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi del XX secolo, con un costo pari a oltre il 20 per cento del PIL dell’epoca.
Tra i più recenti, la pandemia è un altro esempio citato di crisi in grado di sviluppare approcci per molti aspetti rivoluzionari e, in certi casi, destinati a durare. Un evento che ha ucciso milioni di persone nel mondo e ha quasi portato al collasso economico, scrisse Roos sul New York Times, ha anche di fatto favorito nuove prospettive nel mondo del lavoro e aumentato la spesa pubblica per lo sviluppo di vaccini di nuova generazione, basati sull’RNA messaggero (mRNA), che potrebbero migliorare la ricerca delle cure contro il cancro.
Esistono poi contesti che Krznaric definisce di «rottura» (disruption), meno sconvolgenti rispetto a disastri, guerre e rivoluzioni, ma comunque in grado di determinare trasformazioni sostanziali delle politiche dei governi. Sono momenti di instabilità del sistema prodotti dalla combinazione di tre fattori interconnessi: un qualche tipo di crisi, meno estrema di una guerra o di un disastro, unita a movimenti sociali dirompenti e nuove idee.
I movimenti sono fondamentali nei processi storici perché in genere amplificano crisi che potrebbero altrimenti essere ignorate da altre parti della società. Nel libro del 2014 Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Klein scrisse che solo un movimento sociale avrebbe permesso al cambiamento climatico di diventare una crisi «degna di una risposta al livello di un piano Marshall». In quel caso la politica dovrebbe reagire sia rendendo disponibili le risorse per affrontare la crisi, sia piegando regole del libero mercato che possono essere più o meno flessibili a seconda degli interessi in gioco.
Riprendendo gli spunti di Klein, Krznaric cita come esempio storico di «rottura» gli eventi che portarono all’abolizione graduale della schiavitù nelle colonie dell’Impero britannico, con l’approvazione dello Slavery Abolition Act nel 1833. Già nei primi anni di quel decennio estese rivolte guidate dagli agricoltori inglesi, che protestavano per i salari bassi e le dure condizioni di lavoro, avevano creato condizioni di instabilità sociale. E l’abolizione della schiavitù nelle colonie nel mar dei Caraibi era già da anni l’obiettivo di un gruppo di attivisti e riformisti.
Ad avviare i processi di trasformazione degli statuti fu però a Natale del 1831 una rivolta di oltre 20mila schiavi in Giamaica, che guidati dal predicatore Samuel Sharpe incendiarono centinaia di piantagioni. Fu repressa all’inizio del 1832 dalle milizie della guarnigione britannica e del governo dei proprietari terrieri della colonia, ma aggravò una crisi politica esistente nell’establishment britannico, che a quel punto vide nell’abolizione della schiavitù l’unico modo per non perdere il controllo delle colonie.
Allo stesso modo, scrive Krznaric, il suffragio universale in Finlandia – primo paese in Europa a introdurlo, nel 1906 – fu preceduto da una serie di eventi concomitanti e da un movimento fondamentale, che si era costituito fin dal 1899 nel Partito socialdemocratico finlandese (SDP) e includeva diversi gruppi operai e associazioni femminili. Uno sciopero generale nel novembre del 1905 e una rivolta contro l’imperialismo russo nel paese avevano creato le condizioni di una crisi politica che il movimento femminile finlandese aveva aggravato, organizzando oltre 200 manifestazioni di massa per rivendicare il diritto di tutte le donne a votare e candidarsi alle elezioni.
Oltre che delle crisi e dei movimenti, secondo Krznaric qualsiasi contesto storico di rottura ha infine bisogno di idee, di un mutamento del clima intellettuale. Ed è più probabile che a produrlo siano appunto le esperienze concrete che non precedenti riflessioni teoriche o filosofiche, scrisse l’economista statunitense Milton Friedman nella prefazione del 1982 al libro Capitalismo e libertà, pubblicato vent’anni prima. Sono fenomeni come l’inflazione e la tassazione eccessiva, e non la capacità di convincimento delle idee, secondo Friedman, a spiegare le trasformazioni politiche.
Allo stesso tempo le crisi, reali o percepite che siano, possono produrre un cambiamento soltanto se nel momento in cui si verificano sono disponibili delle idee che sostengono il cambiamento. Solo questo, secondo Friedman, permette di superare l’inerzia dominante nelle organizzazioni e nelle istituzioni pubbliche e private. E a questa necessità è legata la funzione essenziale degli economisti e degli intellettuali: «Sviluppare alternative alle politiche attuali, in modo che siano a portata di mano fino al momento in cui ciò che oggi è politicamente impossibile diventerà politicamente inevitabile».
La crisi finanziaria del 2008 è uno degli esempi citati da Krznaric di crisi che si verifica in mancanza di idee unificanti. C’era una crisi, quella finanziaria, e c’era un movimento, Occupy Wall Street: ciò che mancava erano nuove idee e nuovi modelli economici in grado di rimpiazzare il sistema in crisi. E il risultato fu che le banche di investimento riuscirono a farsi salvare e il sistema finanziario rimase fondamentalmente intatto.
Non è detto che la presenza di tutti e tre i fattori – crisi, movimenti, idee – porti necessariamente a un cambiamento della politica. A volte il potere, o per dirla con Friedman «la tirannia dell’esistente», è semplicemente troppo radicato. È la ragione per cui i pacifisti negli Stati Uniti, per esempio, non furono in grado di fermare la guerra in Vietnam negli anni Sessanta pur avendo il sostegno di ampie fasce dell’opinione pubblica, scrive Krznaric.
Infine, come attestato dalla duttilità e dalla pregnanza del concetto di “crisi” in tutte le scienze sociali, ogni crisi può avere sviluppi imprevedibili in più direzioni. La Grande Depressione degli anni Trenta, per esempio, da un lato potrebbe aver contribuito all’ascesa dei partiti progressisti socialdemocratici dei paesi scandinavi, ma dall’altro favorì anche l’ascesa del nazismo in Germania e del fascismo in Italia, secondo Krznaric.