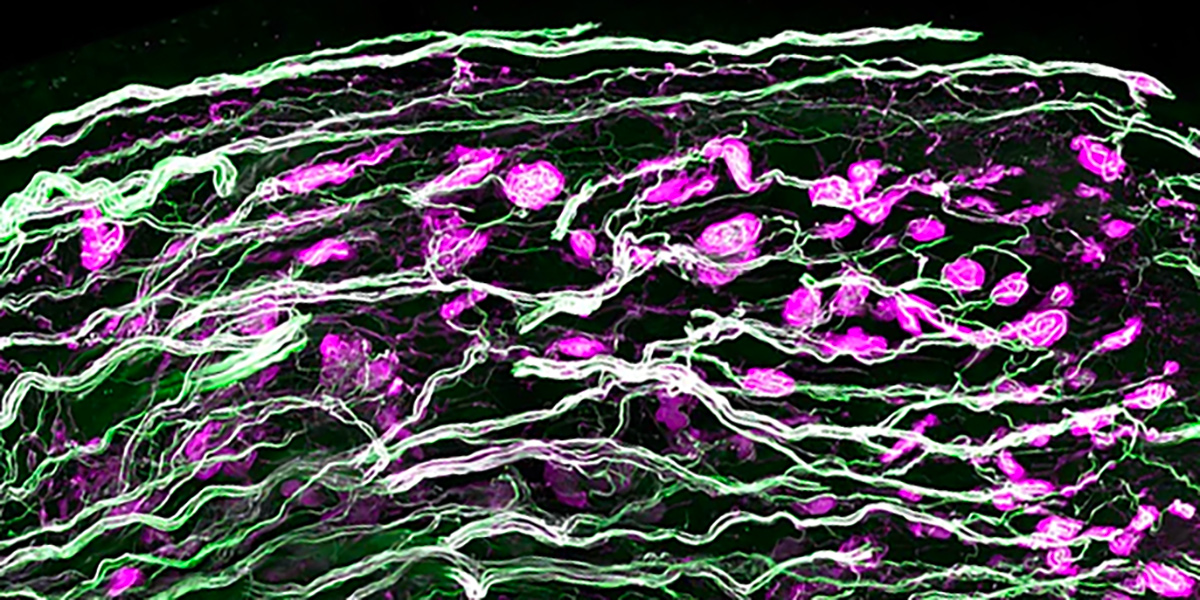Da 80 anni Reinhold Messner guarda le montagne
E da qualcuno di meno le scala, dalle pareti delle Dolomiti alle cime dell'Himalaya, dove perse un fratello e segnò come pochi altri la storia dell'alpinismo
di Emanuele Menietti

Secondo alcuni medici, Reinhold Messner sarebbe dovuto morire nel 1978 scalando l’Everest, raggiungendo la vetta a 8.848 metri di altitudine senza una bombola di ossigeno. Messner divenne invece il primo alpinista a riuscire in quell’impresa e, nonostante le previsioni poco ottimistiche e lo scetticismo dell’epoca, può raccontarla ancora oggi: il giorno del suo ottantesimo compleanno. Nei suoi oltre quarant’anni di carriera, Messner ha scalato tutte le 14 montagne sopra agli ottomila metri, ha perso un fratello sull’Himalaya, ha attraversato l’Antartide, la Groenlandia e qualche deserto, ha scritto decine di libri e fatto il testimonial in molte pubblicità, ha litigato (tanto) con i colleghi alpinisti, ma soprattutto ha segnato come pochi altri l’alpinismo della seconda metà del Novecento.
«Un tempo, la storia dell’alpinismo si scriveva sulle muraglie di roccia con la penna simbolica dell’ardimento; oggi, si scrive con i chiodi». Fu con queste parole che Messner si fece notare nel 1968 quando la Rivista mensile del Club Alpino Italiano (CAI) pubblicò il suo intervento “L’assassinio dell’impossibile”. Messner esponeva la sua avversione per il ricorso sempre più frequente all’arrampicata artificiale, dove si avanza aiutandosi con attrezzature come scalette e staffe, a scapito dell’arrampicata libera, che non prevede attrezzatura se non quella per proteggersi dalle cadute. Messner era convinto che fosse necessario un ritorno alle «vie di arrampicata libera» per recuperare un pieno rapporto con la montagna, e cercò di aderire a quel proposito per buona parte della propria carriera.
È difficile dire quando un alpinista diventa tale o per lo meno inizia a considerare la propria passione per le montagne come qualcosa a cui dedicare la vita. Messner forse lo diventò già a cinque anni quando il padre Josef lo accompagnò nella sua prima ascensione sul Sass Rigais, nelle Dolomiti. Era del resto cresciuto lì vicino, a Funes, un piccolo paese del Trentino-Alto Adige, dopo essere nato a Bressanone il 17 settembre del 1944. Secondogenito di nove fratelli, Messner crebbe in una famiglia numerosa e con un rapporto a dir poco conflittuale con il padre, per via dei suoi modi spicci e spesso autoritari.
Un giorno di fine giugno del 1957 Messner trovò nascosto in un angolo della casa il fratello Günther, che aveva 12 anni, un anno meno di lui. Si era nascosto perché il padre in un attacco d’ira lo aveva picchiato con la corda del cane al punto che non riusciva più a muoversi. Avrebbe raccontato in seguito Messner in uno dei suoi libri: «Quel giorno non diventammo solo amici. Günther divenne il mio compagno di cordata e ben presto imparò a scalare con me. Cominciammo a parlare assieme di evasioni e vedevamo nelle nostre gite delle brevi fughe. Volevamo andare lontano, lontano da un padre autoritario e lontano dall’ingiustizia di questo mondo».
Tra i punti di riferimento dei due fratelli Messner c’erano l’alpinista austriaco Hermann Buhl e l’italiano Walter Bonatti, non solo per la fama che si erano guadagnati con alcune delle più grandi imprese alpinistiche negli anni precedenti, ma anche per il loro stile di salita e il modo in cui affrontavano la montagna. Su spinta soprattutto di Reinhold, i Messner scalavano infatti utilizzando il minimo necessario in termini di equipaggiamento, in modo da essere più leggeri e flessibili nel trovare i percorsi, assecondando le caratteristiche naturali delle montagne.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta aprirono numerose vie nelle Dolomiti cercando sempre di privilegiare i percorsi che rendessero possibili le ascese in arrampicata libera. Sull’Ortles, sulle Pale di San Martino e sul Monte Agner, sul Monte Civetta e sul Gruppo del Sella aprirono nuove vie di difficoltà notevole per l’epoca, sempre usando pochissimi chiodi e altre protezioni, in modo da lasciare meno attrezzatura possibile sulle pareti. Fu nel 1968 che, insieme a Günther, Reinhold realizzò la sua più importante impresa sulle Dolomiti. Aprì una nuova via sulla monumentale parete del Pilastro di Mezzo del Sas dla Crusc, in Val Badia, superando un passaggio di alcuni metri che all’epoca sembrava sostanzialmente impossibile: quando fu ripetuto per la prima volta un decennio più tardi la difficoltà fu valutata di grado VII+/VIII-, che all’epoca della sua ascesa non era mai stato raggiunto.
Nel 1974, con il suo libro Il settimo grado. Scalando l’impossibile, Messner raccontò le sue imprese sulla roccia e teorizzò il superamento del sesto grado, considerato allora da molti il limite massimo dell’arrampicata libera, attirandosi molte critiche tra gli alpinisti più conservatori, che mal tolleravano la sua audacia e la sua sfrontatezza. Da allora, il limite dell’arrampicata libera è stato spostato ulteriormente, e di molto, ma Messner è ricordato ancora oggi come una delle figure più importanti nella definizione di un approccio alla disciplina che sarebbe poi diventato quello maggioritario nei decenni successivi.
Alla fine degli anni Sessanta i Messner iniziarono a pensare a scalate fuori dall’arco alpino, proprio come avevano fatto Buhl e Bonatti con l’Himalaya. L’occasione si presentò nel 1970 quando furono invitati a far parte della spedizione sul Nanga Parbat del tedesco Karl Maria Herrligkoffer, molto noto per la sua organizzazione e un certo piglio marziale. L’approccio delle spedizioni all’epoca, del resto, non era così diverso da quello di una campagna di assedio, con un notevole sforzo logistico di portatori e materiali per allestire campi base via via che ci si avvicinava all’ascesa finale. Il contrario di come Reinhold Messner concepiva una impresa alpinistica.
– Leggi anche: La conquista italiana del K2, e tutto quello che venne dopo
L’obiettivo principale della missione era raggiungere la sommità del Nanga Parbat a 8.126 metri passando per il versante Rupal, una parete molto ripida e considerata la più alta del mondo con i suoi 4.500 metri di altezza. Alla fine di giugno i Messner erano all’ultimo campo e si prospettava un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il giorno seguente. Reinhold aveva concordato di iniziare l’ascesa in solitaria e senza utilizzare corde fisse, in modo da muoversi più velocemente verso la cima prima dell’atteso peggioramento del tempo. Günther avrebbe dovuto invece attrezzare un canalone per facilitare la successiva discesa del fratello, ma le cose andarono diversamente.
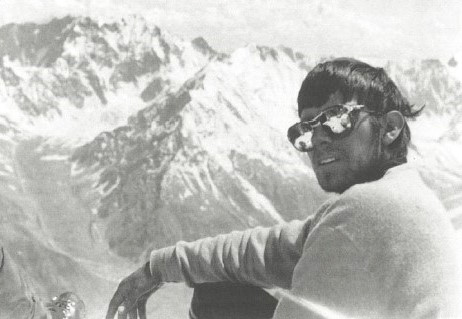
Gunther Messner durante la spedizione del 1970 sul Nanga Parbat (via Wikimedia)
Dopo circa quattro ore di salita, Reinhold notò Günther in lontananza che si stava avvicinando di propria iniziativa per effettuare la scalata con il fratello. Insieme, nel tardo pomeriggio del 27 giugno i Messner raggiunsero la vetta effettuando per la prima volta un’ascesa completa attraverso il versante Rupal. Era ormai tardi per tornare al campo e Günther stava accusando il male di montagna a causa dell’alta quota.
Secondo il racconto di Reinhold Messner, i due fratelli concordarono di bivaccare a 7.600 metri e il giorno dopo di scendere dall’altra parte della montagna attraverso il versante Diamir, perché difficilmente nelle sue condizioni Günther avrebbe potuto percorrere in discesa la parete del Rupal, molto più ripida. Iniziarono la discesa, ma nonostante la temperatura meno rigida e la quota relativamente più bassa Günther non dava molti segni di miglioramento. Bivaccarono una seconda notte e l’indomani Reinhold propose al fratello di attenderlo mentre andava in avanscoperta per trovare la via più pratica e sicura per proseguire la discesa.
Pochi minuti dopo essersi separati, una valanga seppellì di neve, ghiaccio e detriti il punto in cui era stato lasciato Günther. Reinhold Messner tornò indietro in soccorso del fratello, ma ogni ricerca fu vana. Con un principio di congelamento, proseguì la discesa a tratti a carponi prima di essere trovato per caso da due locali che lo portarono al loro villaggio; non avendo avuto notizie per circa sei giorni, i compagni di spedizione avevano pensato fosse morto.
La prima spedizione sull’Himalaya era andata molto diversamente da come aveva immaginato Messner. Gli erano state amputate parzialmente sette dita dei piedi a causa del congelamento e soprattutto le particolari condizioni in cui aveva perso il fratello sarebbero diventate per anni fonti di polemiche e accuse, talvolta infamanti. Messner fu accusato di aver abbandonato il fratello nei pressi della cima del Nanga Parbat, e non più a valle come dai suoi racconti, per non essere ostacolato nel compiere per primo l’attraversamento del versante Diamir. Secondo quelle ricostruzioni, sempre respinte da Messner, il fratello col suo mal di montagna avrebbe reso più difficile se non impossibile l’impresa e visto che aveva scelto di propria iniziativa di salire sul Nanga Parbat si sarebbe dovuto arrangiare per la discesa.
I dubbi intorno alla versione ufficiale di Messner continuarono a essere sollevati da alcuni alpinisti e giornalisti per circa 30 anni, fino al 2000 quando fu effettuato l’esame del DNA di alcuni resti di una persona trovata sul versante Diamir. Stando ai risultati degli accertamenti, quei resti appartenevano a Günther Messner, a conferma della versione di Reinhold che aveva sempre sostenuto di avere effettuato buona parte della discesa con il fratello: negli anni seguenti sarebbero stati trovati altri resti. Le ricerche e le analisi erano state finanziate da Messner stesso, nonostante la vicenda fosse ormai datata e da molti dimenticata, a suo dire per un semplice e altrettanto doloroso motivo: «Vivo con il senso di colpa di essere sopravvissuto».

Reinhold Messner nel 1985 tra i rilievi del massiccio montuoso del Pamir (via Wikimedia)
La spedizione sul Nanga Parbat non fermò le ambizioni di Messner, che anzi mise insieme in pochi anni una serie impressionante di ascese per i ritmi dell’alpinismo dell’epoca. Incontrò l’alpinista austriaco Peter Habeler che condivideva la sua visione delle scalate in stile alpino, con poca strumentazione e senza l’utilizzo di bombole d’ossigeno. Nel 1975 scalarono insieme il Gasherbrum I, l’undicesima montagna più alta del mondo sempre nell’Himalaya, e tre anni dopo annunciarono di voler fare altrettanto con l’Everest, suscitando le previsioni pessimistiche di medici ed esperti che ritenevano impossibile una salita senza ossigeno supplementare fino a 8.848 metri.
Contro le previsioni, l’8 maggio 1978 Messner e Habeler raggiunsero poco dopo le 13 la cima dell’Everest diventando i primi a scalare la montagna più alta del mondo senza bombole di ossigeno. La notizia fu ripresa dai giornali di tutto il mondo e diede ulteriore fama a Messner, che negli anni seguenti proseguì con le proprie imprese alpinistiche diventando la prima persona a salire tutte le 14 vette più alte del pianeta senza ossigeno supplementare. Completò l’impresa nel 1986 salendo sul Lhotse, a 16 anni di distanza dall’ascesa sul Nanga Parbat.

La Stampa, 11 maggio 1978
Messner divenne noto non solo grazie all’interesse della stampa e ai numerosi libri pubblicati in quegli anni, ma anche per i molti marchi che gli chiesero di fare da testimonial in quel periodo e nelle fasi successive della sua carriera. Molti ricordano ancora oggi lo slogan scandito con accento altoatesino “Altissima, Purissima, Levissima” dell’acqua minerale, o le campagne per molti marchi di abbigliamento sportivo come Millet, Salewa e Fila, o ancora per l’azienda automobilistica Opel, per gli orologi Citizen e per i tanti prodotti tipici delle terre di Messner a partire dallo speck.
La grande visibilità e la fama furono fonti di gelosie, liti o semplici incomprensioni con altri alpinisti, anche a causa del carattere di Messner non sempre semplice da gestire. In fasi diverse della propria carriera, litigò con molte persone, comprese alcune con cui aveva condiviso grandi imprese come Habeler. Nei suoi libri e nelle interviste, Messner ha ricondotto il deterioramento dei rapporti con i colleghi a una ricorrente sensazione di sentirsi sfruttato: «Molti di loro, non tutti loro, ma molti, capirono di avere un’opportunità unica di usarmi per avvantaggiarsene personalmente. Ed è molto facile approfittarsi di me. Lo facciamo stando sulle spalle di Messner, dicono. Ed è possibile: posso farmi carico di molte persone. Ma smetto di sostenerle se iniziano a cagarmi addosso».
Habeler lo ha accusato di essere un «maniaco del controllo» e di essersi intestato più meriti di quanti ne avesse nell’ascesa dell’Everest, mentre altri lo hanno accusato di avere raggiunto alcune cime scegliendo le vie più facili e con poche difficoltà tecniche. Negli anni Novanta furono anche messe in circolazione voci sulla presunta instabilità mentale di Messner, con ipotesi sul fatto che la privazione di ossigeno ad alta quota avesse compromesso alcune delle sue funzioni mentali.
Quei dubbi, non sostanziati, emersero soprattutto quando Messner avviò un’iniziativa per scoprire se esistesse effettivamente lo yeti, cioè la creatura che secondo le leggende di alcune popolazioni dell’Himalaya vive tra quelle montagne.
– Leggi anche: Bigfoot e altri abominevoli
Apparve da subito improbabile e assurdo che Messner potesse fare qualche progresso nella ricerca dell’abominevole uomo delle nevi, argomento su cui scrisse anche un libro, ma l’alpinista mostrò come in altre occasioni una certa determinazione e cocciutaggine. L’argomento era a dir poco discutibile, ma al di là delle critiche più facili, Messner cercò di mantenere un approccio se non proprio scientifico per lo meno critico, cercando indizi e dando spiegazioni all’origine della leggenda. Ipotizzò infine che lo yeti potesse essere una sottospecie ibrida di orso: la teoria è ancora dibattuta, ma Messner è fermamente convinto di avere risolto il mistero.

Reinhold Messner davanti a un orso impagliato alla presentazione dei suoi studi sullo yeti a Vienna, in Austria, il 3 novembre 1998 (Herwig Prammer/Reuters)
Gli anni Novanta erano comunque iniziati per Messner con un’impresa lontana dall’Himalaya e dalla sua mitologia. Insieme all’esploratore tedesco Arved Fuchs era stato il primo ad attraversare l’Antartide senza utilizzare mezzi motorizzati o tirati da animali, come i cani da slitta: percorsero quasi 3mila chilometri in tre mesi. Qualche anno dopo un cinquantenne Messner effettuò una traversata della Groenlandia con il fratello Hubert.
Convinto della necessità di preservare gli ambienti alpini e portare maggiore sensibilità sui temi dell’ambiente, Messner ebbe anche una breve carriera politica. Fu eletto nel 1999 al Parlamento europeo con i Verdi, partito dal quale fu poi espulso nel 2004 in seguito alla sua scelta di fare da testimonial in una pubblicità per un’azienda produttrice di fucili. Nello stesso anno, Messner era comunque tornato alle esplorazioni effettuando a quasi 60 anni una traversata del deserto del Gobi.

La sede del Messner Mountain Museum sul Monte Rite tra Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo (Toni Anzenberger/Anzenberger/Contrasto)
Da allora Messner ha iniziato a camminare meno e si è soprattutto dedicato alla creazione e al finanziamento di iniziative per aprire e gestire musei della montagna, con l’intento di fare divulgazione non solo intorno alle imprese alpinistiche, ma anche al rapporto tra gli esseri umani e le montagne. Il Messner Mountain Museum è un museo diffuso con sei sedi nel Sudtirolo, ognuna delle quali è dedicata a particolari aspetti della montagna, dalle esplorazioni all’ambiente, passando per la cultura e le tradizioni alpine.
Nei pressi di uno dei musei, vicino a Cibiana di Cadore, ci sono anche alcuni yak nati dagli animali che Messner portò dall’Himalaya nelle Dolomiti a metà degli anni Ottanta. Da allora all’inizio e alla fine dell’estate, è possibile trovare Messner sul percorso utilizzato per la transumanza degli yak tra gli alpeggi e la loro sistemazione per la stagione fredda. Il trasferimento degli yak di Messner è ormai una tradizione e l’occasione per molte persone appassionate di montagna di camminare al fianco di uno dei loro idoli, alla velocità che da sempre preferisce: «L’uomo ha imparato a muoversi con le gambe e camminando capisce il mondo, capisce il suolo, capisce la biologia e capisce se stesso. Tutto il resto, aereo, macchina, bicicletta, troppo veloce».