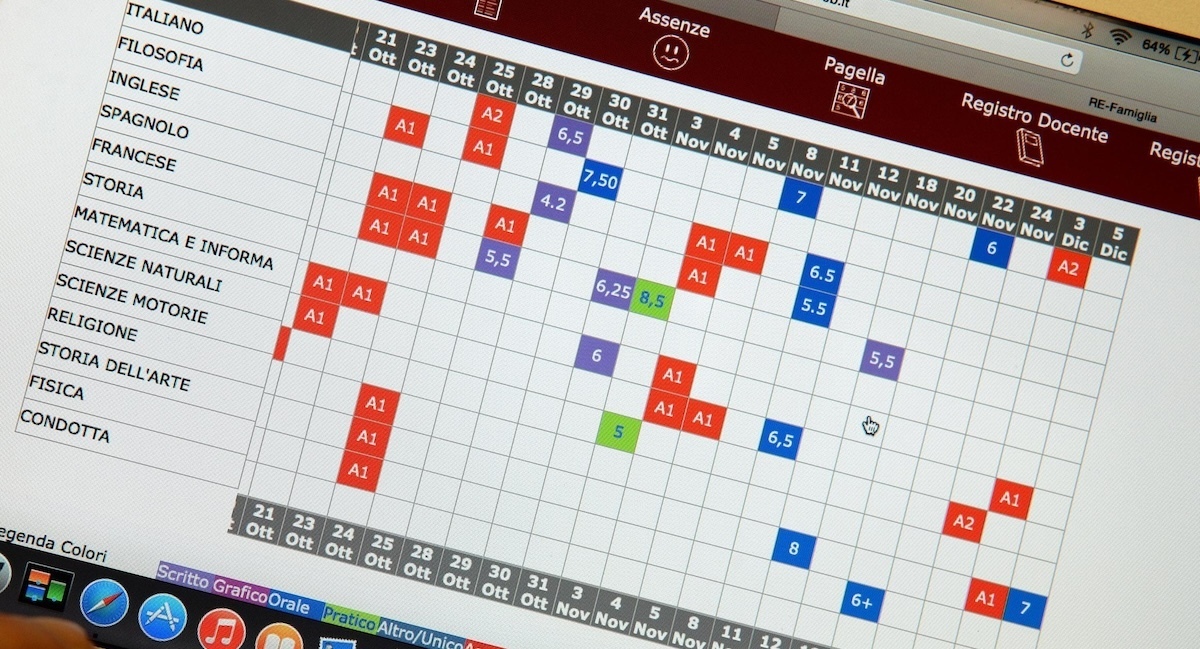La lunga marcia dell’estrema destra in Germania
«Molti anni fa mio “zio Michael”, ormai anziano, ospitò me e mio figlio nella sua casa nel Connecticut negli Stati Uniti. Un giorno, aprendo l’armadio a muro della camera per gli ospiti, era saltata fuori la sua uniforme di Buchenwald. Manca ormai da un decennio mio zio Michael, questo mio amatissimo parente, uno dei pochissimi scampati allo sterminio. Se mi immagino in dialogo con lui, vorrei rispondergli che il fascismo di oggi non è quello di allora che ha rialzato la testa, ma mi risuonano nella mente le parole della scrittrice Anne Rabe che tracciano un quadro terrificante di quello che la Germania dell’Est è diventata. La presenza della destra estrema è persino più spaventosa che negli anni in cui il mio amico Johannes era stato preso a calci dai naziskin di Lipsia. La paura è diffusa in chiunque non sia un simpatizzante, il controllo territoriale è esercitato da gente disposta a spaccare le ossa a chi sia inviso, il clima associabile allo spadroneggiare delle SA negli anni Trenta»

Negli anni ’90, quando per tenere i contatti esistevano solo le lettere o le telefonate dal fisso di casa, sentivo ogni tanto un caro amico di Monaco finito a Lipsia dopo la riunificazione. Era stato assunto alla radio della MDR, l’emittente creata sul modello di quelle pubbliche dei vecchi Länder, per occuparsi di programmi di cultura. Ormai sulla cinquantina, era la prima volta che avrebbe potuto sperare di arrivare all’età della pensione facendo un lavoro a lui congeniale per un pubblico capace di apprezzarlo. A Lipsia c’erano la prima orchestra radio-sinfonica risalente agli anni ’20, il Thomanerchor diretto da Johann Sebastian Bach, e la fiera del libro che, per secoli, era stata più grande di quella di Francoforte. Ma appena fuori dagli studi ovattati cominciavano le bruttezze e le durezze del post-comunismo e la paura dei nazisti – quelli nuovi dalla testa rasata.
Che Johannes Kiebranz fosse un “Wessi” lo dicevano l’abbigliamento e l’accento occidentale, che fosse ebreo e per giunta gay non era difficile scoprirlo. E infatti aveva cominciato a trovare messaggi marchiati con la svastica e la dicitura «JUDEN RAUS» nella cassetta della posta. Per combinazione aveva trovato alloggio nella Humboldtstrasse, proprio la via dove, sotto il regime nazista, gli ebrei di Lipsia erano stati costretti ad ammassarsi. Poi un giorno i naziskin lo avevano atteso vicino a casa riempiendolo di calci e pugni. Mentre mi raccontava di quell’assalto e della difficoltà di andare al pronto soccorso mi ero scordata della bolletta del telefono, e allora telefonare in un altro paese europeo costava moltissimo.

Johannes Kiebranz nella sua casa di Berlino nell’estate del 2023 (Helena Janeczek)
Per me, figlia tardiva di sopravvissuti, i nazisti erano stati una presenza coperta di silenzio, il vecchio che non muore anche se non alza più la testa. Anziani signori con il loden, il cane e il passo marziale, vecchie sul tram che osservavano ingrugnite l’indisciplina di noi studenti, la professoressa di tedesco che mi riempiva di insufficienze mentre alle colleghe e ai colleghi di vedute democratiche ero sempre risultata una delle migliori. Non avendo però mai incontrato neanche un commento antisemita, il racconto di Johannes mi lasciò esterrefatta. Diceva che gli era andata ancora bene visto che, in quella via troppo centrale, i suoi assalitori non avevano avuto il tempo di infierire. Non diceva che, appena possibile, avrebbe rinunciato alla sicurezza del posto fisso per trasferirsi a Berlino.
Chissà, magari qualcuno dei ragazzi che avevano pestato il mio amico adesso è un deputato. Me lo sono chiesta guardando la cartina della Germania dopo le ultime elezioni europee, che già lasciavano presagire l’esito del voto in Turingia e Sassonia: l’ex Germania Ovest, la BRD, tutta nel nero tradizionale della CDU/CSU, nell’azzurro squillante dell’AfD l’intero territorio un tempo separato dal Muro, la DDR.
In Italia, dove l’attuale presidente del Senato non ha mai dovuto dissociarsi dal suo passato neofascista, compreso il ruolo di picchiatore, l’idea che un uomo in giacca e cravatta che sorride rassicurante dai manifesti elettorali in gioventù abbia avuto gli anfibi e la mazza da baseball risulterebbe plausibile. Però in Germania l’avanzata e la graduale normalizzazione dell’estrema destra hanno seguito un percorso più complicato. Perché, a differenza dell’Italia, la Germania resta comunque il paese che «ha fatto i conti con il passato»? O perché, dopo tre generazioni, persino nella patria del nazismo è inevitabile che quel passato di regime totalitario, guerra mondiale e genocidio sia diventato una memoria talmente labile e sbiadita da non agire più come deterrente? Specie nella ex DDR dove la riunificazione ha lasciato dei risentimenti e anche delle fragilità socio-economiche ben più recenti?
– Leggi anche: Perché l’estrema destra è così forte nella Germania orientale
In realtà guardandola meglio, questa storia, bisogna porsi molte domande su quei famosi «conti fatti». Eppure, per me, il distacco dal passato nazista non è stato solo un credo, bensì un’esperienza. Gli amici che mi porto dietro dai tempi della scuola, la maggioranza dei miei professori erano – e restano – esattamente questo: democratici, antifascisti, attenti a ogni forma di razzismo e antisemitismo. Anzi, di più: erano stati proprio loro a innescare e a prolungare fino a pochi decenni fa la forza di rottura del ’68 tedesco, il cui spirito anti-autoritario si esprimeva, prima di tutto, nella sfida al silenzio del dopoguerra: nel rendere politico il privato chiedendo ai padri ma tu che cosa hai fatto durante la guerra, o trovando addirittura il coraggio di raccontare in classe come il nazismo li avesse indottrinati, di modo che noi, le nuove generazioni, imparassimo il valore della disobbedienza.
Trovavo comprensibile che i miei pochi parenti superstiti alla Shoah mettessero piede in Germania solo per rivedere i miei genitori che per malasorte erano rimasti lì, nella terra rifiorita degli aguzzini. A cominciare da mio zio Michael, il nipote più grande di mio padre diventato un businessman americano, che d’estate in Germania scopriva il braccio con il numero di Auschwitz con tutta l’intenzione di mostrarlo al popolo carnefice, magari incarnato proprio dai signori seduti accanto nella birreria all’aperto. No, lui non avrebbe mai creduto che un lupo, per quanto ben pasciuto e “rieducato”, potesse cambiare pelle. E io, oggi, dopo queste elezioni, cosa dovrei fare? Dare ragione a “zio Michael”?
Sembra un paradosso, ma è proprio l’ironia della sorte dell’essere cresciuta nella patria del nazismo a rendermi tuttora quanto mai convinta che i popoli possano cambiare, sia per il meglio che per il peggio. E che non basti nessuna memoria collettiva, tantomeno ufficiale, a conservare e proteggere quel cambiamento, perché si cambia solo per desiderio di un presente e di un futuro differente, non per placare la coscienza di uno sterile senso di colpa collettivo.
A proposito: quanto era stato comodo potersela rimpallare la colpa da entrambi i lati dei Muro? Finché erano esistite due Germanie, entrambe rivendicavano di aver rotto con il nazismo. La DDR, antifascista per statuto, enfatizzava ogni notizia proveniente dall’altra parte che mostrasse come gli USA avessero riabilitato i vecchi nazi in funzione anticomunista. La BRD andava superba della sua Costituzione liberal-democratica e, oltretutto, si era dotata di un servizio d’informazione, il Verfassungsschutz, con il compito di sorvegliare e punire ogni rigurgito estremista.
Nella Baviera della mia infanzia i manifesti con le foto segnaletiche dei latitanti RAF – «Achtung Terroristen!» – erano affissi persino a scuola. Nulla di simile avveniva per l’eversione neonazista dando a intendere che «mai più» quei pochi esaltati sarebbero diventati un pericolo. E così la violenza esplosa a est negli anni ’90 era stata dipinta come un problema transitorio dell’est selvaggio, il Wilder Osten. Soltanto nel trentennale della caduta del Muro, cioè nel 2019, si è aperto un dibattito che ha reso tangibile quanto nella ex DDR il terrore degli skinhead a caccia di stranieri, “zecche”, senzatetto, o semplicemente ragazzi dall’aria diversa, dominasse la vita quotidiana. La rivisitazione degli «anni con la mazza da baseball» – come li ha chiamati il giornalista Christian Bangel – era stata favorita dal susseguirsi di notizie troppo gravi per non suonare come un campanello d’allarme. Da qualche tempo la Germania registrava una ripresa consistente – e assassina – dell’eversione nera.
Ma vivendo nel paese dove Salvini, Meloni e i loro accoliti ripetevano da anni, incontrastati, che per prevenire la “sostituzione etnica” orchestrata da Soros bisognava affondare i barconi, la “Germania di Merkel” mi sembrava comunque un’isola di buona “memoria storica” in un mondo dove la destra trionfava. Lo shock più inatteso, per me, era stata la vittoria di Brexit nel 2016: la popolazione che – «Keep Calm and Carry On» – aveva resistito al blitz nazista, la prima democrazia a mobilitarsi per sconfiggere le armate tedesche, si era lasciata persuadere dal populista Farage e dal privilegiatissimo Boris Johnson. La grandezza perduta da ex potenza imperiale sperava di riconquistarla levando il visto a idraulici polacchi e fruttivendoli portoghesi ma, soprattutto, fermando “l’invasione” dei migranti prima che potessero varcare le scogliere di Dover.
La parte più spaventosa del romanzo Exit West di Mohsin Hamid, uscito nel 2017, riguarda il momento in cui i due protagonisti Nadia e Saeed, fuggiti da una guerra in Medio Oriente, poi spiaggiati su un’isola greca, approdano finalmente a Londra, dove però i “nativi” si preparano a dare l’assalto al campo profughi. La cupa favola di Mohsin Hamid propone un finale negli Stati Uniti, dove almeno Nadia riesce a rifarsi una vita. Ma proprio in quell’anno Donald Trump diventa presidente degli USA. L’anno dopo il Salvini “capitano” offre un assaggio di nazionalismo etnico in salsa italiana – i “porti chiusi”, la diffamazione delle navi di soccorso, i selfie con la felpa della polizia come fossero suoi pretoriani. Finché il ministro dell’Interno non reclama “i pieni poteri” e viene scaricato da un evanescente presidente del Consiglio, il suo sogno autoritario va a gonfie vele.
In ogni caso, sia in Italia che tutt’intorno, il populismo razzista cresceva così vistosamente da non farmi percepire che proprio la gestione merkeliana della “crisi migratoria” avesse prodotto, sotto traccia, una reazione che non si limitava a scorgere il nemico esterno nei profughi accolti. No, la destra estrema identificava il nemico interno proprio nella cancelliera e in chi ne sposava la linea “immigrazionista”. Come il democristiano Walter Lübcke assassinato nel 2019 nella Germania occidentale, uno degli atti di terrorismo neonazista più sconvolgenti di quel periodo segnato dalla ripresa di attentati razzisti e antisemiti, a est come a ovest. Insomma, nel 2019 si cominciava a temere che “gli anticorpi democratici”, di cui la Germania andava tanto fiera, non fossero più tanto reattivi. D’altra parte l’emergere delle ampie coperture di cui avevano goduto i neonazisti – attraverso il processo alla cellula terroristica NSU oppure quando i giornali portarono alle dimissioni Hans Georg Maassen, il capo del Verfassungsschutz, il servizio di informazione che si occupa di attività contro la Costituzione, svelando i suoi legami con la destra – mostrò che in Germania la volontà collettiva di proteggere la democrazia sembrava molto più vigorosa che altrove.
Intanto, però, cresceva la nuova Alternative für Deutschland che superava il 20% nel Meclemburgo già nel 2016, sino al risultato con cui da poche settimane si è attestata primo partito in Turingia. A fare paura non è solo quel 32,8% e il 30,6% in Sassonia, ma che come hanno mostrato le elezioni europee AfD è ormai seconda forza anche all’ovest, a cominciare dai Länder più ricchi come la Baviera e il Baden Württemberg. Troppo comodo e semplice, quindi, sostenere che il problema sia specifico dell’“arretrata” Germania ex-comunista. La spiegazione più plausibile è che l’est tedesco sia stato il laboratorio perfetto per fare leva sulla perdita d’identità sperimentata dopo il 1989, colmandola con un’offerta identitaria semplice e vincente: razzista, nazionalista, antieuropea, antioccidentale nella misura in cui i “valori occidentali” impongono le regole dello Stato di diritto.
Impressiona che a AfD sia andata gran parte del voto giovanile. Sono ragazzi senza memoria di come si vivesse durante la transizione o dietro il Muro – tantomeno durante il nazismo. Come in Francia il Rassemblement National del ventottenne Jordan Bardella, AfD è un partito abilissimo a comunicare via TikTok, il social media più usato dai giovani. In generale, ha curato sin da principio l’immagine di un partito nuovo. Nessun richiamo a vecchi simboli – a differenza della fiamma tricolore MSI che resta irremovibile dal simbolo di Fratelli d’Italia –, un nome vago come Alternativa per la Germania e quel luminoso azzurro normalmente associato alle forze liberali o liberiste. Bjorn Höcke, il capolista in Turingia, è nato e si è formato a ovest, e così la bionda leader nazionale Alice Weidel. Figlia del ceto medio, laureata con lode in economia, ex analista di Goldman Sachs a Francoforte sul Meno, oggi vive sul lago di Costanza con la sua compagna di origine cingalese e ha due figli adottivi. Donna, lesbica, legata a una donna non bianca eppure sostenitrice dei “valori tradizionali” e di una “Germania per i tedeschi”.

Alice Weidel sul palco del congresso di Alternative für Deutschland a Essen in Germania il 29 giugno 2024 (Thomas Lohnes/Getty Images)
Il successo di AfD deriva anche dall’abilità con cui il partito ha saputo presentarsi come qualcosa di diverso dal “ritorno del passato”. Fino a pochi anni fa i partiti tradizionali, inclusi quelli conservatori, avevano ribadito che le forze democratiche dovessero essere unite nell’erigere “un muro antincendio” contro l’estrema destra. Niente alleanze con AfD, neanche a livello locale. Ma dopo le ultime elezioni questo muro mostra segni sempre più tangibili di cedimento. Nei giorni del trionfo dell’AfD persino il presidente della Repubblica ha dichiarato che il problema prioritario della Germania non era l’avanzata dell’estrema destra bensì l’immigrazione.
Era, certo, la risposta all’attentato a Solingen, commesso in solitaria da un giovane siriano e subito rivendicato dall’ISIS. Ma Friedrich Merz, il successore di Merkel alla guida dei cristiano-democratici, ha subito fatto un discorso in linea con Meloni mettendoci una foga quasi salviniana: respingimenti, accordi con paesi come l’Albania, messa in discussione del trattato di Dublino, niente più ingressi per richiedenti asilo siriani e afghani. Intanto la ministra dell’Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, annunciava di aver espulso e rimpatriato ventisei afghani «con la fedina sporca» senza però trattare direttamente con i talebani che, proprio in quei giorni, avevano privato le donne del diritto di far udire la propria voce fuori casa.
Come negli altri paesi avanzati, anche in Germania la questione migratoria è il principale cavallo di battaglia delle destre, il cavallo di Troia con cui anche le forze politiche che non agitano lo spettro della “sostituzione etnica” premono sull’opinione pubblica allineandosi a un discorso che identifica nello straniero l’elemento che mina l’ordine, la sicurezza, il benessere comunitario. Eppure sono passati pochi anni da quando proprio la nazione partita a conquistare il mondo in nome della purezza ariana si vantava di essere diventato un grande paese d’immigrazione, uno Stato che ai cittadini «con background migratorio» offriva la possibilità di accedere a carriere in ogni ambito: dai media alle professioni, dalle imprese alla politica.
La Germania è stata anche il primo paese dove si era sviluppato un forte movimento ecologista e in cui i Verdi avevano governato a vari livelli, svolgendo un ruolo importante nel far diventare il paese leader mondiale della “Green economy” e del know how per affrontare le questioni ambientali, a partire dall’emergenza climatica. Però a partire dagli anni del Covid, quando la destra radicale ha cominciato a strumentalizzare le grandi proteste no vax, con i suoi umori negazionisti, le sue teorie del complotto, anche l’ecologismo è diventato sospetto e sgradito.
Non è un caso se il rafforzamento delle destre sia “tradizionali” che estreme è andato di pari passo al crollo di consensi dei Verdi, diventati negli anni il partito più europeista, “inclusivo” e difensore dei diritti civili e umani. Da un lato si è prodotto un imponente flusso di voti verso il conservatorismo della CDU, dall’altro è cresciuta l’astensione a sinistra che ha sentito i suoi valori traditi dalla Realpolitik del governo rosso-giallo-verde di Berlino. E così ormai è normale parlare di “terrorismo climatico” e accusare le politiche ambientali di attingere vessatoriamente alle tasche del povero contribuente. Si sostiene che la “scusa” della sostenibilità serva, in sostanza, a limitare la libertà individuale e aumentare la sorveglianza da parte dell’apparato statale o dell’“Europa”.
Dopo essersi illusa di essere l’unico paese ad aver veramente fatto i conti con il passato, adesso la Germania ha accelerato nel mettersi in pari con le tendenze politiche che si sono imposte tanto nei paesi che una forma di fascismo lo hanno conosciuto come in quelle che, storicamente, lo avevano sconfitto. La Erinnerungskultur – la cultura della memoria – si è dimostrata inutile o, peggio, un rito autocelebrativo buono a nascondere o minimizzare ciò che si stava preparando, da anni.
Nell’imminenza delle elezioni regionali, il direttore del sito di memoria di Buchenwald, lo storico Jens-Christian Wagner, ha deciso di mandare una lettera a 350mila cittadini della Turingia per dissuaderli dal contribuire alla vittoria dell’AfD. Come reazione ha ricevuto innumerevoli minacce, tra cui la sua foto affissa a una stele commemorativa delle «marce della morte», con cui nel ’45, di fronte all’avanzata delle truppe alleate, i nazisti trasferirono in massa a ovest i prigionieri dei campi di concentramento. Negli ultimi tempi, sostiene Wagner, è diventato normale vedere il lager imbrattato di svastiche, o che i visitatori facciano il saluto nazista, o che le guide e i dipendenti a fine turno ritrovino le loro auto con le gomme bucate.
Molti anni fa mio “zio Michael”, ormai anziano, ospitò me e mio figlio nella sua casa nel Connecticut negli Stati Uniti. Un giorno, aprendo l’armadio a muro della camera per gli ospiti, era saltata fuori la sua uniforme di Buchenwald. Non mi aveva scioccato soltanto il fatto di trovarla lì, intonsa, lavata e stirata, ma di poterla toccare, di capire nei dettagli come era fatta: non un “pigiama a righe”, bensì un completo di tela grossolana, certo, però cucita per durare più a lungo della vita del prigioniero che la indossava: con i bottoni ben attaccati, le asole rifinite, persino le spallette imbottite, da vera e propria giacca.
Quando gli chiesi dell’uniforme, Michael raccontò che in Germania non ci era tornato solo per vedere la mia e la sua famiglia, ma anche, qualche volta, per partecipare ai raduni degli ex detenuti. E che l’essere stato destinato a Buchenwald, dopo la marcia da Auschwitz, avesse contribuito alla sua sopravvivenza. Non solo perché era giovane, non solo perché Buchenwald era un campo di concentramento e non un campo di sterminio, ma anche perché nella gerarchia del lager non comandavano i criminali ma i “politici” che contenevano il più possibile l’arbitrio e il sadismo delle SS e delle guardie.

Zio Michael, con i baffi, in visita un’estate di inizio anni ’70 (Helena Janeczek)
Manca ormai da un decennio, questo mio amatissimo parente, uno dei pochissimi scampati allo sterminio. Ma se mi immagino in dialogo con lui, vorrei dirgli che il fascismo di oggi non è quello di allora che ha rialzato la testa, perché è insieme tedesco e globale, vecchio e nuovo, e intanto però mi risuonano nella mente le parole della scrittrice Anne Rabe, nata negli ultimi anni della DDR, testimone da bambina del Wilder Osten. In un discorso tenuto a fine agosto a Weimar – la città di Goethe alla cui periferia è sorta Buchenwald unendo per sempre cultura umanistica e disumanizzazione ariana – Rabe traccia un quadro terrificante di quello che la Germania dell’Est è diventata. Parla di una presenza della destra estrema persino più spaventosa che negli anni in cui il mio amico Johannes era stato preso a calci dai naziskin di Lipsia. Descrive la paura diffusa in chi non sia un simpatizzante, le intimidazioni capaci di far gettare la spugna a borgomastri democratici, di un controllo territoriale esercitato da gente disposta a spaccare le ossa a chiunque sia inviso, di un clima associabile allo spadroneggiare delle SA negli anni Trenta.
Nella Germania orientale si è realizzato un continuum assai sinistro, forse perché negli anni “con la mazza da baseball” il terrore neonazista aveva ottenuto un primo successo. Mentre la Germania dibatteva per la prima volta sul diritto d’asilo sancito dal Grundgesetz, la Costituzione tedesca, nella ex DDR si sommavano gli attacchi alle strutture di accoglienza per rifugiati e immigrati. Il fatto più grave avvenne a fine agosto del 1992 a Rostock-Lichtenhagen, con centinaia di neonazisti che distrussero e incendiarono un centro di raccolta per richiedenti asilo e una residenza per lavoratori in buona parte vietnamiti. Una folla di spettatori li guardò plaudendo alle grida «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!», «La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri». I bersagli del primo pogrom commesso su suolo tedesco dopo il nazismo furono tratti in salvo in extremis. Ma la politica rinunciò a ripristinare le strutture per ospitare gli stranieri e, soprattutto, il parlamento ratificò la prima restrizione del diritto d’asilo, come era stato formulato proprio per sancire l’universalità dei diritti letteralmente sterminati dai nazisti in ogni terra da essi invasa.
«Non temo il ritorno del nazismo» mi dice oggi, da Berlino, l’amico Johannes, «temo soprattutto la polarizzazione inaudita della società, il suo sgretolarsi in gruppi gli uni contro gli altri armati». È a questa evoluzione che la politica nel suo insieme sembra incapace di reagire se non promettendo compulsivamente “soluzioni” populiste, con l’appoggio altrettanto inedito della stampa e persino dei media del servizio pubblico. «Sai», continua, più polemico che spaventato, «nessuno ti invita più a pensare con la tua testa: l’imperativo categorico di Kant, l’idea che il dovere morale caratterizzi l’essere umano, non va più di moda».
Non è soltanto nella ex DDR, non è solo in Germania che, da tempo, i diritti umani – che devono molto all’universalismo di Kant – vengono talmente erosi e violati da apparire, ormai, meri princìpi di carta. E così «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!» oggi lo intonano anche dei giovani tedeschi in vacanza sull’isola di Sylt, ballando, bevendo Spritz Aperol, alzando estatici le mani o l’iPhone verso il cielo del mare del Nord. Cantano, questi tedeschi ricchi occidentali, questa futura classe dirigente, sulle note di L’amour toujour di Gigi D’Agostino perché è con quel tormentone da discoteca anni ’90 che il vecchio slogan per cacciare lo straniero è diventato virale su TikTok. Il medium è nuovo, vecchia la storia che la ferocia, quando si è in gruppo, diventa qualcosa di molto allegro e divertente.