Il nuovo piano del governo per ridurre le liste d’attesa negli ospedali è vecchio
E serve a poco, perché non mette a disposizione abbastanza soldi e non fa cenno a uno dei tanti problemi, cioè le troppe prescrizioni
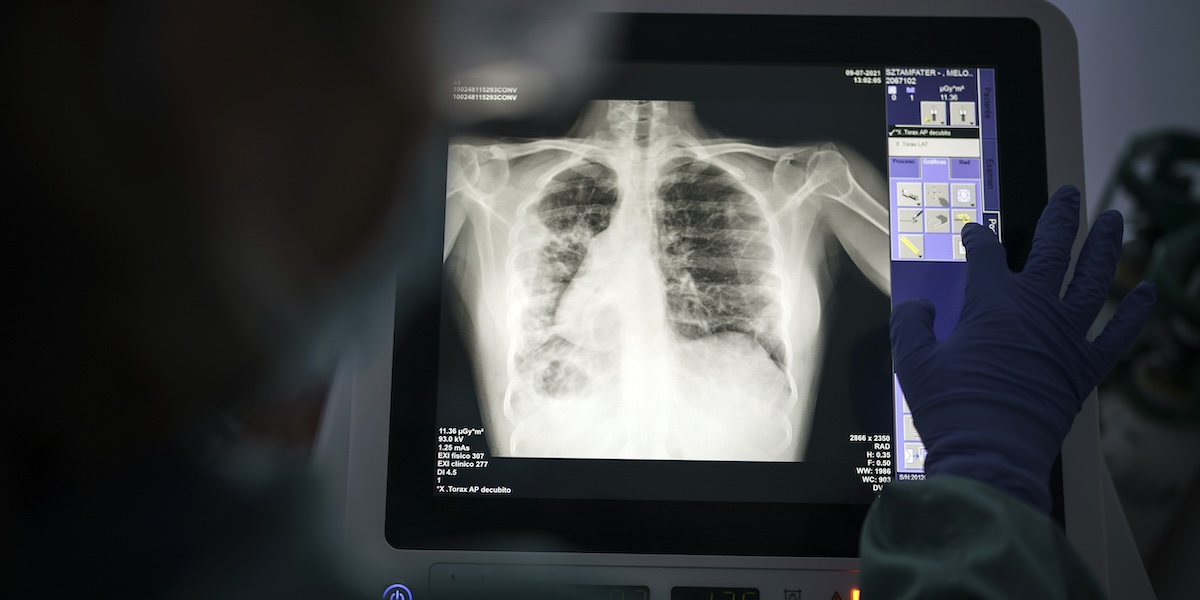
Il decreto del governo per la riduzione delle liste d’attesa negli ospedali, approvato mercoledì dal parlamento, contiene molte misure già previste da anni e soprattutto non è finanziato con fondi sufficienti per cambiare davvero le cose. È stata la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ridimensionare le aspettative: «Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma siamo convinti che la direzione sia quella giusta», ha detto, con una formulazione abbastanza tipica di chi non può promettere risultati straordinari. Eppure prima delle elezioni europee il piano per la riduzione delle liste d’attesa era stato presentato come straordinario e risolutivo, per motivi più che altro elettorali.
Tra le varie novità approvate, una delle più celebrate dal governo è la creazione della piattaforma nazionale delle liste d’attesa, un sistema per controllare che le regioni – in Italia la sanità è di competenza regionale – rispettino le priorità indicate sulla ricetta. Le classi di priorità sono indicate dai medici e sono: U per urgente, B per breve, D per differibile e P per programmata. A ogni classe corrisponde un tempo massimo in cui il sistema sanitario deve garantire la visita o l’esame: entro 72 ore se è urgente, entro 10 giorni se è breve, entro 30 giorni per prestazioni differibili, entro 120 giorni quando sono programmate.
– Leggi anche: Le lunghe liste di attesa negli ospedali, spiegate
In realtà la piattaforma era già prevista a livello regionale dal 2019 e finora non è servita a molto, soprattutto perché ogni regione l’ha costruita con criteri diversi. La novità consiste nel passaggio dei dati dalle regioni all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che avrà più sotto controllo le situazioni critiche.
Un’altra misura riguarda i centri di prenotazione regionale, che dovranno comunicare alle persone i tempi di attesa sia degli ospedali pubblici che di quelli privati accreditati. Gli ospedali privati accreditati forniscono servizi sanitari per conto del servizio sanitario nazionale, che successivamente rimborsa la differenza tra il ticket pagato dal paziente e il costo della visita sulla base di criteri e limiti di spesa decisi dalle regioni. In questo modo, almeno nelle intenzioni del governo, si avrebbero a disposizione agende più chiare e complete, con un risparmio di tempo. Alcune regioni come la Lombardia avevano già provato a creare un’unica agenda, ma con scarsi successi perché le strutture private non vogliono condividere la programmazione dei loro appuntamenti.
Anche la norma chiamata “salta code” non è nuova: prevede che quando non è possibile rispettare i tempi delle priorità indicate nella ricetta ci si possa rivolgere a strutture private, pagando solo il ticket. Il costo della visita dovrebbe essere rimborsato successivamente dalla regione alle strutture private. È una possibilità già prevista da una ventina d’anni e finora quasi mai utilizzata.
Questo diritto non viene garantito un po’ perché le aziende sanitarie e gli ospedali non lo pubblicizzano, e un po’ perché chiudono le agende di prenotazione dicendo di non avere posto e di fare direttamente la visita per via privata. Questa cosa in teoria è illegale, perché elude il rispetto dei tempi di attesa di visite ed esami e limita l’accesso alla sanità.
La mancanza di soldi è il vero problema non risolto dal nuovo decreto. Le poche risorse economiche messe a disposizione dal governo serviranno soprattutto a finanziare una detassazione degli straordinari per incentivare gli operatori sanitari a lavorare di più. Pierino Di Silverio, segretario dell’ANAAO Assomed, uno dei principali sindacati di medici ospedalieri, ha detto che puntare tutto sull’aumento del lavoro straordinario di medici e infermieri non ridurrà i tempi di attesa. «Era un decreto partito con delle intenzioni megagalattiche, è stato svuotato di contenuti economici e di contenuti innovativi», è il commento di Di Silverio. «Già oggi i medici lavorano più di 60 ore settimanali, al limite della legge europea sui riposi, e per oltre il 67% sono già in sindrome di burnout. Nonostante le buone intenzioni, il decreto non risolverà i problemi».
I dubbi dei sindacati sono giustificati da una situazione di partenza davvero complicata, risultato di una gestione approssimativa che si trascina da anni. Secondo un’indagine diffusa mercoledì dall’associazione Cittadinanzattiva, in molte regioni i tempi previsti vengono sforati di molto.
Alcuni esempi: nell’azienda universitaria Friuli centrale si attendono in media 498 giorni per un’ecografia all’addome e 394 giorni per la visita ginecologica, mentre nell’azienda sanitaria 3 della Liguria servono 427 giorni per una visita cardiologica. In molte regioni solo per una minima parte dei pazienti viene rispettato il tempo massimo di attesa indicato dalla ricetta. Nell’ASL Roma 4 solo il 17,6% dei pazienti riesce a fare un’ecografia all’addome entro i 10 giorni previsti, a Napoli solo il 14% delle visite oncologiche rispetta i tempi, a Bari solo il 9% per quanto riguarda le visite pneumologiche. La situazione è complicata un po’ ovunque in Italia, anche nelle regioni considerate virtuose.
Il decreto invece fa poco o nulla per controllare la cosiddetta “appropriatezza prescrittiva”, cioè la richiesta congrua di esami e visite. L’appropriatezza prescrittiva non viene rispettata quando i medici prescrivono più accertamenti sanitari del necessario. Uno dei fattori che spingono questa domanda è la cosiddetta “medicina difensiva”, cioè il ricorso a un gran numero di esami e visite per prevenire il rischio di denunce da parte dei pazienti o dei loro parenti. Questo atteggiamento porta inevitabilmente a prescrivere esami senza rispettare i protocolli indicati per gli accertamenti legati a diverse malattie. La riduzione della domanda di visite è uno degli interventi consigliati da studi nazionali e internazionali in merito alla gestione dei tempi di attesa, ma il decreto non ne fa cenno.



