Sui social si parla troppo di salute mentale?
Gli sforzi di sensibilizzazione e divulgazione aumentano la consapevolezza e riducono lo stigma, ma possono anche accrescere un’inclinazione all’autodiagnosi e favorire la patologizzazione di esperienze comuni

Le correlazioni tra l’utilizzo dei social media e l’aumento dei problemi di salute mentale, soprattutto tra gli adolescenti, sono da diversi anni oggetto di studi e di un dibattito esteso e polarizzato. La ricerca scientifica ha generato analisi contrastanti, condizionate in parte dalla riluttanza delle piattaforme a condividere dati e informazioni, e in parte da una definizione spesso troppo ampia e incoerente dei termini della questione. Queste condizioni, secondo uno studio epidemiologico di revisione di decine di meta-analisi pubblicato nel 2020, hanno portato a trascurare importanti differenze individuali all’interno dei campioni analizzati e a interpretare in modo ambiguo le dimensioni del fenomeno.
Ma un aspetto riguardo al quale diversi professionisti tendono a trovarsi piuttosto d’accordo è in generale l’influenza esercitata dai social media nella crescita di attenzioni intorno alla salute mentale. Alcuni di loro, come scritto a maggio dal New York Times, si chiedono da tempo se quelle attenzioni non siano diventate eccessive.
Da un lato il fatto che si parli di malattie mentali molto più spesso che in passato ha permesso di ridurre la stigmatizzazione sociale, che tra i fattori che ostacolano l’accesso ai trattamenti da parte dei pazienti è da sempre uno dei più potenti. La popolarità dei contenuti relativi alle malattie mentali su piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok ha inoltre moltiplicato i canali attraverso cui è possibile per le persone ricevere informazioni e sostegno psicologico, soprattutto in contesti sociali in cui altre forme di assistenza mancano o sono difficili da ricevere, per ragioni economiche o di altro tipo.
Dall’altro lato la tendenza a trattare temi relativi alle malattie mentali con assiduità su canali utilizzati ogni giorno da milioni di persone, indipendentemente dalle intenzioni e dal livello di competenza di chi lo fa, ha generato anche una serie di effetti controproducenti. Uno di questi, che riguarda in parte anche altri ambiti della medicina, è l’inclinazione di molte persone ad autodiagnosticarsi disturbi mentali. Spesso è un’autodiagnosi fatta sulla base di descrizioni approssimative e parziali da loro apprese attraverso brevi video pubblicati sui social da persone con obiettivi, interessi e standard etici molto eterogenei, sia che abbiano sia che non abbiano una formazione professionale.

Spille e gadget distribuiti durante la giornata mondiale della salute mentale in una scuola a Miami, il 10 ottobre 2023 (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Il principale rischio di questa tendenza è che le autodiagnosi, giuste o sbagliate, bastino ad alcuni pazienti per decidere di gestire in autonomia problemi che richiederebbero invece l’intervento di psichiatri, psicologi o psicoterapeuti, cioè di personale specializzato e diverso a seconda dei casi. L’altro rischio, laddove i pazienti decidano più opportunamente di rivolgersi a un professionista, è che al lavoro necessario per diagnosticare e trattare eventuali malattie mentali si aggiunga un ulteriore e necessario lavoro preliminare di sradicamento della convinzione del paziente di avere una malattia diversa. È un fenomeno descritto da tempo negli Stati Uniti, ma segnalato da diversi professionisti anche in Italia.
Le convinzioni dei pazienti derivano appunto in molti casi da conoscenze superficiali di concetti tecnici come attaccamento o trauma, e di disturbi mentali specifici, come quello bipolare, quello ossessivo compulsivo o quello narcisistico di personalità, per dirne solo alcuni dei più discussi e spesso fraintesi sui social media in tempi recenti. Uno degli effetti negativi della crescita di attenzioni verso i disturbi mentali sui social, in altre parole, è che patologie complesse e ben definite in ambito clinico possono diventare argomenti popolari sugli stessi canali e nelle stesse modalità che rendono popolari ricette culinarie e prodotti di consumo vari: modalità spesso imprevedibili e poco trasparenti.
– Ascolta anche: Siamo tutti narcisisti?
La semplificazione di argomenti complessi in contenuti schematici e assertivi adatti alla circolazione sui social è un fenomeno che interessa molti ambiti della società e molte attività professionali. Nel caso delle malattie mentali determina rischi particolari, tra cui quello di trascurare nella descrizione superficiale e puntuale delle malattie differenze individuali che richiedono la valutazione diretta di uno o una specialista: valutazione necessaria per poter formulare diagnosi attendibili. Riconoscere una serie di sintomi sulla base di un video su TikTok non è sufficiente, e può anzi essere fuorviante, dal momento che malattie diverse possono manifestarsi attraverso gli stessi sintomi, e i sintomi stessi possono anche essere lievi o transitori.

Un messaggio di sensibilizzazione sulla salute mentale mostrato prima di una partita di calcio di Premier League allo stadio St James’ Park a Newcastle, l’11 maggio 2024 (George Wood/Getty Images)
Come scritto sul New York Times dalla psicologa clinica Darby Saxbe, professoressa di psicologia alla University of Southern California, gli effetti problematici della sensibilizzazione sui temi della salute mentale riguardano anche alcuni tentativi strutturali di prevenzione delle malattie mentali tra gli adolescenti nei paesi anglosassoni: tentativi che rischiano di essere inefficaci o persino dannosi, nonostante le buone intenzioni. Saxbe ha citato il WISE Teens, un programma di «formazione sulle abilità socio-emotive» basato sulla terapia dialettico comportamentale (TDC), un tipo di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Consiste in otto sedute settimanali da un’ora tenute in aula da psicologi clinici in formazione, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a gestire le emozioni.
– Ascolta anche: L’espressione “salute mentale” è abusata
Uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista Behaviour Research and Therapy ha confrontato la salute mentale di due gruppi di studenti di licei nell’area metropolitana di Sydney, per un totale di 1.071 studenti osservati tra febbraio 2017 e ottobre 2018. Un gruppo aveva partecipato al programma WISE Teens, l’altro aveva frequentato le normali lezioni scolastiche di educazione fisica e alla salute. I risultati dello studio mostrarono che otto mesi dopo la fine dell’esperimento gli studenti del primo gruppo avevano rispetto a quelli del secondo gruppo più alti livelli di depressione, ansia e difficoltà a gestire le emozioni, e peggiori rapporti con i genitori. Uno studente su otto del gruppo che aveva partecipato al programma WISE Teens mostrava segni clinici di depressione, mentre nell’altro gruppo solo uno su tredici.
Studi precedenti sui programmi di sensibilizzazione sulle malattie mentali nelle scuole, tra cui uno studio ancora più ampio condotto su oltre 8mila studenti del Regno Unito, avevano portato a risultati simili. Frequentare corsi pensati per accrescere la consapevolezza dei problemi di salute mentale non aveva ridotto la probabilità che quei problemi si manifestassero in seguito tra gli adolescenti, e in alcuni casi aveva generato anzi livelli più alti di ansia e minore capacità di gestire le emozioni.
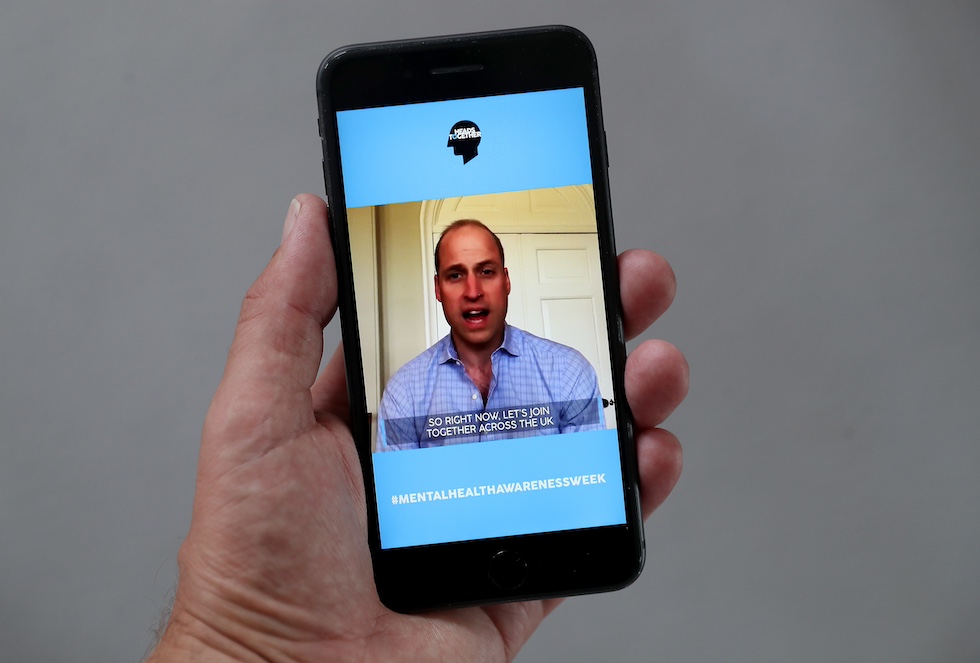
Il principe William, erede al trono britannico, partecipa a una videochiamata organizzata da Heads Together, una fondazione benefica della famiglia reale che si occupa della prevenzione e della cura delle malattie mentali, a Londra, il 18 maggio 2020 (Chris Jackson/Getty Images)
Secondo i sostenitori del WISE Teens la principale ragione dell’insuccesso del programma nei risultati di alcuni studi recenti sarebbe lo scarso coinvolgimento degli adolescenti. Alcuni potrebbero essersi sentiti sopraffatti dalla quantità di informazioni sulla salute mentale fornite durante i corsi, e potrebbero non aver avuto il tempo sufficiente per apprenderle e padroneggiarle. Ma secondo Saxbe è anche possibile che concentrare l’attenzione degli adolescenti sulla salute mentale abbia involontariamente esacerbato i loro problemi. È un’ipotesi definita da una coppia di psicologi dell’università di Oxford, Lucy Foulkes e Jack Andrews, «inflazione da prevalenza»: il fatto che una maggiore consapevolezza dei problemi mentali porti le persone a parlare di normali problemi della vita quotidiana in termini di «sintomi» e «diagnosi».
Secondo Foulkes e Andrews, sebbene dimostrare l’esistenza di una relazione causale tra gli sforzi di sensibilizzazione e la prevalenza dei sintomi sia impossibile, sarebbe comunque utile valutare l’eventuale correlazione tra i due fenomeni nel tempo, nella società. Sarebbe quantomeno possibile verificare attraverso ricerche specifiche, per esempio, se le parole relative al dibattito sulla salute mentale siano state utilizzate più frequentemente sui giornali e sui social media in corrispondenza del periodo in cui i problemi di salute mentale sono aumentati.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak partecipa a un incontro con i medici per discutere dell’integrazione di strutture e interventi gratuiti per la salute mentale nel National Health Service (NHS), uno dei sistemi sanitari pubblici del Regno Unito, durante una visita in un ospedale a Northampton, il 23 gennaio 2023 (Toby Melville/Getty Images)
Indipendentemente dalle eventuali correlazioni, resta il fatto che i problemi di salute mentale sono un argomento molto popolare sui social media, spesso trattato con superficialità. Vale anche per altre malattie, ha scritto a maggio sullo Huffington Post l’epistemologo Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina e di bioetica all’Università Sapienza di Roma. Ma sensibilizzare sulle malattie mentali non è la stessa cosa che farlo «per un tumore o una malattia rara», ha scritto Corbellini, proprio per il tipo di fenomeni particolari che la sensibilizzazione sulla salute mentale attraverso i social può generare.
Quando i tentativi di sensibilizzazione provengono da persone che hanno sofferto di disturbi specifici esiste il rischio che la descrizione e il racconto della malattia attingano unicamente dall’esperienza personale di chi ne parla, a scapito della completezza dell’informazione. In un contesto come quello dei social, dominato da un’agguerrita concorrenza per l’attenzione del pubblico, è inoltre possibile che la sensibilizzazione sia in qualche misura condizionata da incentivi di vario tipo, anche economici. «Se un personaggio ultra-pubblico incrocia per esempio un problema di salute di cui tiene a parlare secondo la sua percezione, per reinvestire del suo narcisismo, le sue tesi diventano eventi mediatici, editoriali», ha scritto Corbellini.
La concentrazione di attenzioni sulla salute mentale attraverso i social ha permesso e permette a molte persone di identificare disturbi che richiedono un trattamento, ha scritto il New York Times. Ma può anche avere effetti negativi su persone portate a sovrastimare sintomi indefiniti e a pensare di soffrire di problemi che non hanno: condizione che può complicare anziché semplificare il lavoro degli specialisti. È un problema che riguarda in parte anche iniziative intraprese nei paesi non anglosassoni, tra cui il “bonus psicologo” in Italia, un contributo economico per aiutare le persone a sostenere le spese per un percorso di terapia psicologica.
Nonostante le critiche per l’insufficienza dei fondi stanziati, il bonus psicologo è stata un’iniziativa largamente apprezzata perché ha permesso prima di tutto di rafforzare nel dibattito pubblico il principio che afferma la salute mentale come un diritto delle persone. D’altra parte esiste il rischio che i criteri di assegnazione del contributo – la fascia ISEE di chi ne fa richiesta (l’indicatore della situazione economica delle famiglie) e l’ordine di arrivo della domanda – determinino una selezione impropria dei beneficiari.
– Ascolta anche: Sono state presentate più di 400mila domande per il “bonus psicologo”
«Il rischio è che a beneficiare [del bonus] possa essere anche chi non ne ha una reale necessità, ma rientra nei requisiti», ha detto ad aprile alla rivista TrendSanità la psicoterapeuta Teresa Cosentino, docente delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva APC e SPC (Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva). Il fatto che la maggior parte delle richieste per il bonus nel 2022 fosse stata presentata da persone minori di 35 anni, per esempio, potrebbe indicare sia un’effettiva maggiore distribuzione dei problemi mentali in quella fascia di età, sia una maggiore consapevolezza.
«I giovani hanno fatto più richieste per il bonus non solo perché sono quelli che hanno subìto di più l’impatto della pandemia ma anche perché sono dotati di strumenti culturali che hanno permesso loro di superare lo stigma nella richiesta di aiuto», disse nel 2022 all’Espresso Elisabetta Camussi, professoressa di psicologia sociale all’Università Milano-Bicocca e presidente della Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini. Tra gli esclusi dal bonus ci sono quindi non soltanto persone che non rientrano nella graduatoria per ragioni di reddito o per indisponibilità dei fondi per chi arriva tardi, «ma anche quella grande parte di popolazione che per mancanza di strumenti non è in grado di formulare la propria richiesta di supporto», e che fatica a rendersi conto di averne bisogno.
– Ascolta anche: La tecnologia va troppo veloce rispetto all’evoluzione?
In linea generale è possibile affermare che una parte della popolazione nei paesi sviluppati sia sottoesposta e un’altra sovraesposta alle campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale. Di quella sovraesposta e tendenzialmente più giovane potrebbero far parte anche adolescenti che stanno ancora sviluppando la loro identità e che a fronte di sintomi lievi o transitori potrebbero essere inclini ad attribuire un significato eccessivo a definizioni e categorie, ha scritto Saxbe sul New York Times.
È un dibattito che nel contesto anglosassone va avanti da diversi anni e presenta alcune specificità, perché si interseca con quello – molto polarizzato – sulla politica identitaria (identity politics): un approccio alla teoria e all’azione politica che interpreta la realtà e i suoi problemi principalmente sulla base delle identità etniche, religiose, di genere, di orientamento sessuale e anche, specialmente negli ultimi anni, identità legate a problemi di salute, inclusi quelli di salute mentale.

L’attrice statunitense Selena Gomez partecipa a una conferenza alla Casa Bianca sulla salute mentale dei giovani, a Washington, il 18 maggio 2022 (AP Photo/Jacquelyn Martin)
L’autodiagnosi di condizioni neurologiche, malattie mentali e disturbi della personalità associata all’uso dei social media è considerata un problema rilevante perché complica ulteriormente un dibattito già molto difficile, e rischia di mettere sullo stesso piano aspetti dell’identità della persona indiscutibili e immutabili, come per esempio la provenienza etnica, con altri che in teoria dovrebbero essere valutati da specialisti e che non sono necessariamente permanenti, come un disturbo d’ansia o uno stato depressivo. Da una parte insomma accresce il rischio di interpretare condizioni emotive comuni e transitorie come neurodiversità da considerare e gestire con maggiore serietà, e dall’altra parte – a causa della limitazione delle risorse pubbliche disponibili – riduce per le persone effettivamente malate le opportunità di ricevere trattamenti, aumentando la platea di chi ritiene di averne bisogno.
In generale, secondo Saxbe, «è un segno di progresso quando diagnosi che un tempo venivano sussurrate in vergognosa segretezza entrano nel nostro vocabolario quotidiano e perdono il loro stigma». Ma soprattutto sui social, dove gli algoritmi intensificano nei feed di determinate persone la visualizzazione di contenuti incentrati su traumi, attacchi di panico e disturbi della personalità, la maggiore consapevolezza dei problemi di salute mentale rischia di incoraggiare la patologizzazione di emozioni comuni. E rischia di favorire una tendenza a considerare i problemi quotidiani come insormontabili: «Invece di dire “sono nervoso per X”, un adolescente potrebbe dire “Non posso fare X perché ho l’ansia”».
– Ascolta anche: La scomparsa della noia
Attribuire un’etichetta ai propri sintomi potrebbe non essere utile di per sé, ha scritto a maggio il New York Times, segnalando uno studio recente condotto da diverse università e istituti statunitensi su un campione di 1.423 studenti universitari. Il 22 per cento del campione si era autodefinito affetto da depressione, ma una percentuale superiore – il 39 per cento – soddisfaceva i criteri diagnostici per la depressione. Gli studenti che si autoetichettavano come depressi sentivano però di avere meno controllo sulla depressione, rispetto ai loro coetanei che avevano sintomi di depressione simili, ed erano meno propensi a reagire al disagio mettendo le loro difficoltà in prospettiva.
Le persone che si autoattribuiscono un’etichetta «sembrano considerare la depressione come un’inevitabilità biologica», e quelle «che non vedono le emozioni come malleabili, e le vedono come fisse, bloccate e incontrollabili, tendono a gestirle meno bene perché non vedono un motivo per provarci», ha detto la psicologa Jessica L. Schleider, coautrice dello studio. I risultati dello studio, secondo lei, suggeriscono che non ci sia un problema di sovrastima delle diagnosi, ma piuttosto che le campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale siano destinate ad avere molteplici effetti, positivi per alcuni studenti e negativi per altri.
L’ipotesi dell’inflazione da prevalenza rimane un punto di vista minoritario tra gli specialisti della salute mentale che si occupano di adolescenti. L’ipotesi su cui la maggior parte di loro è invece d’accordo è che l’accesso alle cure sia pesantemente condizionato, più che da storture o difetti delle campagne di sensibilizzazione, da una grave indisponibilità di risorse sanitarie. «La dura verità è che l’impennata dei tassi di depressione e ansia adolescenziale rappresenta un problema strutturale che richiede soluzioni strutturali, compresa la formazione di una forza lavoro molto più ampia di terapisti», ha concluso il New York Times.



