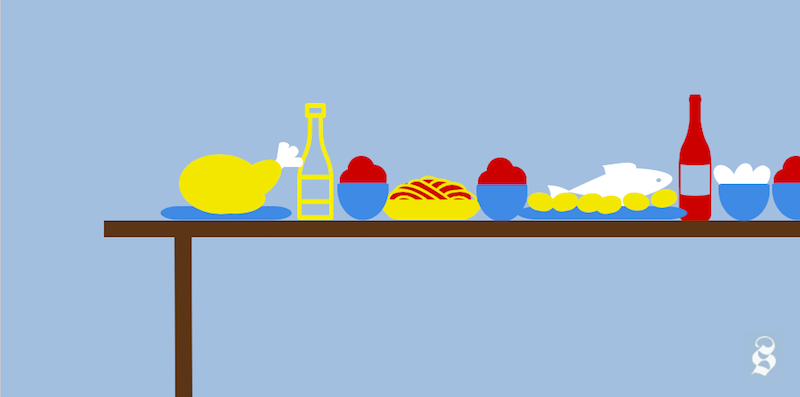La democratizzazione della scuola, cinquant’anni fa
I cosiddetti "decreti delegati" furono fondamentali per la storia politica dell'istruzione italiana, sebbene siano stati criticati, fin dall'inizio, da chi li aveva promossi

Il 31 maggio del 1974, cinquant’anni fa, furono approvate delle norme note come “decreti delegati” in attuazione di una legge dell’anno prima. I decreti delegati furono fondamentali per la storia politica della scuola e per il suo processo di democratizzazione perché, contro il tradizionale centralismo dell’amministrazione scolastica, introdussero, tra le altre cose, gli organi collegiali: il collegio dei docenti, il consiglio di classe e quello di istituto. E furono la risposta delle istituzioni – sebbene come risultato di un compromesso al ribasso – alle richieste studentesche di partecipazione nate durante le proteste del Sessantotto e dei primi anni Settanta.
L’anno dell’inizio di qualcosa di nuovo per la storia dell’istruzione fu il 1958 quando, dopo le elezioni politiche di maggio, il governo affidato al segretario della Democrazia cristiana Amintore Fanfani segnò la fine del centrismo e l’avvio di un lento avvicinamento tra democristiani e socialisti: da quel momento, come spiega Monica Galfré nel libro sulla storia della scuola nell’Italia del Novecento edito da Carocci e intitolato Tutti a scuola!, «l’istruzione e i suoi problemi entrarono ufficialmente in una logica di programmazione simile a quella con cui si discuteva di economia secondo il trinomio indagine-programmazione-riforme comune a molti dei paesi europei».
Si trattava, in quel momento storico, di trasformare un’istruzione che era sempre stata di pochi e per pochi in un’altra che rispondesse alle esigenze di una società sempre più complessa, articolata e che aveva preso la via dell’industrializzazione. Una prima svolta fu l’introduzione della scuola media unica con una legge del 1962 approvata dal governo di Fanfani con l’appoggio esterno dei socialisti. L’obiettivo era offrire una formazione di base sia a chi avrebbe sia a chi non avrebbe proseguito gli studi: «Tutti i bambini classe 1952 della penisola, di città e di campagna, dalle Alpi alla Sicilia» racconta Galfré, furono chiamati «a frequentare lo stesso tipo di scuola, uguale nei programmi, negli orari, nelle opportunità».
Qualche anno dopo, nel marzo del 1968, venne poi istituita la scuola dell’infanzia statale per offrire l’opportunità di una frequenza più ampia possibile: non obbligatoria ma gratuita, spiega Galfré, alla scuola dell’infanzia vennero attribuite funzioni pedagogiche, assistenziali e sociali, «funzioni integrative e compensative rispetto alla famiglia». E se da una parte l’istituzione della media unica e della scuola dell’infanzia statale pose le basi per un innalzamento culturale, dall’altra ebbe dei limiti evidenti: gli interventi si limitavano infatti a un solo segmento dell’intero sistema scolastico e lasciavano sostanzialmente inalterato tutto il resto. Per Galfré i processi che interessarono la scuola e il mondo giovanile nel decennio successivo ebbero in parte origine proprio da questo.
Le contestazioni studentesche del Sessantotto che portarono anche la scuola a diventare un luogo di conflitto e uno dei luoghi dove si manifestò con più radicalità l’esigenza di partecipazione collettiva del periodo iniziarono in realtà nel 1966 quando un gruppo di studenti occupò la facoltà di Sociologia dell’università di Trento dando inizio a una rivolta sociale, politica e culturale che poco dopo si saldò con le contestazioni degli operai delle fabbriche che avevano cominciato a scioperare.
Quello stesso anno sulla Zanzara, il giornale studentesco del liceo Parini di Milano, venne pubblicata un’inchiesta intitolata “Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso”. Nell’inchiesta si affrontava la questione del sesso al di là dei condizionamenti della morale del tempo e della religione. Ne nacque uno scandalo, il preside e i tre autori dell’articolo, tutti minorenni, furono incriminati e poi assolti. Ma quella, come ha raccontato Christian Raimo sul Post, venne considerata la prima presa di parola da parte degli e delle studenti a cui ne seguirono migliaia in tutta Italia e che poi si trasformarono in picchetti e mobilitazioni permanenti.
L’anno dopo, nel 1967, venne pubblicato “Lettera a una professoressa” che don Lorenzo Milani, prete, maestro e educatore, aveva scritto con otto suoi allievi della scuola popolare di Barbiana, un piccolo paese della montagna toscana. Il libro era un atto d’accusa verso l’intero sistema scolastico: verso l’arretratezza e la disuguaglianza ancora presenti nella scuola italiana che sembrava essere ispirata da un principio classista e non di solidarietà, che favoriva l’istruzione delle classi più ricche e di chi già era in grado di farcela, mentre agli altri diceva che non erano adatti allo studio e che era meglio se fossero andati a zappare la terra.
– Leggi anche: Don Milani e “la scuola come un ottavo sacramento”
Tra la fine del 1967 e i primi mesi del 1968 le occupazioni delle università si diffusero, contagiarono i licei delle città e poi gli istituti tecnici e professionali anche delle province. La lotta dentro la scuola diventò una lotta contro la scuola per reclamare il diritto di assemblea, un metodo di lavoro differente, di gruppo per non penalizzare gli svantaggiati, e interdisciplinare. Si chiedevano una modifica dei programmi per avvicinare l’insegnamento alla società che stava prendendo corpo, per sganciare l’insegnamento dalla valutazione, per favorire un approccio critico e non più passivo e mnemonico.
Cominciarono ad assumere un ruolo nuovo e attivo anche i genitori. In quegli anni nacque il Centro operativo tra genitori per l’iniziativa democratica antifascista nella scuola (Cogidas) e l’Associazione genitori a livello nazionale (Age), con sede a Roma. Molti e molte docenti, tra i quali si avviò un largo processo di sindacalizzazione, parteciparono e sostennero attivamente la richiesta di democratizzazione dell’istituzione scolastica e furono moltissimi i casi di repressione avviati contro di loro dal ministero che si servì di diversi strumenti: le ispezioni, i trasferimenti d’ufficio e le “note di qualifica”, cioè giudizi annuali sulle capacità degli insegnanti che impattarono direttamente sulla loro carriera e sui loro stipendi.
Le “note di qualifica” furono abolite proprio dai decreti delegati il cui iter legislativo cominciò nel 1970 con un dibattito parlamentare che stava cercando di accogliere quel desiderio di democratizzazione e partecipazione “dal basso” nella scuola che si era manifestato in modo così evidente. Nel luglio del 1973 venne dunque approvata la legge delega numero 477 con cui si dava mandato al governo di intervenire in modo organico sul sistema scolastico italiano. Nel maggio del 1974 vennero infine approvati i decreti delegati relativi a quella legge. Erano cinque.
Il primo, il numero 416, si occupava dei cosiddetti organi collegiali, le assemblee con potere decisionale che oggi costituiscono, almeno in teoria, l’infrastruttura democratica della scuola: il consiglio di classe, esportato anche alle elementari come consiglio di interclasse, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto o i consigli scolastici distrettuali, poi soppressi. L’obiettivo, diceva la legge all’articolo 1, era realizzare «la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica».
Il decreto numero 417 riconosceva la libertà di insegnamento già sancita dall’articolo 33 della Costituzione italiana e definiva la funzione del docente «intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla rielaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». Sempre nello stesso decreto si stabilivano i limiti della funzione direttiva, ossia i compiti del preside o del direttore didattico, e si riconosceva la libera associazione sindacale dei docenti, dei presidi e degli ispettori. I restanti tre decreti delegati comprendevano, tra le altre cose, la legittimità del pagamento degli straordinari al personale direttivo ed ispettivo, normavano il trattamento economico del personale non docente, regolavano le sperimentazioni nella scuola sul piano metodologico-didattico e su quello di nuovi ordinamenti scolastici che si concretizzarono, subito dopo, nel Piano Nazionale Informatica.
Alle prime elezioni nel febbraio del 1975 per consigli d’istituto, collegi docenti, consigli di classe parteciparono milioni di persone, con una percentuale media di oltre l’80 per cento: fu una «tra le elezioni più partecipate della storia repubblicana», scrive Raimo.
– Leggi anche: L’epopea delle 150 ore
Quando venne approvata, la riforma dei decreti delegati fu però contestata da parte di quegli e di quelle studenti che l’avevano sostenuta: ne erano rimaste fuori importanti questioni come l’edilizia scolastica, l’università, il diritto allo studio. E anche ciò che invece era presente era stato il risultato di un compromesso al ribasso con uno scarto notevole tra le intenzioni della legge delega e la loro concretizzazione nei decreti delegati: uno scarto che era andato a scapito della democrazia diretta e a favore di una ristretta democrazia rappresentativa molto macchinosa. I consigli di istituto, ad esempio, a cui la legge delega aveva assicurato poteri deliberativi per l’organizzazione della vita scolastica, con i decreti delegati mantennero la possibilità di legiferare solo nell’ambito delle attività parascolastiche, extra-scolastiche e integrative.
«Sono “riforme” che a parole consentono il massimo della democrazia, ed in ogni caso sempre delegata, nei fatti poi mantengono tutto come era prima», scriveva ad esempio uno studente ligure subito dopo il maggio del 1974. E ancora: «Questa “rivoluzione silenziosa”, come amano definirla i capoccioni Dc e i mezzibusti televisivi, è tanto rivoluzionaria da prevedere organismi di gestione sociale, che, a ben guardare, non gestiscono niente o quasi, e dove, comunque, preside e prof sono in numero uguale o superiore a quello di studenti e genitori (senza contare la possibile e probabile strumentalizzazione in senso conservatore di questi ultimi)».
Molto critici furono anche i comunisti che su Riforma della Scuola, rivista del PCI che si occupava di politica scolastica, dissero che i decreti erano una riforma che voleva «realizzare un tipo di gestione circoscritta e indolore in cui, attraverso il dosaggio delle componenti e il giuoco delle mediazioni» si intendevano «smorzare spinte e tensioni». Di fatto, molti degli elementi introdotti dalla riforma svuotarono di significato alcuni degli istituti democraticamente più innovativi a cui si era pensato con conseguenze che, secondo diversi studiosi e studiose della scuola, si trascinano ancora oggi.