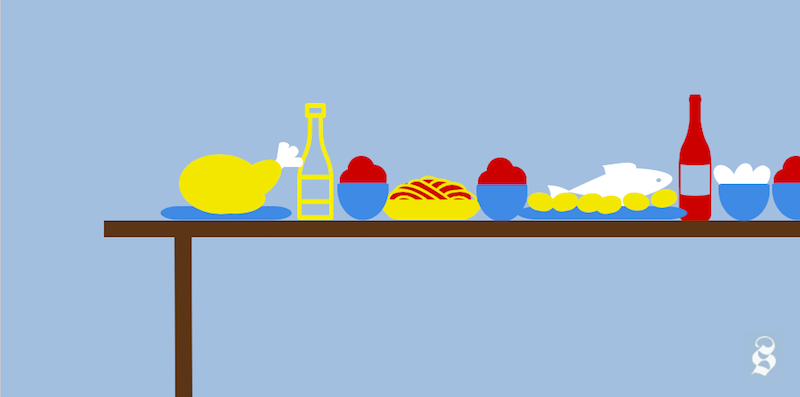Perché non ricordiamo Gabriella Ferri
«Lei era Roma per me: sorrideva pur essendo triste, gli occhi bistrati e chiarissimi. Il suo corpo mi pareva il corpo della città. Era facile riconoscerla nelle sue canzoni, era evidente che le paillettes e i foulard, gli abiti fuori misura coincidessero con le contraddizioni e la pietas della città. La tragedia della donna che si butta nel Tevere per un amore finito in "Barcarolo romano" racconta lo stesso fiume che abbraccia l’Isola Tiberina e l’ospedale Fatebenefratelli, dove sono nate generazioni di romani. A me sembra che finché Roma è rimasta "india, pigra e furba" come il padre di Gabriella Ferri, lei, come tutte le maschere, non ha avuto bisogno di presentazioni perché il luogo da cui veniva era la sua vera identità. Ma dopo l’inizio e la consacrazione, è arrivata la consapevolezza, il timore di ritrovarsi alla fine di un percorso»

Quando ho visto Gabriella Ferri per la prima volta avevo cinque anni, era il 1973 e il programma era Dove sta Zazà. Rimasi ipnotizzata. La voce roca, la cupezza del sorriso, una donna con la paglietta glitterata, giacca e pantaloni larghissimi, due pomelli rossi sulle guance. Si sedimentò, quell’immagine, dentro di me come un’icona, per sempre. Non sapevo niente di lei, la prima volta che l’ho sentita cantare, ma credo – sono certa – di aver visto Roma, di aver capito, a quel livello prelinguistico che è già verità, che lei stesse parlando anche di me, delle mie radici, che fosse sempre appartenuta alla mia storia e alla mia famiglia. Lei era la canzone popolare, era il folk romano già da circa vent’anni. Quasi nessuno dei ragazzi con cui quotidianamente mi confronto, a scuola e fuori, ricorda Gabriella Ferri. È infinito il disorientamento che provo nel constatare che il tempo sgretola quello che io do per acquisito – in particolare le presenze che ritengo indistruttibili all’interno della memoria collettiva – ogni volta che nomino un’idea, uno slogan, un artista del passato. Succede ogni giorno.
Gabriella Ferri era per me la voce di Roma. Potrebbe esistere, forse, una definizione meno retorica ma, in questo caso, la retorica è il più limpido degli specchi: una lingua che restituisce esattamente quel che esiste. Tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, Roma era un’immensa borgata composta da quartieri più piccoli, con un forte senso identitario ma consapevoli – fieri – di condividere e rappresentare l’anima della stessa città. Roma era il posto del popolo, delle botteghe, delle sedie fuori dai vicoli, dei palazzi in cui il lutto di una famiglia era quello di tutti. Era un paesone suddiviso in tanti piccoli paesi dove la vita di ciascuno era di pubblico dominio e dove anche i bambini che giocavano in piazza sapevano quante bottiglie di rosso il vecchio del mezzanino aveva comprato ai Vini & Oli sotto casa.
Per parlare del popolo non serviva ancora la retorica: quelli che ora sono quartieri abitati da chi finge di essere povero, all’epoca erano borgate popolari in cui viveva chi faticava a fare tre pasti al giorno. Il popolo di Roma – cinico, guascone e strafottente, ma sostanzialmente ingenuo, anzi: fregnone – mi sembra essere scomparso dagli anni Ottanta in avanti, polverizzato dal canone di bellezza, ricchezza e benessere che si stava affermando e che avrebbe generato intorno alla metà degli anni Dieci del Duemila il canone contrario, l’esaltazione dell’ignoranza, della schiettezza e della volgarità, idealizzate in povertà. Credo, forse perché ci sono nata e ci vivo da sempre, che Roma abbia rappresentato questo passaggio più di altre città italiane. E che Gabriella Ferri ne sia stata una figura centrale (e forse per questo dimenticata).
Maria Gabriella Ferri nasce a Testaccio nel 1942, figlia di un venditore ambulante, lascia la scuola in quarta elementare e inizia a lavorare a dodici anni. Suo padre mandava lei e la sorella Maria Teresa, da sole, «a vendere lamette agli zingari in mezzo alle vacche». Quando parla di suo padre, intervistata da Maurizio Costanzo a Bontà loro, nel 1976, dice: «Lui cercava di fare i soldi, s’era comprato un Transit, ci aveva scritto sopra GABRIELLA FERRI, andava nei paesi, si faceva dare due polli, sei uova, con la scusa di far cantare la figlia». Il piglio fatalista, un’audacia apparentemente priva di fragilità Gabriella Ferri la eredita dal padre. «Era un indio, un indio pigro. È stato seduto una vita a leggere il giornale».
Non è strano che il suo primo, clamoroso successo nel 1970 sia stato La società dei magnaccioni in coppia con Luisa De Santis (“Luisa e Gabriella, le Romanine”, così le chiamavano i giornali). La canzone romana aveva sfondato il tetto di cristallo, le due ragazze diventarono famosissime, si trasferirono a Milano, conobbero Camilla Cederna, la famosa giornalista di costume che diventò una firma politica scrivendo sulla strage di piazza Fontana e per chiedere le dimissioni del presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Nel 1997 Luisa De Santis, intervistata da Gianni Minà, avrebbe raccontato: «Io ho smesso soprattutto perché avevo paura del pubblico, quindi soffrivo il palcoscenico e per me era uno stress enorme. Non ce la facevo. Poi, in ogni caso, lei non aveva nessun bisogno di me. Gabriella era, già allora, una grande protagonista, una grande cantante, e quindi era assolutamente ridicolo stare lì a fare i coretti». Ferri continua da sola. Al sogno di fare l’indossatrice si sostituisce la passione per l’arte. Racconta Renzo Arbore che, appena arrivato da Foggia, dopo aver vinto un concorso alla Rai, si ferma dal bar Rosati a piazza del Popolo. L’unica persona che gli si avvicina è Gabriella Ferri: «E tu chi sei?» gli chiede, con la sfrontatezza curiosa che è tipica dei romani. «Sono Renzo Arbore, ho vinto un concorso alla Rai».
«Ah, vabbè. Annamo a balla’».
Per molti era difficile sottrarsi al fascino di Gabriella Ferri: aveva i lineamenti forti e delicati, allegri ma anche tristi, a me fanno pensare a una città indifesa che cerca di resistere. Avvertiva l’urgenza di sottrarsi alle etichette, si rifiutava di essere considerata soltanto una cantante folk. «Me dicheno che qui chi resta mòre, che st’aria maledetta nun perdona», canta in M’hai messo le catene. La potenza della sua voce è tutt’uno con l’esigenza di una libertà e di una pace mai raggiunte del tutto. Si trasferisce in Congo con il primo marito ma, dopo poco tempo, vuole tornare a Roma. Divorzia. Ama la musica beat, si esibisce nei locali underground, ma anche al Piper e al Bagaglino. Canta a Sanremo con Stevie Wonder, canta (benissimo) La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Recita a teatro, conduce trasmissioni televisive, va in tournée in tutto il mondo (in America Latina conosce il secondo marito da cui avrà l’unico figlio). «Senza pelle», «fuori ordinanza», «diversa da tutto e tutti»: sono le descrizioni più usate dalla stampa e dalla televisione degli anni Settanta per descrivere Gabriella Ferri. In un’intervista del 1976 risponde a Warner Bentivegna a proposito dei suoi studi: «Io non so fare nemmeno le sottrazioni. Però conosco Cartesio. Conosco molte altre cose».
Gabriella Ferri era Roma per me: sorrideva pur essendo triste, gli occhi bistrati e chiarissimi. Il suo corpo mi pareva il corpo della città. Era facile riconoscerla nelle sue canzoni, era evidente che le paillettes e i foulard, gli abiti fuori misura, il trucco pesante coincidessero con le contraddizioni e la pietas della città, anche quando cantava canzoni che romane non sono, come Dove sta Zazà, Lacreme napulitane, Luna rossa, Malafemmena – perché le radici, sotto la terra, si toccano e s’intrecciano – Vecchio frack. La tragedia della donna che si butta nel Tevere per un amore finito in Barcarolo romano racconta lo stesso fiume che abbraccia l’isola Tiberina e l’ospedale Fatebenefratelli, dove sono nate generazioni di romani. A me sembra che finché Roma è rimasta «india, pigra e furba» come il padre di Gabriella Ferri, lei, come tutte le maschere, non ha avuto bisogno di presentazioni perché il luogo da cui veniva era la sua vera identità. Ma se La società dei magnaccioni era stato l’inizio di tutto, se Barcarolo romano e Sinnò me moro erano state la consacrazione, Grazie alla vita – la versione italiana della canzone di Violeta Parra – è la consapevolezza, il timore di ritrovarsi alla fine di un percorso.
Dagli anni Ottanta in poi Roma si è smarginata. I quartieri si sono frammentati fino a perdere la loro lingua comune. Roma è irriconoscibile. Come Gabriella Ferri negli ultimi anni, sul corpo porta i segni della grave depressione che, nel 1997, la costringe al ritiro dalle scene. Intervistato da Rai Storia, il figlio Seva Borzak Jr dice: «Io non penso che lei si sia allontanata dal pubblico che tanto la amava, lei si è allontanata da un mondo che vedeva violento, bugiardo: il mondo dello spettacolo. Il mondo in cui si utilizza al massimo l’arte, la creatività che proviene dalle parti più intime, dalle parti più vulnerabili di una persona solo per scopi commerciali». Nel 2002 Gabriella Ferri torna, in qualità di ospite, nei programmi Cominciamo bene di Pino Strabioli e Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Mentre Roma diventava altro, e non esisteva più Testaccio, né Trastevere, né il centro storico, né la Garbatella, né Prati, né nessun quartiere di Roma ancora animato dallo spirito di una comunità non solo nominale, Gabriella Ferri si trasferisce in provincia di Viterbo, a Corchiano, dove muore il 3 aprile 2004, vent’anni fa. Il suo corpo, dimenticato, dovrà aspettare un mese al cimitero del Verano prima di essere tumulato.