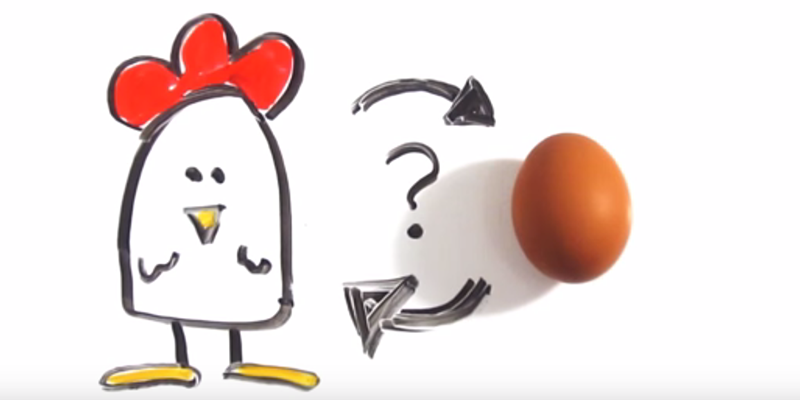Roma e la strage nazista delle Fosse Ardeatine
Ottant'anni fa 335 uomini di ogni estrazione sociale vennero uccisi vicino alle cave di tufo lungo la via Ardeatina, nell'unica azione punitiva di questo genere avvenuta dentro una grande città

Il 24 marzo del 1944 i soldati nazisti guidati da Herbert Kappler, ufficiale delle SS e comandante della polizia tedesca a Roma, spararono a 335 uomini riempiendo con i loro corpi le cave di tufo che si trovavano lungo la via Ardeatina, poco fuori città, e che da quel momento in poi cambiarono il loro nome in “fosse”. Il massacro avvenne 24 ore dopo un’azione dei partigiani e delle partigiane in via Rasella e fu reso noto solo a esecuzione avvenuta. Come ha raccontato lo storico romano Alessandro Portelli nel libro L’ordine è già stato eseguito, le Fosse Ardeatine non furono né l’unica né la peggiore delle stragi naziste. Ma furono «l’unica strage “metropolitana” avvenuta in Europa», in una città che oppose ai nazisti «una resistenza attiva e passiva intensa e diffusa» e che per questo venne così duramente colpita.
Il 25 marzo del 1944 sui giornali romani venne pubblicato un comunicato emanato dal comando tedesco della città occupata di Roma:
Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bomba contro una colonna tedesca di Polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della Polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti.
La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani […]
Il Comando tedesco è deciso a stroncare l’attività di questi banditi scellerati […] perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato dieci criminali comunisti-badogliani saranno fucilati. Quest’ordine è già stato eseguito.
La “vile imboscata”, come la definirono i nazisti, avvenne il 23 marzo in via Rasella, una strada lunga e stretta parallela a via del Tritone. Quella di via Rasella fu una delle azioni più efficaci portate avanti dai partigiani e dalle partigiane dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) in cui furono uccisi 32 membri del Polizeiregiment “Bozen”, un reparto sotto diretto comando della polizia nazista creato in Alto Adige nell’autunno del 1943, quando l’esercito tedesco occupò la regione.
L’azione di via Rasella non si concluse in realtà con la sola esplosione di una bomba, e per questo motivo alcuni storici faticano a definirla un “attentato”. L’esplosione della bomba fu infatti seguita da lanci di granate e sparatorie, dall’irruzione da parte dei tedeschi in case e botteghe del quartiere e da rastrellamenti che durarono fino a sera. Nelle cantine del Viminale vennero ammassate oltre 300 persone e la verifica del loro coinvolgimento nell’azione andò avanti fino alla mattina dopo.

Abitanti e passanti allineati davanti a Palazzo Barberini, accanto a via Rasella, a Roma, il 23 marzo del 1944 (ANSA ARCHIVIO/CRI)
Nel frattempo quanto accaduto venne comunicato a Adolf Hitler che chiese una punizione esemplare: far saltare il quartiere, evacuarlo, e fucilare cinquanta italiani per ognuno dei soldati nazisti morti. Perfino ai colonnelli tedeschi di comando a Roma la decisione sembrò eccessiva. Presero dunque tempo e avviarono una trattativa con Hitler che si concluse con la decisione di ridurre il rapporto a dieci a uno. Alle 23 di quello stesso giorno arrivò un’ultima disposizione da parte di Hitler: l’esecuzione doveva avvenire entro le 24 ore.
Nella notte Kappler cominciò dunque a stilare le liste. Si decise, inizialmente, che andassero scelte persone già condannate alla pena di morte, che però non erano più di quattro. Allora i criteri della ricerca si allargarono: alle persone già in arresto per azioni contro le leggi tedesche e passibili di pena di morte, alle persone incarcerate ma non ancora condannate, a quelle passibili o condannate ai lavori forzati e ad altre arrestate perché si trovavano nelle vicinanze di via Rasella. E poi agli ebrei, ai presunti oppositori politici, ai comunisti. Dovevano insomma raccogliere nel giro di poche ore 320 nomi che divennero 330 nel corso della notte, dopo la morte di un altro soldato sudtirolese per le conseguenze dell’esplosione.
Alla fine vennero inclusi nella lista dieci ebrei arrestati il giorno prima, ma quando arrivò il mattino mancavano ancora cinquanta persone. I tedeschi chiesero allora aiuto alle autorità italiane, che dipendevano dalla Repubblica di Salò, creata da Benito Mussolini nel Nord Italia dopo il suo arresto nel 1943 e la successiva liberazione. Il questore di Roma andò dal ministro dell’Interno, Guido Buffarini Guidi, che per caso si trovava a Roma. Svegliandolo la mattina nel suo albergo gli disse delle richieste dei tedeschi e Buffarini Guidi, preoccupato, gli rispose di procedere. Alla fine Kappler riuscì a chiudere la sua lista: ne facevano parte 335 persone, cinque in più di quanto stabilito.
A quel punto andava trovato un luogo adatto, una «camera mortuaria naturale», come dirà più tardi Kappler. I prigionieri vennero ammassati su dei camion e portati poco fuori Roma, vicino a delle cave che il comandante della polizia tedesca aveva ispezionato in passato alla ricerca di rifugi antiaerei. Lì i prigionieri vennero uccisi a gruppi di cinque. «Ordinai che tutti gli appartenenti al comando dovevano sparare almeno una volta e diedi istruzioni circa il modo di eseguire l’esecuzione», racconterà Kappler durante il processo che si tenne alla fine degli anni Quaranta. E ancora: «Nonostante il breve tempo bisognava mantenere, per quanto possibile, l’usuale procedura di esecuzione; l’ordine di fuoco doveva essere dato da un ufficiale; i plotoni dovevano essere cambiati, così anche il modo di esecuzione. Il colpo al cervello fu ordinato da me. Il numero delle vittime in proporzione ai miei uomini non ammetteva che su ogni vittima si sparasse più di un colpo. L’unico colpo sicuro era al cervelletto. Per evitare il deterioramento dei cadaveri e per riguardo al senso fisico e psichico della vittima diedi ordine di non appoggiare l’arma e che nonostante questo, il colpo venisse sparato dalla più vicina distanza possibile per essere sicuri dell’effetto».
Kappler stesso uccise personalmente molti dei prigionieri, aiutato dai suoi ufficiali, tra cui anche il capitano Erich Priebke. Le SS andarono avanti per tutta la giornata. La sera del 24 marzo tutti i 335 erano stati uccisi e l’ingresso delle grotte della cava venne fatto esplodere.

Le tombe dei 335 uomini morti alle Fosse Ardeatine (GIUSEPPE GIGLIA/ANSA/LI)
Lo storico Alessandro Portelli, ricostruendo cosa accadde attraverso il racconto di più di duecento persone, spiega come quello delle Fosse Ardeatine non fu il peggior massacro che successe in Italia in quegli anni, né in Europa. Ma fu quello che ebbe, e che continua ad avere ancora oggi, una valenza simbolica ineguagliata. Per almeno due ragioni: il luogo in cui avvenne e per come è ricordato.
Roma era la capitale e le altre decine di stragi naziste commesse in giro per l’Italia avvennero in contesti più piccoli, rurali, nei quali la composizione delle vittime era relativamente omogenea. Alle Fosse Ardeatine morirono persone di tutte le classi sociali, dagli aristocratici ai venditori ambulanti, dagli operai ai professionisti. Persone che provenivano, come dimostrano le tante targhe e lapidi commemorative sparse per la città, da ogni quartiere e borgata di Roma: Trastevere e Montesacro, Torpignattara e Trionfale, Portico di Ottavia e Centocelle, Testaccio e La Storta.
Molti degli uomini che furono uccisi, scrive sempre Portelli, erano nati a Roma, ma a Roma la gente era venuta «da tante parti, e alle Fosse Ardeatine finirono vite cominciate in Abruzzo, in Puglia, a Torino, nei Castelli romani, e in Lussemburgo, in Ungheria, in Turchia, in Ucraina….». E poi c’erano cattolici, ebrei, atei, socialisti, liberali, democristiani, un prete, monarchici, persone prive di appartenenza politica, comunisti e anche ex fascisti come Aldo Finzi, che nel primo governo Mussolini era stato sottosegretario all’Interno e che in seguito partecipò attivamente alla Resistenza. Alle Fosse Ardeatine, come ha confermato il politico, sindacalista e scrittore Vittorio Foa, vennero uccisi «gli ebrei perché erano ebrei […], gli antifascisti per quello che pensavano e facevano […] e uomini che non c’entravano nulla, solo perché erano dei numeri da completare per eseguire l’ordine». Per questo è così difficile trovare un termine comune per mettere insieme tutti i 335: non erano né tutti partigiani, né tutti patrioti, né vittime (definizione rifiutata da molti dei familiari), né italiani, poiché undici erano stranieri. Erano tutti uomini, questo sì.
Un’altra delle ragioni per cui il massacro delle Fosse Ardeatine è differente è una narrazione che ne è stata spesso fatta, che di fatto rovescia la responsabilità del massacro sui partigiani per l’azione di via Rasella, e che di quest’ultima mette in dubbio l’opportunità e la legittimità sostenendo che la strage avrebbe potuto essere evitata se i partigiani si fossero consegnati ai tedeschi. Questa narrazione delle Fosse Ardeatine si basa infatti su una simmetria e un automatismo: tra l’azione dei partigiani e la reazione dei nazifascisti, tra l’attentato e la rappresaglia.
– Leggi anche: Storia dell’attentato di via Rasella
È una versione che spesso viene condivisa dalle destre e che ha una lunga storia. Iniziò infatti il giorno dopo il massacro quando l’Osservatore Romano, organo ufficiale del Vaticano, riportando il comunicato tedesco, aggiunse questo commento: «Di fronte a simili fatti ogni animo onesto rimane profondamente addolorato in nome dell’umanità, e dei sentimenti cristiani. Trentadue vittime da una parte; trecentoventi persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all’arresto, dall’altra».
Per Portelli non c’è alcun rapporto giustificabile di causa ed effetto tra via Rasella e le Fosse Ardeatine: non solo perché non vi furono né il tempo né la richiesta da parte dei nazisti che i partigiani si consegnassero ma anche perché, come si legge nella sentenza del 1948 emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma, «la ricerca degli attentatori non costituì l’attività prima del comando di polizia tedesca, ma fu effettuata in maniera blanda come azione marginale e successiva alla preparazione degli atti di rappresaglia». C’è la convinzione, spiega lo storico, che via Rasella fosse la prima azione partigiana a Roma, invece non fu né l’unica e nemmeno la prima: ce ne furono molte altre e nessuna fu seguita da un’analoga rappresaglia.
Una relazione esiste nel senso che la strage fu una decisione politica presa dopo via Rasella, ma per un motivo ben preciso: via Rasella fu la più clamorosa e la prima azione partigiana che i nazifascisti non poterono pubblicamente fingere di ignorare. «In questa combinazione di gravità e visibilità sta l’insopportabilità di via Rasella. Trentatré morti […] sotto gli occhi di tutti, un reparto armato in formazione attaccato in scontro aperto e prolungato da un nemico di cui si vuol tacere persino l’esistenza, sono intollerabili». Tanto più, conclude lo storico, in una città che non collaborava, che non rispondeva ai bandi di reclutamento, che non denunciava gli antifascisti, che non aderiva alla “repubblica”. «Perciò prendere i “colpevoli” era irrilevante: la rappresaglia non voleva punire loro o vendicare gli uccisi, ma restaurare pubblicamente il potere ferito».

Le foto delle persone morte alle Fosse Ardeatine sulle pareti della cava sistemate dai parenti subito dopo la Liberazione da parte degli Alleati (ANSA)
La storia processuale della strage delle Fosse Ardeatine è lunga e complessa, Kappler venne arrestato alla fine della guerra e condannato per l’eccidio del 24 marzo, per la deportazione degli ebrei di Roma e per altri crimini di guerra (riuscì a fuggire dal carcere nel 1977 e morì in Germania due anni più tardi). Anche Priebke riuscì a fuggire: si scoprì che era in Argentina soltanto nel 1994. Nel 1995 venne estradato in Italia. Nel processo del 1996 venne dichiarato colpevole, ma non punibile per prescrizione del reato. Una forte reazione dell’opinione pubblica portò a un nuovo processo che stabilì l’imprescrittibilità del reato e respinse la linea della difesa dell’obbedienza a ordini superiori. Priebke fu dichiarato colpevole di “omicidio plurimo con premeditazione” e condannato all’ergastolo. È morto a 100 anni nel 2013, dopo che per motivi di età gli erano stati concessi i domiciliari.