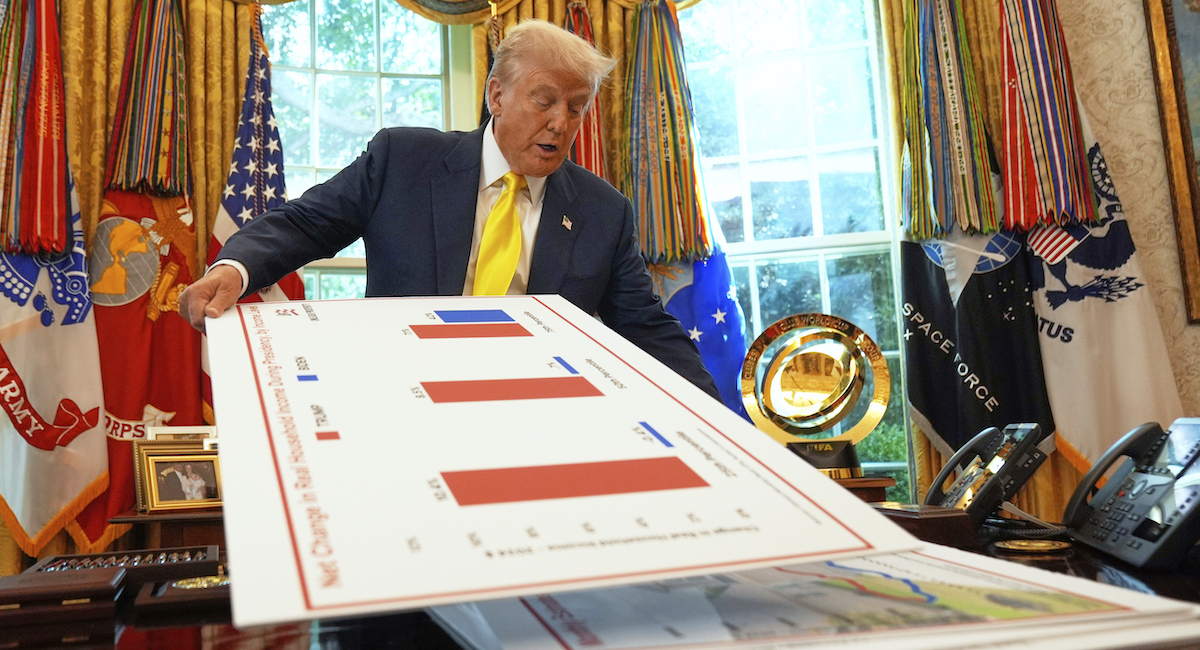Molte maestre, poche manager
Si potrebbe riassumere così una delle ragioni del cosiddetto “gender pay gap”, il fatto che le donne vengano pagate meno degli uomini: c'entrano soprattutto gli stereotipi e la discriminazione
di Mariasole Lisciandro

I differenziali salariali di genere – cioè la differenza tra la retribuzione media delle donne e quella degli uomini, da sempre a favore dei secondi – sono il risultato di un fenomeno complesso, che si è recentemente cominciato a studiare per tentare non solo di capire perché esistono e da cosa dipendono, ma anche dove si dovrebbe agire per correggerli. È un problema che riguarda la politica ma che ha profonde radici culturali, visto che è in gran parte causato da secoli di discriminazione nei confronti delle donne, che fino a pochi decenni fa avevano un accesso alle occupazioni più remunerate quasi nullo, e che nella gran parte delle famiglie delle società occidentali avevano (e hanno ancora, anche se meno) le maggiori responsabilità di cura della casa e dei figli, con un grosso impatto sullo sviluppo di una carriera e quindi sulla possibilità di accedere a uno stipendio alto.
Quando si parla di differenziali salariali di genere si usa spesso anche un altro termine, gender pay gap, che tiene al suo interno sia le differenze tra i salari medi maschili e femminili, sia la più specifica differenza tra quanto guadagnano uomini e donne con le stesse professioni e nello stesso ruolo. Per spiegare il gender pay gap bisogna tenere conto dei pregiudizi culturali diffusi, ma anche di alcune cause secondarie, per così dire: prima di arrivarci però serve guardare quanto valgono, questi differenziali, che riguardano sia la paga oraria che il reddito da lavoro annuale.
Secondo i dati Eurostat sui lavoratori delle aziende sopra i 10 dipendenti, in Unione Europea le donne guadagnano in media il 12,7 per cento in meno degli uomini. In Italia solo il 5 per cento ed è uno tra i paesi europei in cui questo divario è più stretto. In realtà il tessuto imprenditoriale italiano è fatto soprattutto da piccole e piccolissime imprese, che sfuggono a questa classifica e che rendono quindi questo dato poco rappresentativo. Anche i dati OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) restituiscono un numero simile, che sale però al 33 per cento se si considerano i soli lavoratori autonomi e i professionisti.
Guardando ai redditi annuali, i dati INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato (escludendo quello agricolo) mostrano che in Italia il reddito medio annuale lordo delle donne è di 18.305 euro, contro i 26.227 degli uomini: sono quasi 8 mila euro in meno, il 30 per cento. È un differenziale che aumenta con l’età delle lavoratrici e dei lavoratori, che tocca il suo massimo in corrispondenza della fascia tra i 55 e i 59 anni, dove è di 11.282 euro, il 33 per cento. Nel settore privato su 17 milioni di lavoratori 9,7 sono uomini e 7,3 donne.
Lo stesso avviene nel settore pubblico: in media le donne guadagnano 30.262 euro lordi all’anno, il 25 per cento in meno dei colleghi uomini, che ne guadagnano 40.157. E in questo caso le lavoratrici sono più dei lavoratori: su 3,7 milioni di dipendenti pubblici 2,2 sono femmine e 1,5 sono maschi.
Il fatto che le donne guadagnino meno degli uomini sia all’ora che all’anno, e che la differenza sia più alta nelle retribuzioni annuali che in quelle orarie, mostra già una parte del problema. Alessandra Casarico, professoressa di economia all’Università Bocconi ed esperta di studi sui differenziali di genere, dice che «le differenze che si vedono nel salario orario sono più piccole rispetto a quelle sui redditi complessivi da lavoro perché in quest’ultime entra in maniera più decisiva la componente di quanto si lavora: sul salario orario incide meno il fatto che abbiano, per esempio, contratti a tempo determinato o contratti part-time. Mentre si vede il fatto che spesso le donne hanno lavori meno prestigiosi e pagati meno», dice Casarico.
Le ragioni di questo divario sono molteplici e connesse tra loro, ma semplificando molto si possono ricondurre a quattro categorie: la prima riguarda la cosiddetta “segregazione orizzontale”, per cui le donne scelgono soprattutto settori lavorativi in cui gli stipendi sono di per sé più bassi, a prescindere dal genere; la seconda è la “segregazione verticale”, che definisce le minori opportunità di carriera per le donne rispetto agli uomini e la difficoltà per loro di ottenere promozioni e posizioni più alte; la terza riguarda il fatto che tra congedi parentali, maternità, aspettative, part-time e contratti a tempo determinato le donne lavorano ogni anno meno ore dei colleghi maschi, dunque vengono pagate di meno in assoluto; una quarta consiste nella quota residuale che i ricercatori non si riescono a spiegare, probabilmente costituita anche dalla scelta arbitraria dei datori di lavoro di pagare meno le donne degli uomini.
La prima categoria, la “segregazione settoriale”, è confermata da diversi dati. Secondo l’Eurostat, in Unione Europea il 92 per cento dei lavori di assistenza all’infanzia è svolto da donne, così come l’89 per cento dei lavori di segreteria e di insegnamento nella scuola primaria e nei nidi. L’87 per cento delle infermiere e delle ostetriche sono donne, e l’86 delle addette alle pulizie e delle collaboratrici domestiche.
Anche in Italia le donne sono nettamente prevalenti in settori come la sanità e l’istruzione, in cui le retribuzioni sono più basse.
Il fatto che le donne facciano questi mestieri non dipende solo dalle preferenze dei singoli individui, ma dal fatto che le donne come genere e gruppo siano più portate a sceglierle per fattori culturali e sociali. Sono gli stessi fattori che nella scelta del percorso di studi le tengono lontane dalle cosiddette lauree STEM, ossia quelle scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, che dopo gli studi peraltro offrono prospettive migliori di carriera e guadagno.
Secondo un’analisi del sito lavoce.info le donne tendono a evitare i percorsi STEM, e a scegliere percorsi umanistici e di studi sociali, principalmente perché dopo temono di imbattersi in ambienti ancora maschili, perpetuando così lo squilibrio. Alcune ricerche mostrano che, per esempio, «negli ambienti professionali gli stereotipi riguardanti le abilità, gli interessi e i ruoli sociali di uomini e donne possono manifestarsi come pregiudizi nelle decisioni di assunzione e promozione, ostacolando l’avanzamento di carriera e le opportunità»: in questi settori si assumono e si promuovono meno le donne perché si crede che possano rendere meno. Alcuni studi citati mostrano che questi stereotipi non solo portano alla scelta più frequente di uomini per attività che hanno a che fare con la matematica, ma anche che tengono le donne lontane da queste discipline perché loro stesse sono portate a pensare che non avranno mai lo stesso successo degli uomini se intraprendono percorsi di studio STEM.
Secondo Casarico c’è un ulteriore aspetto della segregazione settoriale, ossia quella nelle imprese: le donne si ritrovano più spesso in aziende meno competitive, che pagano meno tutti i lavoratori. Questo dipende anche dal fatto che spesso le donne, dovendo prendersi cura della famiglia, sono costrette a scegliere lavori che possono fare senza allontanarsi troppo da casa, limitando notevolmente le proprie opportunità e portandole con più frequenza a doversi accontentare.
Per quanto riguarda la segregazione verticale, invece, in Italia nel totale dei lavoratori dipendenti le donne compongono il 58,4 per cento delle posizioni impiegatizie e solo il 21 di quelle da dirigenti. Carriere che le limitano in posizioni più in basso nelle gerarchie limitano anche i loro guadagni, che sono dunque in media sistematicamente più bassi di quelli degli uomini.
La terza categoria citata, il fattore tempo, si deve al fatto che alle donne è ancora demandata la gran parte delle attività di cura della famiglia. Lo stesso congedo di maternità, per cui l’INPS garantisce il pagamento dell’80% dello stipendio, abbassa le retribuzioni annue delle donne con figli.
Il loro “svantaggio” sul lavoro non è solo associato al periodo della maternità e soprattutto non è solo rispetto ai colleghi maschi, ma anche alle colleghe senza figli. Casarico è autrice di uno studio secondo cui a parità di età, competenze e reddito da lavoro iniziale, la retribuzione annua delle donne con figli a quindici anni dalla nascita del primogenito è in media circa la metà di quella delle donne senza figli.
Questo divario è dovuto soprattutto al fatto che le donne con figli finiscono per lavorare meno ore, per esempio perché passano a contratti part-time. Nel 2022 secondo dati INPS in Italia il 47,7 per cento delle donne ha contratti part-time, a fronte del solo 17,4 per cento degli uomini: la percentuale tende a salire nettamente nelle regioni del Sud (in Calabria due terzi delle lavoratrici hanno contratti part-time). Ma anche quando lavorano a tempo pieno le donne sfruttano di più strumenti legati all’accudimento dei figli come i congedi e le aspettative, che riducono il numero di settimane retribuite ogni anno.
Carriere così discontinue sono anche tra le cause per cui per le donne è così difficile raggiungere ruoli alti nelle aziende: una componente residuale del divario è legata alla minore crescita delle retribuzioni delle donne con figli, determinata da progressi di carriera più lenti rispetto alle donne senza figli.
Queste tre categorie di ragioni – segregazione verticale, orizzontale e tempo – per cui le donne vengono pagate meno degli uomini naturalmente non esauriscono la spiegazione del gender pay gap, dato che tutte e tre hanno origine a loro volta da stereotipi culturali e sociali. «Se si tiene conto che le donne studiano meno ingegneria, se si tiene conto che vanno in settori diversi, se si tiene conto che hanno ruoli diversi, e via così, allora siamo portati a credere che le differenze che ci sono nei salari tra uomini e donne non siano poi così grandi. Ma il punto non è tanto spiegare che ci sono, queste differenze, quanto poi domandarsi perché esistono» dice Casarico. «Il fatto di essere in grado di spiegare alcuni fattori che giustificano le differenze non ci esime dal chiederci come e se negli stadi precedenti ci siano stati stereotipi della cultura o discriminazioni che poi abbiano portato le donne a compiere determinate scelte».
Infine la quarta ragione per cui le donne guadagnano meno degli uomini, quella “residuale” e inspiegabile con i soli dati e studi scientifici, viene rimandata a discriminazioni e pregiudizi ancora più netti: i datori di lavoro scelgono di pagare meno le donne per i motivi più svariati, per esempio perché pensano che avranno un rendimento inferiore, perché pensano che saranno più distratte dal lavoro per non tralasciare la cura della famiglia, o più emotive, o ancora perché temono che a un certo punto smettano di dedicarsi interamente al lavoro per via dei figli, appunto.
– Leggi anche: Quanto costa fare un figlio