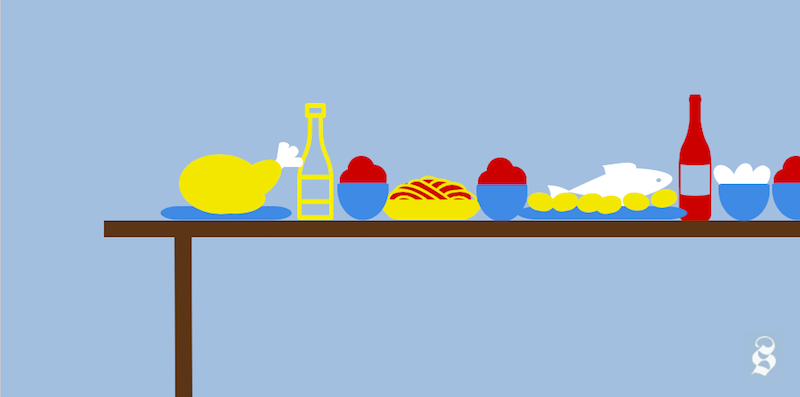Nella gestione delle proteste conta molto la “cultura della polizia”
Cioè il modo in cui gli agenti percepiscono sé stessi e chi manifesta, che a sua volta dipende da fattori storici, dalla capacità di prevenire la violenza e anche dai governi
di Alessandra Pellegrini De Luca

Le violente cariche della polizia a Pisa e a Firenze contro gli studenti minorenni e disarmati che manifestavano a favore della Palestina hanno generato estese indignazioni e attirato molte critiche agli agenti e al ministero dell’Interno. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di «clima di repressione» e sul caso è intervenuto pubblicamente persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un richiamo al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un po’ inusuale rispetto ai suoi modi abitualmente felpati.
La polizia è stata accusata di non aver fatto niente per prevenire le violenze (18 persone sono state ferite), di aver reagito in modo sproporzionato rispetto alla manifestazione, che era pacifica, e di aver poi usato giustificazioni deboli e in contrasto col diritto costituzionale a manifestare: il dipartimento di Pubblica sicurezza, cioè la sezione del ministero dell’Interno che si occupa della polizia, ha difeso l’operato degli agenti in un comunicato sottolineando che la manifestazione non era autorizzata (in realtà per organizzare una manifestazione non servono autorizzazioni: ci torniamo).
Come in altre occasioni, più in generale la polizia italiana è stata accusata di aver agito in questo modo per via di una cultura diffusa dell’autoritarismo e della repressione, che in questa come in altre occasioni l’ha portata a gestire il dissenso e le proteste con quelle che sono state definite «pratiche fasciste».
Esistono studi e discussioni su quella che viene definita police culture, cultura della polizia: è un ambito poco conosciuto e riguarda il modo in cui gli agenti percepiscono sé stessi e il proprio ruolo, l’immagine che hanno di chi manifesta e il modo in cui l’interazione tra queste due cose influenza le loro scelte operative. Chi si occupa di cultura della polizia ritiene che sia particolarmente determinante nella gestione delle proteste e delle manifestazioni, perché sono situazioni in cui gli agenti devono agire con un ampio margine di discrezionalità, e in cui quindi possono entrare in gioco anche fattori diversi dalle semplici indicazioni ricevute.
«A differenza di altre attività, come quella investigativa, il protest policing, cioè il controllo della protesta, prevede un margine di interpretazione più ampio e un modus operandi molto meno strutturato», dice Donatella Della Porta, sociologa della Scuola Normale di Pisa nota per i suoi studi sulla polizia, sui movimenti sociali e sulla violenza politica. Attualmente Della Porta dirige il Centre on Social Movement Studies, ed è autrice insieme ad Herbert Reiter di Polizia e protesta, uno studio sulla gestione dell’ordine pubblico in Italia dal 1945 a oggi, con moltissimi esempi sul tema di come vengono affrontate le manifestazioni.
A Pisa, a Firenze e in molte altre occasioni la polizia ha motivato il proprio utilizzo della violenza come necessario e previsto dalle regole. Secondo Della Porta non è quasi mai così perché il controllo dell’ordine pubblico e il modo in cui viene attuato dipende moltissimo da quello che si può definire un “sapere di polizia”. Cioè dal modo in cui la polizia decide volta per volta di considerare qualcosa «un rischio» e di agire di conseguenza, «comportandosi di fatto da policy maker [cioè chi prende attivamente decisioni] più che da semplice esecutore di regole impartite dall’alto».
Sulla gestione delle proteste la polizia ha ovviamente alcune norme di riferimento. C’è il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS): una norma approvata nel 1931, durante il fascismo, e riformata in modo sostanziale solo nel 1981, con un ritardo che secondo alcuni studiosi ha contribuito a radicare nella polizia una cultura dell’autoritarismo nella gestione dell’ordine pubblico. Ci sono linee guida ministeriali su come garantire la sicurezza all’interno degli spazi in cui si svolge la manifestazione.
C’è l’articolo 17 della Costituzione, quello sul diritto a riunirsi pacificamente: l’articolo dice che per manifestare non bisogna chiedere un’autorizzazione, ma semplicemente dare un preavviso alle autorità, che possono decidere di vietarla soltanto «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». L’articolo smentisce quindi la giustificazione del dipartimento della Pubblica sicurezza che si basava sul fatto che la manifestazione non fosse stata autorizzata, e che per questo creasse «difficoltà operative di gestione».
In anni recenti ci sono stati vari casi in cui la polizia non solo non ha vietato, ma ha gestito in modo molto blando e pacifico altre manifestazioni per cui non era stata chiesta alcuna autorizzazione, per esempio nel caso delle manifestazioni “No Vax” o contro il Green Pass. A Pisa e a Firenze le cose sono andate diversamente, secondo Della Porta per ragioni che hanno a che fare anche con la cultura della polizia.
C’entra il fatto che le proteste o le manifestazioni come quelle a favore della Palestina sono percepite in modo diverso rispetto ad altre: «Gli agenti rispondono in modo più o meno violento a una manifestazione anche sulla base di come una certa causa è accettata dalla politica e dall’opinione pubblica, da quanto i manifestanti godono o meno di simpatie diffuse, e quindi da quanto la polizia si aspetta di essere contestata o lodata per il proprio operato».
Sul modo in cui gli agenti gestiscono le manifestazioni influisce anche il rapporto col potere politico di turno, in questo caso con un governo che ha dimostrato di sostenere approcci rigidi e securitari a tantissimi problemi, e che tende a difendere le forze dell’ordine nei casi in cui vengono contestate per l’uso sproporzionato della forza. «Non parlerei di una dipendenza diretta», dice Della Porta. «Ma ci sono casi in cui al di là delle indicazioni ricevute dalla propria dirigenza ci si può aspettare di essere più o meno lodati dal potere politico, se si interviene con più durezza.
Conta anche quanto gli agenti conoscono gli ambienti di chi manifesta: un caso esemplare riguarda il Social Forum di Firenze, nel 2002, quando la gestione della protesta fu meno conflittuale anche perché la polizia conosceva gli organizzatori e c’era una sorta di rapporto di fiducia tra le due parti, anche se con rispettive posizioni molto diverse. È un caso molto diverso dalla manifestazione di Pisa, dove a manifestare non era tanto un movimento organizzato quanto un gruppo di studenti.
Dal punto di vista operativo la differenza tra la violenza con cui la polizia ha gestito la manifestazione di Pisa e altre manifestazioni, per esempio quelle contro il Green Pass, si è vista nella mancata attuazione di una serie di accorgimenti.
Tra le cose che si potevano fare per evitare l’utilizzo della forza c’erano alcune azioni di prevenzione. Gli studi sulla cultura della polizia dicono che in qualsiasi controllo della protesta che non abbia finalità punitive, ma di tutela della sicurezza, prima di caricare i manifestanti vanno seguiti passaggi ben precisi e graduali. Bisogna prima dialogare con chi protesta, magari anche minacciando interventi più duri, e usare dei gesti chiari per comunicare: per esempio togliersi il casco per segnalare la volontà di parlare, o rimetterselo per far capire che si è intenzionati a intervenire.
Anche una volta intervenuti, nel caso di insuccesso della negoziazione i poliziotti possono usare diversi metodi, senza utilizzare i manganelli: per esempio bloccare i manifestanti, circondarli, e farli uscire uno a uno dopo aver controllato i documenti. A Pisa questi metodi non sono stati usati.
Sui fatti sono in corso due indagini, ma i video disponibili hanno mostrato come gli studenti abbiano a un certo punto imboccato via San Frediano, una strada molto stretta che sbuca su piazza dei Cavalieri, dove ha sede la Scuola Normale. Lì i manifestanti hanno trovato la strada sbarrata da un veicolo della polizia e da agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno provato ad avanzare, pacificamente e con le mani alzate, e a quel punto i poliziotti hanno iniziato a manganellare con violenza gli studenti, inseguendoli anche quando fuggivano.
In teoria la polizia ha detto di aver ordinato una “carica di alleggerimento” in via San Frediano, cioè un’azione fisica che serve a ridurre la pressione del corteo e a sgomberare un po’ la folla. Dovrebbe essere un’azione graduale, dettata da princìpi di proporzionalità tra l’azione della polizia e la reazione dei manifestanti, e soprattutto orientata al calo della tensione: «Quanto successo a Pisa non rispettava nessun principio di proporzionalità», dice Della Porta.
Le violente cariche di Pisa e Firenze sono state paragonate da alcuni a quanto avvenuto a Genova nel 2001, quando durante le manifestazioni contro il G8 (l’incontro tra i governi delle principali potenze economiche mondiali) le forze dell’ordine italiane si resero responsabili di alcuni degli episodi più violenti della storia italiana recente. Molto di quello che è successo a Pisa e a Firenze andrà chiarito dalle indagini in corso, che tra le altre cose cercheranno di capire come ha funzionato la catena di comando della polizia durante le manifestazioni e come hanno agito gli agenti. Nel frattempo, comunque, sta circolando una petizione per chiedere le dimissioni del questore di Pisa, Sebastiano Salvo, che a fronte delle dure critiche per l’operato della polizia a Pisa e Firenze ha ammesso che «è mancata l’interlocuzione» tra polizia e manifestanti.
Secondo Della Porta parlare di «cultura fascista» nella polizia italiana è una generalizzazione, perché soprattutto tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta ci sono stati profondi cambiamenti che l’hanno resa quello che è oggi: un corpo complesso, con posizioni molto diverse al suo interno, reparti molto variegati per cultura, sindacati che vanno da «unità molto corporative, chiuse e di destra» a frange più progressiste.
Limitatamente alla gestione delle proteste, però, ci sono diverse ragioni per ritenere che la cultura sia ancora profondamente caratterizzata da un atteggiamento repressivo: «Parliamo di un ambito che incoraggia naturalmente divisioni molto nette tra “noi e loro” e tra “amici e nemici”» e in cui, come Della Porta stessa ha documentato nel suo libro, ha avuto un peso enorme il ventennio fascista e il modo in cui ha immaginato, concettualizzato e successivamente regolamentato il concetto di ordine pubblico, successivamente rimasto invariato per decenni e ben oltre la caduta del regime fascista.
– Leggi anche: Come polizia e carabinieri gestiscono i casi di violenza contro le donne