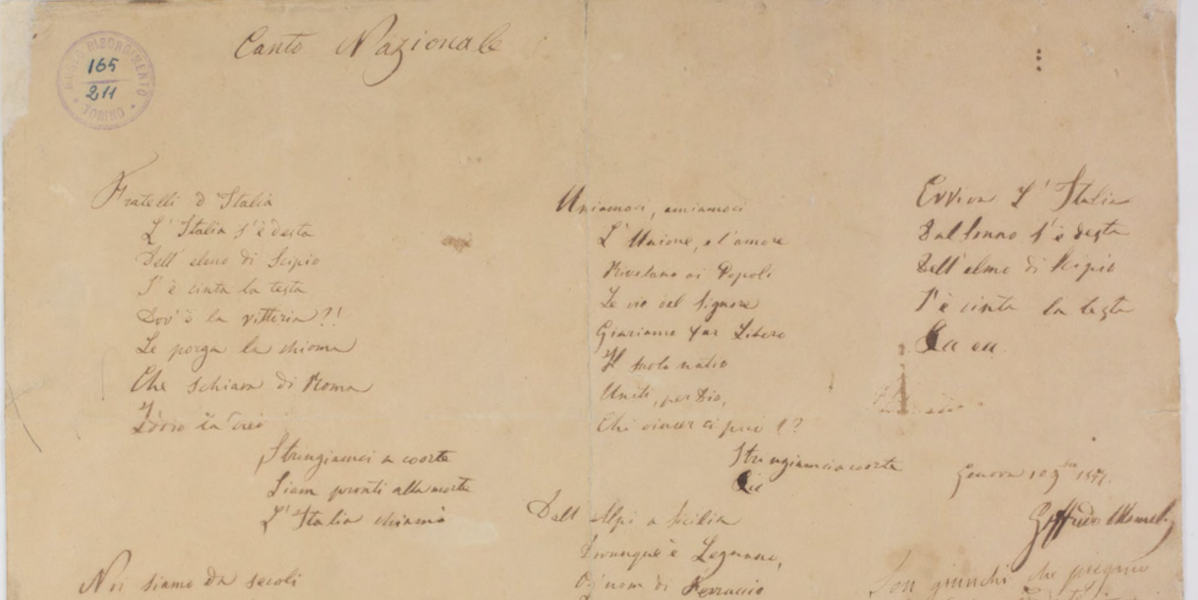La crisi del commercio equo e solidale
I costi sono aumentati e le vendite dei prodotti sono diminuite, mentre il movimento non riesce a rinnovarsi

A fine novembre ad Abano Terme, in provincia di Padova, si è svolta l’annuale assemblea dei soci di Altromercato, un consorzio composto da 80 cooperative che aderiscono al commercio equo e solidale: è un modello di mercato che promuove le aziende che si pongono l’obiettivo di controllare in maniera diretta la filiera, stabilendo un prezzo più giusto per i prodotti e un salario più alto ai lavoratori. Altromercato è il principale importatore in Italia di questo tipo di prodotti. Inoltre gestisce circa 200 punti vendita, la gran parte dei quali si trova nel Nord Italia.
I negozi, amministrati dalle cooperative socie di Altromercato, sono divisi in quattro categorie. Ci sono innanzitutto gli empori, che sono dei punti vendita di grandi dimensioni, e le botteghe del mondo, di dimensioni più piccole. Poi ci sono i distretti, che sono dei luoghi di incontro in particolare per i cosiddetti gruppi di acquisto solidale, vale a dire per le persone che decidono di acquistare frutta, verdura e altri generi alimentari direttamente dai produttori e poi dividersela. Infine ci sono gli outlet, dove si trovano in vendita prodotti a prezzo ridotto.
I dati del 2023 presentati durante l’assemblea mostrano un calo delle vendite sia in tutti i formati di punti vendita che nelle catene del biologico e nei supermercati. Nel primo semestre di quest’anno le vendite nelle botteghe sono calate del 4,5 per cento e il calo nei negozi biologici e nei supermercati ha superato l’8 per cento. «Abbiamo risentito della forte crescita di prodotti con il cosiddetto primo prezzo, cioè quello più basso, e di quelli con il marchio del negozio, che sono sempre più diffusi», dice il presidente Alessandro Franceschini.
«Il combinato disposto di crisi economica, escalation militare e tensione politica condiziona in modo sostanziale il contesto in cui il commercio equo e solidale opera», si legge nella relazione di bilancio di Altromercato per il primo semestre del 2023. Il documento elenca una serie di «fattori negativi» che hanno messo in difficoltà il commercio equo e solidale in Italia nell’ultimo anno: tra i principali ci sono «i ritardi dei trasporti soprattutto via mare», «l’incremento del costo dell’energia», «la crisi del settore logistico in Italia, che si traduce in un aumento dei costi del trasporto su gomma e in ritardi ed errori nelle consegne», l’inflazione e la «percezione di un minor potere d’acquisto» da parte dei consumatori, che si sono spostati verso i discount o verso i prodotti che costano meno.
Sono stabili invece gli acquisti di prodotti equi e solidali da parte di bar, gelaterie e pasticcerie, che li utilizzano per la preparazione di dolci e gelati. A riequilibrare il bilancio sono i ricavi dalla ristorazione scolastica, aumentati del 10,5 per cento, e la cooperazione con grandi imprese: su 55 milioni di fatturato complessivo, dieci provengono da progetti con aziende come Ferrero, che importa lo zucchero di canna dalle isole Mauritius, e Loacker, che acquista il cacao equo e solidale in Ecuador, mentre i comuni di Milano e Roma hanno introdotto le banane e il cioccolato equi e solidali nei menu delle mense scolastiche. Sono questi ultimi dati che spingono il presidente di Altromercato Alessandro Franceschini a dire che «finalmente, dopo anni di cali, ci sono segnali di tenuta».
Il movimento che nel mondo è noto come del commercio equo e solidale cominciò a formarsi negli anni Sessanta tra Europa e Stati Uniti con piccoli negozi che acquistavano direttamente dai produttori nei paesi in via di sviluppo. Alla fine degli anni Sessanta nei Paesi Bassi fu fondata Sos Wereldhandel, la prima organizzazione per l’importazione di prodotti equi e solidali. Nel 1969 a Breukelen, una cittadina di 15mila abitanti vicino a Utrecht, fu aperta la prima bottega del mondo. Fu solo all’inizio degli anni Ottanta, però, che questo mercato cominciò a consolidarsi.
Il movimento italiano nacque come costola del movimento austriaco e di quello tedesco a Bolzano, e i fondatori da subito decisero di chiamarlo con la formula nota oggi (commercio “equo e solidale”, appunto, leggermente diverso dal nome con cui è noto in tutto il mondo, fair trade). Negli anni Ottanta l’ong Mani Tese cominciò a vendere i prodotti equi e solidali e nel 1981 a Bressanone aprì la prima «bottega del mondo» in Italia, pur con un nome tedesco: Dritte Welt Laden. Nel 1988 a Bolzano fu fondato il consorzio Altromercato, la prima organizzazione per l’importazione di prodotti equi e solidali.
Il commercio equo e solidale ebbe il suo momento di maggiore crescita tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, in coincidenza con la crescita delle proteste in tutto il mondo contro l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), che era accusata di promuovere un modello di mercato che favoriva le multinazionali a discapito dei piccoli coltivatori. Nel 1997 nacque Fairtrade International, un’associazione che creò un sistema di certificazione mondiale delle produzioni etiche e sostenibili. Per avere sui loro prodotti il logo di Fairtrade i produttori dovevano accettare alcune regole, per esempio il divieto di assumere minori o il rispetto di specifiche direttive a salvaguardia dell’ambiente. In cambio ottenevano di vendere i loro prodotti a un prezzo minimo, concordato con Fairtrade e non soggetto a speculazioni finanziarie.
In più, i produttori ricevevano periodicamente un premio che potevano decidere come spendere: per esempio per migliorare le tecniche produttive o le condizioni della loro comunità, costruendo scuole e ospedali. «Era un momento in cui i movimenti che allora si definivano altermondialisti pensavano di creare nuovi mercati più giusti e sostenibili e c’era una grande attenzione a tutto ciò che proveniva dal Sud del mondo», dice Tonino Perna, professore di Sociologia economica all’università di Messina e autore di un libro del 1998 intitolato Fair Trade, la sfida etica al mercato.
In quel periodo la diffusione dei prodotti equi e solidali, in particolare di caffè, cioccolato, zucchero e banane, fu tale che in tutta Europa le grandi catene di supermercati fecero accordi per vendere i prodotti sui loro scaffali. In Italia nel 2002 Altromercato fece un accordo con Esselunga che generò divisioni tra i sostenitori del commercio equo e solidale ma fece anche aumentare molto le vendite. «Con quella scelta che fu molto contestata abbiamo cambiato la vita di centinaia di coltivatori in Ecuador, se non l’avessimo fatto avremmo dovuto sospendere l’importazione di banane perché non saremmo stati in grado di garantire una diffusione sufficiente», dice Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato. Portandole nei supermercati ora se ne vendono 9mila tonnellate all’anno.
Oggi i prodotti con il marchio Fairtrade si trovano in 2.400 punti vendita, tra supermercati, discount, negozi di vicinato, bar e pasticcerie in Italia. L’ufficio stampa di Faitrade fa sapere che «negli ultimi anni i consumi dei prodotti hanno sempre tenuto nonostante l’inflazione». In Italia nel 2022 sono stati spesi 580 milioni di euro in prodotti equi e solidali, contribuendo a generare 3,8 milioni di euro di premio, vale a dire una cifra extra per assicurare l’avvio di progetti a sostegno dello sviluppo produttivo, economico e sociale delle comunità, ai produttori in Asia, Africa e America Latina.
Il sistema di certificazione Fairtrade è stato contestato da molte aziende che hanno lamentato la mancata efficacia dei controlli, in particolare su come vengono spesi i soldi del premio, come ha raccontato nel 2019 un lungo articolo del Guardian, tradotto e pubblicato in Italia da Internazionale. Nel frattempo, sono nati altri marchi, come quello di Equo Garantito, un’associazione che rappresenta 82 organizzazioni eque e solidali in Italia. Il marchio Equo Garantito certificherebbe il rispetto di alcuni princìpi da parte delle organizzazioni che lo richiedono, come il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori e l’uso sostenibile delle risorse ambientali.
Negli ultimi dieci anni però il commercio equo e solidale ha dovuto far fronte a un lento ma costante ridimensionamento. Secondo i dati di Equo Garantito, dal 2011 le persone impiegate si sono più che dimezzate, da 1.202 a 491, i volontari sono calati da 5mila a 3.960, i soci sono passati da oltre 30mila a 29mila e le botteghe sono scese da 257 a 170. Il fatturato complessivo annuale è diminuito di undici milioni di euro: dai 78 milioni del 2011 ai 67 milioni del 2021.
«A Roma avevamo otto negozi, dopo la crisi economica del 2008 è cominciata una lenta involuzione e ora ne abbiamo tre» dice Gabriella Costantini, amministratrice di Pangea, una cooperativa che ha 800 soci e gestisce i tre punti vendita nella capitale. «Nel 2022 abbiamo chiuso una bottega storica nel quartiere di San Lorenzo, vicino all’università La Sapienza, e se non avremo rassicurazioni sugli affitti da pagare e sulle bollette rischiamo di doverne chiudere anche un’altra». Tra questi c’è l’emporio di via di Ripetta, a poche decine di metri da piazza del Popolo, che è uno dei più noti e frequentati negozi del commercio equo e solidale in Italia. Costantini spiega che sulla riduzione degli incassi hanno pesato diversi fattori, dal taglio dei progetti sul «commercio etico» nelle scuole «con le quali collaboravamo» alle «difficoltà economiche delle parrocchie che compravano i nostri prodotti». Inoltre, «molti dei nostri 800 soci non frequentano più i nostri negozi, se ognuno di loro comprasse 50 euro di prodotti equi e solidali al mese non avremmo alcun problema economico». Invece ogni anno fanno «fatica a chiudere il bilancio in pareggio».
La pandemia da coronavirus ha peggiorato la situazione: secondo un questionario inviato da Altromercato ai suoi fornitori, tra il 2020 e il 2021 i produttori di generi alimentari hanno perso in media il 22 per cento del fatturato, mentre gli artigiani hanno visto ridursi gli acquisti del 61 per cento. Il calo, secondo Altromercato, è stato causato dai lockdown, dalla carenza di materie prime per produrre, dal rallentamento dei trasporti locali e internazionali e dalla riduzione delle vendite nelle botteghe e nei supermercati.
«Bisogna essere onesti nel dirlo: il commercio equo e solidale non è messo bene», dice Stefano Magnoni, presidente della cooperativa Chico Mendes, che a Milano gestisce dieci punti vendita. «Il problema è che le botteghe del mondo non sono riuscite a trasformarsi, tra i soci non c’è stato un ricambio generazionale, sono cambiate le abitudini di consumo e i prodotti equi e solidali non si trovano in tutti i supermercati, come accade in Germania o nei Paesi Bassi». A suo parere, «la solidarietà con i paesi del Sud del mondo ha perso lo slancio che aveva fino a quindici anni fa e la distribuzione basata su una rete capillare di piccoli negozi non sta più in piedi».
Un terzo degli introiti annuali della cooperativa Chico Mendes arriva dagli acquisti al Banco di Garabombo, il mercato natalizio che si svolge per due mesi nel piazzale della metropolitana Pagano di Milano. Quest’anno ha rischiato di saltare per l’aumento del canone unico per l’occupazione di suolo (CUP) da pagare al Comune di Milano, e a causa dell’inflazione che ha fatto lievitare i costi delle bollette e del noleggio e allestimento del tendone. Magnoni pensa che in futuro «dovremmo puntare su negozi più grandi e su un’offerta più ampia rispetto ai soli prodotti equi e solidali», ma al momento la cooperativa Chico Mendes non riuscirebbe a sostenere le spese per affittare un locale di grandi dimensioni nel centro di Milano. Per ora, dice, «ci siamo salvati dalla crisi perché abbiamo diversificato la nostra attività, ad esempio partecipando ad alcuni progetti di inserimento degli immigrati e ad altri con i detenuti nelle carceri».