Il romanzo che fece conoscere Michela Murgia a tantissime persone
"Accabadora", che uscì nel 2009 e vinse il premio Campiello, aveva già dentro tante cose di cui la scrittrice avrebbe parlato negli anni

Michela Murgia, morta il 10 agosto a 51 anni, è stata un’influente intellettuale e attivista femminista, capace di coinvolgere un gran numero di persone nelle sue riflessioni sulle cosiddette questioni di genere e non solo. Molte di queste persone però l’hanno conosciuta prima di tutto in quanto scrittrice, e in particolare come l’autrice di Accabadora, il suo romanzo di maggiore successo. Accabadora fu pubblicato da Einaudi nel 2009, vinse il premio Campiello, uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani, e nel tempo ha venduto centinaia di migliaia di copie.
Ambientato negli anni Cinquanta in un paese della Sardegna, il romanzo parla di una donna che fa l’accabadora nella piccola comunità, cioè uccide le persone agonizzanti come chiesto da loro stesse o dai parenti, di fatto una forma di eutanasia: l’espressione è una parola sarda, che descrive appunto questa pratica, forse solo leggendaria. Al centro della storia c’è però il rapporto tra Bonaria Urrai, l’accabadora, e la protagonista Maria Listru, la sua “fill’e anima”, cioè una sorta di figlia adottiva della donna che all’inizio del libro le viene ceduta dalla madre biologica, una vedova troppo povera per mantenerla. La tradizione dei “fillus de anima” ha avuto una grande importanza per Murgia, che negli anni ha definito molte persone come propri figli d’elezione, e ha anche influenzato il suo concetto di “famiglia queer”, di cui la scrittrice ha molto parlato negli ultimi mesi. Pubblichiamo un estratto dalle prime pagine del romanzo.
***
Quanti anni avesse Tzia Bonaria allora non era facile da capire, ma erano anni fermi da anni, come fosse invecchiata d’un balzo per sua decisione e ora aspettasse paziente di esser raggiunta dal tempo in ritardo. Maria invece era arrivata troppo tardi anche al ventre di sua madre, e sin da subito aveva fatto l’abitudine a essere l’ultimo pensiero di una famiglia che ne aveva già troppi. Invece in casa di quella donna sperimentava l’insolita sensazione di essere diventata importante. Quando la mattina si lasciava alle spalle la porta e stringeva il sussidiario verso la scuola, aveva la certezza che se si fosse voltata l’avrebbe trovata lí a guardarla, appoggiata allo stipite come a reggerne i cardini.
Maria non lo sapeva, ma era soprattutto di notte che la vecchia c’era, in quelle notti comuni senza nessun peccato a cui dare la colpa di essere svegli. Entrava nella camera silenziosamente, si sedeva davanti al letto dove lei dormiva e la fissava nel buio. In quelle notti la ragazzina, che tra i pensieri di Bonaria Urrai credeva di essere il primo, dormiva senza ancora conoscere il peso di essere l’unico.
Perché Anna Teresa Listru avesse dato la figlia minore alla vecchia, a Soreni lo si capiva anche troppo bene. Ignorando i consigli della gente di casa aveva sbagliato matrimonio, passando i successivi quindici anni a lamentarsi di quell’uomo che si era dimostrato capace di far bene una sola cosa. Con le vicine, Anna Teresa Listru amava lagnarsi di come il marito non fosse riuscito a esserle utile nemmeno in morte, avendo magari la buona grazia di crepare in guerra per lasciarle una pensione. Riformato per sua pochezza, Sisinnio Listru era finito stupidamente come era vissuto, schiacciato come un acino nel torchio sotto il trattore di Boreddu Arresi, per cui faceva ogni tanto il mezzadro. Rimasta vedova con quattro figlie femmine, Anna Teresa Listru da povera si era fatta misera, imparando a fare il bollito – diceva — anche con l’ombra del campanile. Adesso che Tzia Bonaria aveva chiesto Maria in figlia, non le sembrava vero di poter infilare tutti i giorni nella minestra anche due patate dei terreni degli Urrai. Se il prezzo era la creatura, poco male: lei di creature ne aveva ancora altre tre.
Perché invece Tzia Bonaria Urrai si fosse presa in casa la figlia di un’altra a quell’età, davvero non lo capiva nessuno. I silenzi si allungavano come ombre quando la vecchia e la bambina passavano per le vie insieme, suscitando code di discorsi a mezza voce sugli scanni del vicinato. Bainzu il tabaccaio si beava di scoprire come anche un ricco, invecchiando, avesse bisogno di due mani per farsi pulire il culo. Ma Luciana Lodine, la figlia grande dell’idraulico, non vedeva necessità di procurarsi un’erede per sopperire a quello che poteva fare qualunque serva pagata bene. Ausonia Frau, che di culi ne sapeva piú di un’infermiera, amava chiudere il discorso sentenziando che neanche la volpe vuole morire sola, e a quel punto nessuno diceva piú nulla.
Certo, se non fosse nata ricca, Bonaria Urrai avrebbe fatto la fine di tutte quelle rimaste senza uomo, altro che prendersi una fill’e anima. Vedova di un marito che non l’aveva mai sposata, in altre condizioni sarebbe forse stata bagassa, oppure suora di casa o di convento, con le imposte sempre chiuse e il nero addosso finché avesse avuto respiro. A rubarle l’abito da sposa era stata la guerra, anche se qualcuno in paese diceva che non era vero che Raffaele Zincu sul Piave c’era morto: piú facile che, furbo com’era, avesse trovato femmina lí, e si fosse risparmiato il viaggio per venire a spiegare. Forse era questo il motivo per cui Bonaria Urrai era vecchia da quando era giovane, e nessuna notte a Maria sembrava nera come la sua gonna. Ma di vedove di mariti vivi il paese era pieno, lo sapevano le donne che sparlavano e lo sapeva anche Bonaria Urrai, per questo quando usciva ogni mattina a prendere il pane nuovo al forno, camminava con la testa alta e non si fermava mai a parlare, tornando a casa dritta come la rima di un’ottava cantata.
In quella decisione di prendere una fill’e anima, la cosa piú difficile per Bonaria non era stata certo la curiosità della gente, ma la reazione iniziale della bambina che si era portata in casa. Dopo sei anni di notti passate a condividere l’aria di una sola stanza con le tre sorelle, era evidente che lo spazio che Maria considerava suo non andava oltre la lunghezza del braccio. L’arrivo nella casa di Bonaria Urrai sconvolse questa geografia interiore; tra quelle mura gli spazi solo suoi erano cosí ampi che la bambina ci mise alcune settimane a capire che dalle porte delle molte camere chiuse non sarebbe comparso nessuno a dire «Non toccare, questo è mio». Bonaria Urrai non fece mai l’errore di invitarla a sentirsi a casa propria, né aggiunse altre di quelle banalità che si usano per ricordare agli ospiti che in casa propria non si trovano affatto. Si limitò ad aspettare che gli spazi rimasti vuoti per anni prendessero gradualmente la forma della bambina, e quando in capo a un mese le porte delle stanze erano state tutte aperte per rimanere tali, ebbe la sensazione di non aver sbagliato a lasciar fare alla casa. Una volta che si sentí forte della nuova confidenza acquisita con quelle mura, Maria cominciò a mostrarsi via via piú curiosa della donna che l’aveva condotta a viverci.
– Di chi siete figlia voi, Tzia? – disse un giorno, con la bocca piena di minestra.
– Mio padre si chiamava Taniei Urrai, era quel signore là.
Bonaria indicò la vecchia foto brunita appesa sopra il camino, dove Daniele Urrai impettito nel corpetto di velluto dimostrava forse trent’anni, e tutto poteva sembrare alla bambina fuorché il padre della vecchia che aveva davanti. Bonaria le lesse l’incredulità sul viso roseo.
– Lí era giovane, io non ero ancora nata, – precisò.
– E mamma non ne avevate? – incalzò Maria, che evidentemente con l’idea che si potesse essere figlie di un padre non aveva particolare confidenza.
– Certo che ne avevo, si chiamava Anna. Ma è morta tanti anni fa anche lei.
– Come mio padre, – aggiunse seria Maria. – A volte lo fanno.
Bonaria rimase stupita da quella precisazione.
– Cosa?
– Lo fanno. Muoiono prima che nasciamo –. Maria la guardò paziente. Poi aggiunse malvolentieri: – Me lo ha detto Rita, la figlia di Angela Muntoni. Anche a lei suo babbo era morto prima.
Durante la spiegazione il cucchiaio si agitava nell’aria come l’archetto di un orchestrale.
– Sí, alcuni lo fanno. Ma non tutti, – disse Bonaria, osservandola con un sorriso vago.
– Non tutti, certo, – convenne Maria. – Uno almeno deve rimanere. Per i bambini. Ecco perché i genitori sono sempre due.
Bonaria annuí, infilando a sua volta il cucchiaio nella minestra, convinta di aver chiuso il discorso.
– Voi eravate due?
Bonaria finalmente capí, e senza smettere di mangiare, parlò con il tono quasi casuale che aveva usato fino a quel momento.
– Si, eravamo due. Il mio sposo è morto anche lui.
– Oh. È morto… – fece eco Maria dopo un istante, indecisa tra il sollievo e il dispiacere.
– Sí, – fece Bonaria a sua volta seria. – A volte lo fanno.
Con il conforto di quella personale statistica, la bambina riprese a soffiare piano sulla minestra. Ogni tanto, sollevando gli occhi dai vapori del cucchiaio, incrociava quelli di Tzia Bonaria, e le veniva da sorridere.
© 2009 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
Per gentile concessione dell’editore.
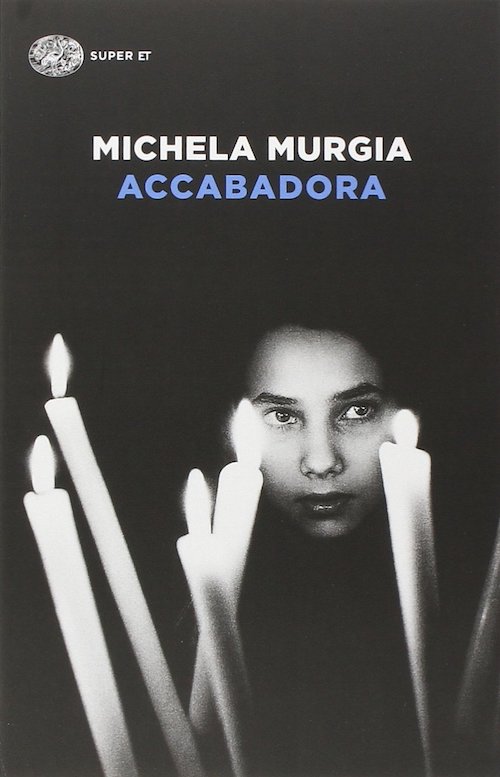
La copertina dell’edizione tascabile di “Accabadora”



