Siamo proprio sicuri?
«Siamo sicuri di aver riflettuto con tranquilla onestà sulla nostra impotenza, invece di ritenere gli intellettuali più influenti di quanto siano, o investiti di qualche altissima missione? Siamo sicuri di prendere sul serio quel che facciamo senza prendere troppo sul serio noi stessi? Che l’autoironia e un po’ di senso dell’umorismo non siano ottimi correttivi alla solennità in cui ogni tanto cadiamo?»
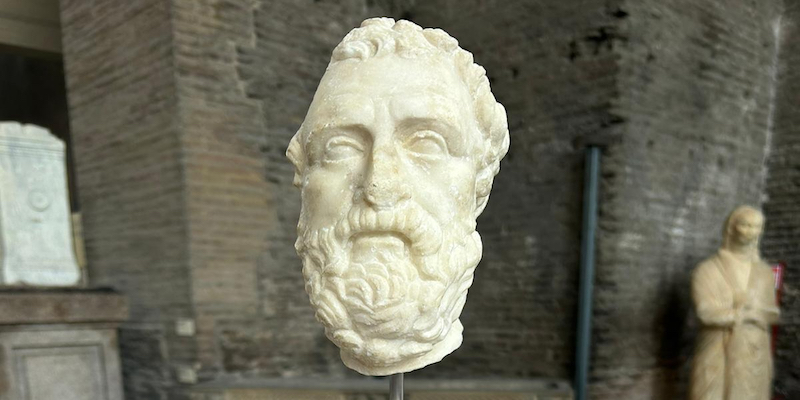
Periodicamente torna il dibattito sul ruolo, i compiti e l’influenza degli intellettuali nella società contemporanea: è un incantesimo cui soggiace ogni membro della sfera intellettuale stessa — giornalisti, docenti, scrittori, critici, registi, fumettisti, attivisti… — in parte perché discutere di sé è sempre piacevole, e in parte perché c’è davvero molto da meditare al riguardo.
Qui vorrei fare un passo di lato: suggerire un laicissimo esame di coscienza relativo non a questo o quel contenuto di attualità bensì a un’impostazione formale; una serie di domande — e la prima plurale vuole includermi nella verifica — che aiuti ad abbozzare un’etica del discorso.
Premetto di avere ben chiaro il mio intellettuale tipo: in parte si evincerà dall’articolo, ma posso subito evocare qualche nume sparso: Dagerman, Berneri, Bachmann, Salvemini, Camus, Arendt, Dolci, Caleffi, Luxemburg, Melazzini, Chiaromonte, Caffi, Silone, Leogrande. Non pretendo sia l’unico modello valido, ovviamente, ma credo offra strumenti per ragionare a mente sgombra su alcuni punti.
Anche perché il problema è assai più vasto di qualsiasi mancanza individuale; lo stesso accanirsi su singoli episodi senza allargare lo sguardo è segno della difficoltà in cui ci dibattiamo, abituati come siamo ad aggredirci perdendo di vista gli interrogativi profondi e le responsabilità collettive. È una questione strutturale: la malattia strisciante di una comunità che — forse sconvolta dalla propria graduale perdita di senso, o forse perché certi atteggiamenti sono premiati — rischia di operare senza bussola. In parte probabilmente è sempre stato così: ma vale la pena rifletterci sopra di nuovo.
E dunque: siamo innanzitutto sicuri di parlare di cose e non di parole, scambiando le seconde per le prime? (Certo è molto importante parlare delle parole: ma l’astrazione irriflessa fa dimenticare la complessità e il dolore di chi vive una situazione su cui pensiamo di opinare; e invece, senza magari accorgercene, stiamo opinando con leggerezza di tutt’altro. Il caso della guerra in Ucraina da questo punto di vista è esemplare). Peggio ancora, siamo sicuri di non dar voce al nostro ego sempre in credito d’attenzione, sotto lo schermo di un altro argomento?
Siamo sicuri di non parlare sull’onda dell’emozione e spinti dall’abitudine a dire subito la nostra? Sicuri che questa reattività non sia deleteria, che ragionare un minuto di più non ci difenda dall’enfasi fuori luogo o dalla cattiva retorica? Sicuri che fra i compiti di un intellettuale non vi sia l’esercitare maggior controllo sulle proprie dita? (Troppe volte in passato ho messo mano alla tastiera accecato dalla rabbia, anche perché c’era e c’è moltissimo per cui essere arrabbiati: ne sono uscite sempre banalità poco utili alla causa).
Ne Il mio debito con la Spagna Albert Camus parla della sua società intellettuale, un mondo «in cui ci si fa un punto d’onore di essere sleali, in cui il riflesso condizionato ha preso il posto della riflessione, in cui si pensa a suon di slogan, come il cane di Pavlov che sbavava al suono del campanello, e in cui troppo spesso la cattiveria vorrebbe farsi passare per intelligenza». Era il 1958: sicuri che queste parole non riguardino anche noi?
Siamo sicuri di essere stati realmente leali agli oppressi come ci piace tanto dire? Non abbiamo invece favorito, magari senza volerlo, una qualche forma di oppressione, benché minore o diversa di quella che andiamo combattendo? Sicuri che la battaglia che conduciamo sia la più urgente solo perché ci riguarda?
Siamo sicuri che le nostre metafore siano trasparenti, e che l’indulgere in metafore non sia segno di doppiezza? Sicuri che l’oscurità linguistica non copra un elitario disprezzo verso le parole comuni e le schiette prese di posizione?
Siamo sicuri di aver riflettuto con tranquilla onestà sulla nostra impotenza, invece di ritenerci più influenti di quanto siamo, o investiti di qualche altissima missione? Siamo sicuri di prendere sul serio quel che facciamo senza prendere troppo sul serio noi stessi? Che l’autoironia e un po’ di senso dell’umorismo non siano ottimi correttivi alla solennità in cui ogni tanto cadiamo?
Siamo sicuri di aver studiato a sufficienza, di aver praticato una dose di scetticismo metodologico? Siamo sicuri che dire «No, grazie» alla richiesta di commento su un tema che conosciamo poco — soprattutto quando ci sono di mezzo reali sofferenze — sia soltanto un’occasione persa e non un dovuto atto di onestà, appunto, intellettuale?
Siamo sicuri di non aver proposto soluzioni vaghe che ci rendono magari affascinanti ma non forniscono alcun contributo praticabile o un incremento di vera comprensione? Michael Walzer ne L’intellettuale militante dice che il critico «arriva ad una posizione assolutista nello stesso modo in cui un bambino si arrampica su un albero, senza pensare a come dovrà mai scenderne; è avventura allo stato puro. Il critico che rifiuta una posizione assoluta rifiuta anche l’ebbrezza della vetta». Siamo sicuri di aver rifiutato — e non è facile — tale ebbrezza?
Siamo sicuri di non aver dimenticato che ogni potere, per quanto piccolo, corrompe sempre? Siamo sicuri che una posizione accademica, una rubrica fissa o il successo professionale mettano al riparo dalla sciatteria o dal torto? Siamo sicuri di non indulgere troppo nelle questioni — e nei pettegolezzi — della nostra “bolla”, dimenticando i bisogni di chi abita fuori da essa e di cui vorremmo però farci interpreti? («La maggior parte degli scrittori d’allora era gente esperta nell’udire con un orecchio solo», scrive Elias Canetti in Karl Kraus, scuola di resistenza. «Erano disposti a frequentare i loro pari, per ascoltarli, più spesso per obiettare. È il vizio ereditario dell’intellettuale, comporre di intellettuali il proprio mondo»).
Siamo sicuri che la postura tranchante e oracolare sia sempre sinonimo di forza interiore e non, anche, levatrice di pensieri sommari in chi legge? Che fra i nostri obblighi ci siano innanzitutto assalto, scandalo, provocazione e soltanto in secondo luogo approfondimento e studio? (Un intellettuale intellige. Invocare Pasolini è rischioso: mimarne il modello senza possederne il genio produce di norma cattivi risultati. Credo che un intellettuale non debba puntare a essere più unico degli altri, bensì suggerire uno stile di pensiero che, parafrasando Kant, possa proporsi come universale — usare parole migliori affinché gli altri trovino le proprie).
D’altro canto, siamo sicuri che un’eccessiva pacatezza e un severo culto del silenzio non nascondano invece qualche viltà o un malcelato snobismo? Siamo sicuri che non intervenire mai sulle storture dell’oggi, scansando astutamente i rischi e magari commentando soddisfatti in privato, basti a ritenerci salvi? Che non valga la pena spendersi con maggiore generosità, soprattutto quando il tema non è “scomodo” solo per etichetta ma può davvero intaccare i nostri privilegi? Sicuri di non aver mai taciuto per paura, per calcolo o per convenienza? È normale, capita a chiunque: ma siamo sicuri che sia degno esibirsi allo stesso tempo come esempi di virtù?
Siamo sicuri di essere fedeli ai nostri eroi? Di non citarli con troppa leggerezza, di non paragonarci impudicamente a essi senza aver pagato un centesimo del prezzo che fu loro imposto? Di combattere davvero battaglie così scomode come ci piace pensarle?
Ne I miei conti con l’idealismo attuale Piero Gobetti spiegò di non aver mai chiesto alle sue idee di servirgli «come pratico ufficio di collocamento», e di non aver domandato «a nessun sistema di salvarmi dal dubbio tragico del pensiero, di offrirmi soluzioni comode anche se fittizie, di darmi le penne del pavone e la pace della pigrizia». Siamo sicuri che frasi del genere, pronunciate da un uomo perseguitato e ucciso dalla violenza, non debbano indurci a maggior discrezione quando pensiamo a noi stessi?
Siamo sicuri di non provare una gioia meschina quando esercitiamo la critica o rileviamo sbagli e fesserie altrui? Sicuri che tutto ciò non sviluppi l’automatismo di vedere stupidità o malafede ovunque, invitando a crederci i depositari del giusto?
E siamo sicuri che esigere segreta vendetta contro chi ci critica a sua volta sia una prassi all’altezza del nostro ruolo? Sicuri che il nostro stesso ruolo, i libri letti, gli incarichi ottenuti, le opere prodotte, ci esimano dall’impegno a essere semplicemente un po’ più buoni — dal praticare nella vita di ogni giorno, con le difficoltà reali del caso, i valori di cui ci ergiamo a baluardo? Che la nostra gratificante idea di “impegno” non renda miopi davanti a più quotidiani doveri, non offuschi la dignità e fragilità dei singoli esseri umani?
E infine. Leggendo Potere e salvezza di Jan Assmann ho scoperto che la ventiquattresima dichiarazione d’innocenza dell’antico Egitto — una lista proferita dal morto per garantire la propria rettitudine al tribunale divino e purificarsi moralmente — recita: «Non mi sono finto sordo alle parole della verità».
Davanti allo specchio, in solitudine, senza alcuna cosmesi social, siamo sicuri di non esserci finti sordi alle parole della verità?



