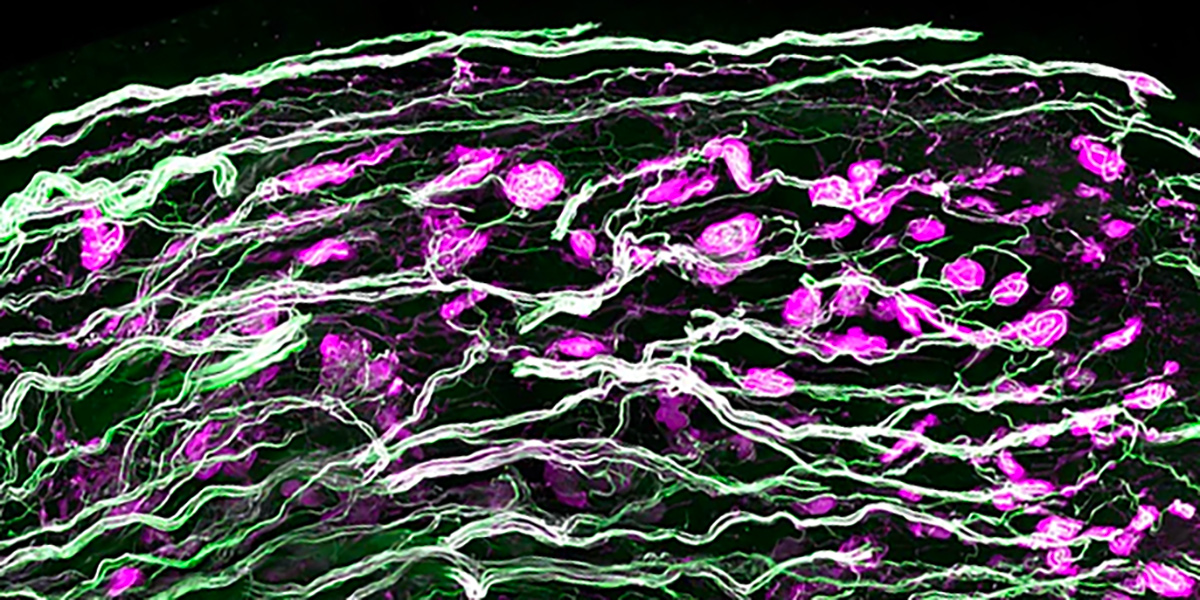Perché alcuni cibi ci disgustano?
E perché ad alcune persone succede più che ad altre? In parte è per una funzione evolutiva di difesa, ma c’entrano anche altri fattori

Nelle settimane scorse è circolato molto sui social un test online (in inglese) che cerca di misurare e classificare tramite un’autovalutazione il disgusto per alcuni cibi sulla base dei diversi fattori specifici che lo attivano. Nel test, intitolato Food Disgust Test e sviluppato da una piattaforma (IDRlabs) che pubblica quiz tratti da articoli scientifici, viene chiesto di esprimere approvazione o disapprovazione riguardo a 32 affermazioni del tipo: “Trovo disgustoso mangiare formaggio a pasta dura dalla cui superficie sia stata rimossa la muffa” e “Trovo disgustoso mangiare pesce crudo come il sushi”, ma anche “non bevo dallo stesso bicchiere da cui ha bevuto qualcun altro”.
Come specificato dagli autori, il test di sensibilità al disgusto alimentare ha soltanto un valore didattico e non diagnostico (obiettivo per cui è consigliabile rivolgersi eventualmente a specialisti della salute mentale). Ha generato comunque un certo interesse ed è stato ripreso da alcuni siti di informazione per l’opportunità che offre di riflettere su una delle emozioni primarie, il disgusto, e sui condizionamenti sociali, culturali e ambientali che subisce. Questi condizionamenti contribuiscono a determinare la variabilità individuale e collettiva del disgusto alimentare e ne fanno qualcosa di molto più complesso e diverso da un meccanismo evolutivo di difesa dall’ingestione di sostanze tossiche e nocive.
Il test circolato su internet si rifà a una classificazione dei fattori di disgusto basata su otto gruppi distinti, proposta nel 2018 da una ricercatrice e un ricercatore del Politecnico federale di Zurigo (ETH), Christina Hartmann e Michael Siegrist. Entrambi si occupano di comportamento dei consumatori, la disciplina che attraverso diverse branche delle scienze sociali (psicologia, sociologia, economia comportamentale, antropologia sociale e altre) studia il modo in cui le emozioni e le preferenze dell’individuo e del gruppo influenzano i comportamenti negli acquisti.
Negli studi di Hartmann e Siegrist il disgusto per un certo tipo di cibi o un altro non è inteso come qualcosa che è soltanto o presente o assente, ma come una ripugnanza che può variare di intensità a seconda dei casi. Una delle scale di sensibilità al disgusto alimentare da loro descritte è il grado di sensibilità alla carne animale, che determina la tendenza a provare disgusto per la carne cruda o per le parti degli animali mangiate meno comunemente (le frattaglie, per esempio). Una persona può gradire molto il sapore e la consistenza di una certa pietanza a base di un certo taglio di carne, ma avere un intenso disgusto per pietanze a base di altre parti e tessuti dello stesso animale.
Dei diversi fattori di disgusto alimentare, scrivono Siegrist e Hartmann, si ritiene che la sensibilità alla carne sia tra quelli con una più forte base culturale. Per ragioni molto radicate, che possono a loro volta essere influenzate da argomenti relativi ad aspetti religiosi e morali, un certo numero di persone in una determinata società può trovare disgustoso e inaccettabile mangiare carne di animali che invece sono parte della cucina di altri paesi in altre culture.
In altri studi sul disgusto alimentare, simili fattori basati su argomenti di ordine culturale e morale sono risultati influenti anche nel caso del disgusto per i prodotti ottenuti tramite nuove biotecnologie, come gli OGM, o per quelli di origine animale considerati inappropriati, come i prodotti a base di insetti. I ricercatori suggeriscono che per molte persone influenzate da questi fattori il disgusto sia tale da renderli sostanzialmente insensibili a eventuali argomenti basati su una valutazione dei rischi e dei benefici dell’introduzione di quegli alimenti.
– Leggi anche: Le farine di insetti, spiegate
Il genere di disgusto alimentare di cui si sono più occupati Hartmann e Siegrist è però quello alla base di variazioni individuali e di gruppo meno omogenee e prevedibili rispetto a quello mediato da fattori culturali più estesi e condivisi. È in particolare un disgusto attivato da segni che possono essere interpretati in modo diverso da persona a persona. La sensibilità alle muffe indicata da Siegrist e Hartmann come altro possibile fattore di disgusto, per esempio, è un esempio abbastanza chiaro di come un disgusto correlato alla possibile presenza di organismi patogeni possa emergere anche in presenza di muffe che non comportano rischi significativi per la salute.
Il disgusto determinato dalla sensibilità alle muffe è un meccanismo di difesa normalmente attivo di fronte ad alimenti potenzialmente dannosi, e cioè quelli su cui si sviluppano muffe che potrebbero renderli non più buoni da mangiare. I formaggi freschi, per esempio, richiedono di essere mangiati entro poche settimane, prima che la muffa favorisca la proliferazione di batteri nocivi. In questo caso il disgusto alimentare è strettamente correlato al disgusto in quanto emozione primaria, in grado cioè di attivare un comportamento necessario alla sopravvivenza: non ingerire il cibo andato a male.
– Leggi anche: Partiamo dalle Basi
Lo stesso disgusto può però manifestarsi anche quando la muffa non comporta concreti rischi per la salute, come nel caso di quella che a volte si forma sulla superficie di formaggi a pasta dura o semidura, come il formaggio svizzero o il cheddar. In questo caso è possibile mangiare il formaggio dopo aver rimosso la parte ammuffita, facendo attenzione a tagliarla via e non a raschiarla (azione che potrebbe aumentare il rischio di contaminare la parte non ammuffita). E ci sono poi anche alcuni tipi di muffe commestibili notoriamente utilizzate per produrre alcuni formaggi, come il Camembert, il Gorgonzola, lo Stilton o altri meno diffusi, che a seconda delle abitudini e dei gusti possono risultare deliziosi ad alcune persone ma sgradevoli ad altre.
La ragione evolutiva del disgusto per questo tipo di alimenti è che il deterioramento del cibo, sia quello di origine animale che quello di origine vegetale, è spesso segnalato da cambiamenti di colore, consistenza, odore e sapore. E alimenti che presentano cambiamenti di questo tipo possono quindi indurre una reazione di disgusto, anche quando i cambiamenti non indicano necessariamente la presenza di agenti patogeni, come nel caso di un frutto la cui polpa diventa scura per effetto dell’ossidazione pur rimanendo del tutto commestibile.
Un altro fattore di disgusto alimentare descritto da Siegrist e Hartmann non riguarda nemmeno dei cibi specifici bensì le condizioni igieniche relative alla loro preparazione o alla loro assunzione. Anche in questo caso il disgusto deriva da una predisposizione evolutiva a evitare o ridurre rischi di contaminazione del cibo. Ma la soglia di accettabilità delle condizioni igieniche può variare molto, sia tra una cultura e l’altra, sia da persona a persona, e quindi in presenza di pratiche e abitudini alimentari condivise (ci sono persone che non mangiano stuzzichini se sono serviti su un piatto comune, per esempio).
Nella letteratura scientifica il disgusto è considerato un’emozione primaria che protegge l’organismo scoraggiando l’ingestione di cibi il cui sapore o aspetto è spesso associato alla presenza di agenti patogeni. Si è quindi evoluto in un meccanismo più complesso, che aiuta a regolare il comportamento in varie situazioni sociali e interpersonali, tenendo conto dei relativi costi e benefici nell’evitare determinati stimoli. E per questa ragione è possibile considerarla «un’emozione dei confini», come ha spiegato la dottoressa e psicoterapeuta Serena Barbieri del centro clinico Spazio FormaMentis di Milano, nel podcast del Post Le Basi, a cura di Isabel Gangitano.
È un’emozione che ha originariamente a che fare con la ricerca e la disponibilità di risorse nutrienti necessarie alla sopravvivenza. Non essere abbastanza “disgustati” mentre ci si muove all’interno di un ambiente potrebbe portare a ingerire sostanze nocive. Ma esserlo troppo – non mangiare un frutto un po’ ammaccato – potrebbe limitare le opportunità di nutrimento.
Come ricordato dalla neuroscienziata canadese Rachel Herz, esperta nella psicologia degli odori e autrice del libro Perché mangiamo quel che mangiamo, il disgusto è l’unica emozione di base che deve essere «appresa», calibrando la propria reazione agli stimoli sulla base di regole e risposte condivise dai genitori, dagli altri membri del gruppo e dalla cultura in generale. E questa eredità culturale subisce l’influenza dell’ambiente.
– Leggi anche: Perché ci piacciono i saponi che sanno di vaniglia e cioccolato
Molti degli alimenti che possono dare disgusto sono quelli ottenuti tramite la fermentazione, il processo in cui gli enzimi di alcuni microrganismi – batteri e funghi, in particolare lieviti e muffe – scompongono lo zucchero presente in un cibo in altre sostanze. È uno dei metodi di conservazione più antichi e relativamente economici al mondo, perché non prevede l’utilizzo di sale o di spezie ma soltanto l’assenza di ossigeno e il passare del tempo.
Una delle ragioni per cui alcuni alimenti significano molto per determinate comunità è che contengono qualcosa di essenziale della flora o della fauna di una certa regione, ha scritto Herz. E lo stesso vale per i microrganismi che rendono possibile la fermentazione dei cibi, che variano notevolmente da una parte all’altra del mondo. I batteri utilizzati nella produzione del Kimchi, un piatto coreano a base di cavolo e ravanelli fermentati, non sono gli stessi utilizzati per produrre il formaggio Roquefort.
Il disgusto è stato condizionato nel tempo anche dalla disponibilità di nuovi metodi, tecniche e strumenti di conservazione del cibo, dalla pastorizzazione ai frigoriferi, che hanno reso certi tipi di fermentazione meno necessari e diminuito la familiarità delle persone con certi sapori.
In uno studio di antropologia, biologia e psicologia pubblicato nel 2021 sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori analizzarono i comportamenti di disgusto tra gli Shuar, un popolo indigeno che abita nella regione amazzonica dell’Ecuador e del Perù. E scoprirono che i membri dei gruppi e delle famiglie meno isolate e più integrate nella moderna economia di mercato – quelli che vivevano non di agricoltura, pesca e caccia, ma con un lavoro salariato o vendendo prodotti agricoli – avevano più alti livelli di sensibilità al disgusto, più probabilità di evitare cibo avariato e un minor numero di infezioni batteriche, virali e parassitarie.
– Leggi anche: Il gusto del marcio