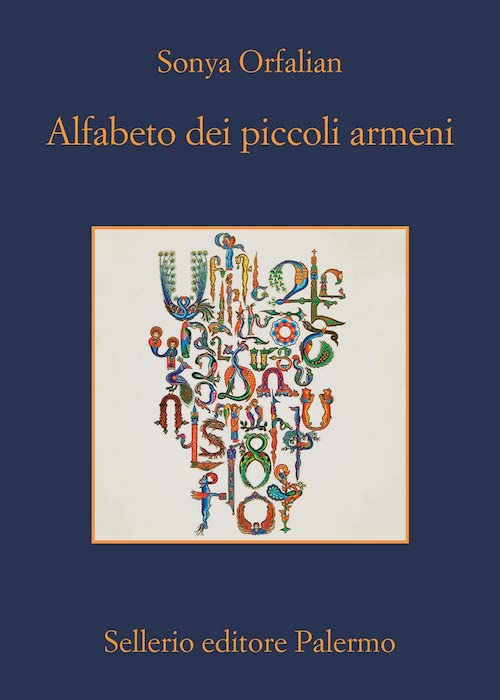La storia di un sopravvissuto al genocidio degli armeni
Una di quelle raccontate nel libro “Alfabeto dei piccoli armeni” di Sonya Orfalian, e che riguarda anche l'Italia

Il 24 aprile è il Giorno del Ricordo per il genocidio armeno perché il 24 aprile del 1915 i più importanti esponenti della comunità armena di Costantinopoli, l’attuale Istanbul, furono arrestati per ordine del ministro dell’Interno dell’Impero Ottomano: tale data viene considerata l’inizio del genocidio, una serie di deportazioni e uccisioni in cui si stima che morì più di un milione di persone.
Tuttora la storia del genocidio degli armeni, che è stato riconosciuto come tale da un paese come gli Stati Uniti solo nel 2021, è relativamente poco nota e i libri che ne parlano sono meno diffusi di quelli che riguardano altri gravi eventi della storia del Novecento. Ne è appena uscito uno, pubblicato da Sellerio: Alfabeto dei piccoli armeni di Sonya Orfalian. Orfalian, che da anni si occupa della memoria del genocidio e della cultura armena, è nata in Libia da genitori armeni, vive a Roma dagli anni Settanta ed è apolide. Nel libro ha messo insieme con qualche rielaborazione letteraria le storie di 36 persone armene sopravvissute al genocidio – 36 sono anche le lettere dell’alfabeto armeno, da cui il titolo – e che erano bambine quando avvenne, tra il 1915 e il 1923. Ne pubblichiamo una.
***
Փ
Dicràn
Non so dove sono nati i miei genitori, credo ad Ankara.
Mio padre, che è un alto funzionario del governo turco, ispettore della Banca ottomana, si è nascosto in soffitta e io, incuriosito del trambusto in strada provocato dai turchi che stavano rastrellando gli armeni, mi sono affacciato alla finestra. «Mio padre si è nascosto!», grido alla mia compagna di giochi, che vedo passare per la strada…
Ho appena quattro anni, a me sembrava un gioco, non capisco perché sono entrati in casa e l’hanno portato via con le mani legate.
Poi ci hanno detto che lo hanno condotto in un bosco e con l’ascia gli hanno spaccato la testa.
Dopo la cattura di mio padre, la nostra casa è stata saccheggiata dai turchi.
Ci hanno cacciato, ci hanno fatto camminare lontano, esiliati.
Lungo la strada della deportazione, di notte, siamo scappati.
Mamma ha tirato fuori le monete d’oro che aveva cucito nella mia giacca, ne ha date un paio a una sentinella che ha finto di non vederci andare via.
Mia madre vuole tornare indietro, a casa, ad Ankara. Per ora siamo in un grande casolare, tutti ammucchiati.
Dormiamo sotto il cavallo del comandante, e quando fa i bisogni ci sporca. Ma non c’è altro posto.
Siamo rimasti vivi io e mia madre, una sorella di mio padre, e mio fratello neonato in braccio a mamma.
In casa non possiamo entrare perché ci sono dei sigilli.
Ma un mio zio, che si era nascosto ed è rimasto vivo, è venuto e li ha tolti.
La casa è vuota, tutto è stato rubato.
Così lo zio è entrato nell’appartamento sopra al nostro, ha preso qualche mobile per noi.
Anche alla famiglia di sopra era toccato l’esilio…
È arrivato il colera e ogni mattina passano i carri e raccolgono i cadaveri. Ci sono dei mucchi altissimi di cadaveri.
Io e la mamma viviamo insieme, ma lei si è ammalata di colera.
È morta e sono rimasto solo.
Sono circa sei anni che mi spostano da un orfanotrofio a un altro: Ankara, Erzurum, Van…
Soffro la fame perché non ci danno da mangiare abbastanza.
A Erzurum c’era un orto recintato, noi bambini abbiamo scavato sotto la recinzione: mangiavamo le melanzane crude, dalla fame che avevamo.
Un frate che cerca i bambini armeni dispersi ha saputo di me. È venuto a prendermi.
Mi porta a Costantinopoli, mi affida al convento dei padri mechitaristi.
Dicono che un turco buono ha detto ai padri: «È meglio che portiate via questi ragazzi, prima che succeda qualche altra cosa».
Ho undici anni, e con una nave sono arrivato in Italia, a Venezia, nel bacino di San Marco.
Siamo sessanta orfani armeni, provenienti da tanti luoghi dell’Armenia, con un passaporto collettivo.
A Venezia i padri armeni ci insegnano tante materie: inglese, francese, matematica, algebra, scienze. Non amo lo studio, però ho imparato a scrivere l’armeno, ho imparato le altre lingue. A me piacciono i mestieri manuali, so lavorare molto bene il legno.
Sono un bravo falegname, ho aperto una bottega. Un giorno arrivano dei clienti, sono turchi. Li accolgo e li saluto nella loro lingua.
Sono sorpresi e mi chiedono chi sono e perché parlo il turco.
Racconto tutto.
L’uomo è un avvocato, è in vacanza con la moglie in Italia. Ascolta la mia storia. Promette di cercare notizie dei miei cari, mi scriverà.
Nella lettera che ricevo mi conferma che mio padre è effettivamente morto, ma che mio fratello è ancora vivo.
Così scopro che avevo ancora un fratello in vita e una zia.
Ci scriviamo per alcuni mesi e dopo un po’ di tempo mio fratello Avedìs viene a trovarmi.
Ma non è riuscito ad ambientarsi e ha preferito tornare a Istanbul.
Dopo un mese dal suo rientro è morto.
Sono quindi andato all’ambasciata turca per chiedere informazioni.
Il console mi dice solo: «Ah! Noi ti conosciamo e conosciamo la fama di tuo padre, che tanto ha fatto per noi!».
Nient’altro. Neppure l’atto di nascita che ho richiesto mi hanno mai dato.
Neanche il certificato di morte di mio padre… di mia madre…
Ma il mio atto di nascita almeno… Dove sarei nato, allora?
A tutt’oggi sono apolide, ho il passaporto Nansen dal 1939.
Ho fatto richiesta per la cittadinanza italiana ma chiedono tanti documenti da presentare, e io non ho quei documenti, non me li danno.
Volevo arruolarmi, ma ero straniero e non ho potuto farlo.
Poi ho fatto domanda anche per partecipare alla guerra d’Africa: anche lì niente.
Mi sono sposato dai padri armeni perché le chiese italiane mi chiedevano documenti che non ho mai potuto ottenere.
Io non so se sono apolide, né cosa sono.
Ai miei figli non ho raccontato mai niente di quello che mi è capitato. Io non so che pesce sono.
Non ho mai avuto un certificato di nascita. Mio fratello aveva il passaporto turco, io no. E neppure al suo funerale sono potuto andare, con il documento che ho.
In Italia mi sono integrato subito. Bisogna sapersi adattare. Se dormi per terra ti abitui a dormire per terra, se dormi sulla bambagia ti abitui a quella. Tutto è abitudine. Una persona si può abituare a qualsiasi cosa, se ha volontà.
Non ho desiderio di tornare ad Ankara a cercare la casa paterna. Ormai morirò qui, anzi, vorrei essere bruciato per non lasciare alcuna traccia.
Ho tribolato tanto nella mia vita…
Durante la guerra, in Italia ho sofferto la fame come tutti.
Io maledico ogni giorno i turchi. E quando laggiù capita qualcosa, un terremoto, un nubifragio o qualche altra disgrazia, ogni volta spero che quelle calamità distruggano tutto.
2021 © Éditions Gallimard, Paris
2023 © Sellerio editore via Enzo ed Elvira Sellerio 50 Palermo