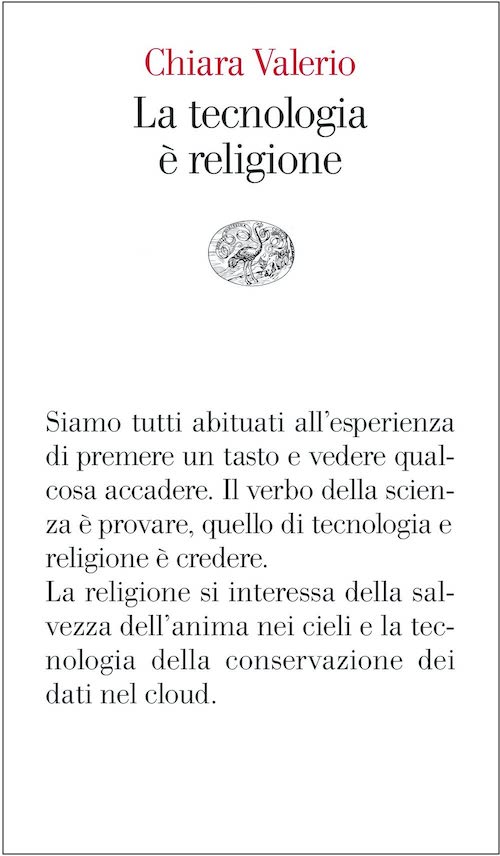«Che differenza c’è tra danzare per far piovere, e schiacciare un tasto per illuminare uno schermo?»
È una delle domande che si fa Chiara Valerio a proposito del mondo in cui viviamo nel suo pamphlet "La tecnologia è religione"

Usiamo continuamente dispositivi tecnologici di ogni genere, in misura tale da rendere faticoso il privarcene, anche se temporaneamente. Eppure la maggior parte di noi conosce i meccanismi di funzionamento di questi dispositivi solo per sommi capi. Perciò, in un certo senso, sono come oggetti magici. A partire da questa osservazione si sviluppa La tecnologia è religione di Chiara Valerio, un breve libro di domande e riflessioni sulle interazioni tra il nostro corpo e i suoi prolungamenti artificiali, che tra le altre cose si chiede se anche il linguaggio possa essere considerato una forma di tecnologia.
Valerio è una degli scrittori che questo fine settimana parteciperanno alla nuova edizione di Pensavo Peccioli, il festival culturale ospitato nel borgo toscano di Peccioli, in provincia di Pisa, curato dal peraltro direttore del Post Luca Sofri insieme alla fondazione Peccioliper. Il programma di quest’anno è costruito intorno all’ambizione di «capire cosa sta succedendo, a noi e al mondo», grazie a sguardi originali del dibattito culturale italiano, sia nel campo della letteratura che in quello della saggistica, come quello di Valerio. Parlerà di La tecnologia è religione, pubblicato da Einaudi, insieme a Ludovica Lugli del Post domenica 19 marzo alle 17.
***
Che differenza c’è tra danzare per far piovere, e schiacciare un tasto per illuminare uno schermo?
Quando nel 1990 il televisore entra per la prima volta in casa mia, non è un apparecchio qualsiasi, è l’ultimo modello della Philips e soprattutto (piú moderno di quello di nonna Tina, l’unico televisore a cui avevo accesso fino a quel momento) non bisogna alzarsi per accenderlo. Il televisore ha il telecomando.
A dodici anni diffidavo del telecomando e dell’idea che esso rappresentava, e mio padre mi sfotteva accendendo lo schermo di sponda. Mi mostrava cioè che l’impulso emesso, in cor- rispondenza della pressione su un tasto, si comportava come una biglia. Ero brava a mandare le biglie in buca – flipper o labirinti – e avevo impiegato poco a impratichirmi nel rimbalzo del segnale per accendere la tv. Questo per dire che avevo saputo, senza averlo dovuto imparare, e di certo senza capirlo del tutto, che tra le cose visibili o invisibili esistono rapporti di causa-effetto anch’essi visibili o invisibili. La forza è la causa, come sappiamo da Landau e Guerre stellari. Purtroppo, se non è sempre facile stabilire le cause, è semplicissimo fraintenderle. (Pochissimi Jedi).
Ricomincio. Che differenza c’è tra danzare per far piovere, e schiacciare un tasto per illuminare uno schermo? Nessuna.
In entrambi i casi, un nostro movimento induce una azione che fornisce una risposta o soddisfa una richiesta. La danza della pioggia si rivolge al cielo e il dispositivo che ne attiva l’intervento è il nostro corpo. Nel secondo caso il dispositivo è un prolungamento del corpo – telefono, smartphone, telecomando – e l’invisibile a cui ci rivolgiamo è il campo elettromagnetico. Nel momento in cui tutti i nostri dispositivi saranno virtualizzati – gli hard disk sono in dismissione sostituiti da nuvole di dati, cloud, le carte di credito come oggetti fisici stanno scomparendo, pagheremo, già paghiamo, ruotando lo smartphone che teniamo in mano o lo smartwatch allacciato al polso –, torneremo ad avere solo il nostro corpo come dispositivo e un gesto della mano, del piede, un cenno della testa accenderà la luce, e un battito di ciglia abbasserà le persiane. Danzeremo per far accadere cose e persone intorno. A quel punto, senza aver chiaro o almeno presente come ci siamo arrivati, senza piú ricordarci che i dispositivi consumano (dunque esistono), potremo credere di essere la causa di ciò che accade. E ancora che la rappresentazione della realtà e la realtà coincidano in toto e non per minime porzioni. Dimenticheremo che il linguaggio è una sintesi. Abbiamo immaginato parole per descrivere il mondo e per sostituirlo, ha scritto Fleur Jaeggy.
Elon Musk (programmatore, imprenditore, immaginatore, piú di 2000 anni dopo Platone) sa meglio di tutti che la tecnologia anima il mondo. Che, forse, finalmente, il confine tra logica ed esperienza sensibile, ragione e sentimento, spirito e materia può tornare permeabile.
Studiare aiuta a fare distinzioni nelle cose invisibili, a non confondere l’intervento divino o magico con l’avanzamento tecnologico. Studiare scienze, piú specificamente, consente di non percepire la tecnologia come fenomeno magico o religioso, ma come risultante di un avanzamento di umane umanissime conoscenze affette da errore e passibili di evoluzione e miglioramento. Studiare scienze aiuta ad accettare che l’oltremondo è in questo mondo, ma a un ordine di grandezza – segnali elettrici, impulsi elettromagnetici e galassie – che non percepiamo con i nostri sensi.
Penso a C’è molto spazio là in fondo, la conferenza nel 1959 al Caltech in cui Richard Feynman (fisico, premio Nobel, piú di 2000 anni dopo Platone) introduce le nanotecnologie. L’oltremondo, l’invisibile, i nodi nel tempo sono accessibili. Il dispositivo che può ingrandire tanto una figura o un oggetto fino a immaginarne la struttura e avvicinarsi a una persona tanto da intuirne l’anima, è la nostra testa. Studiare scienze è il contrario di capire tutto, anzi è ricordarsi, a ogni passo, che tutto non si può capire e che alcune cose, volta per volta, epoca storica per epoca storica, non sono spiegabili, ma possiamo esercitarci a ipotizzare, immaginare, semplificare il mondo per comprenderlo e aiutare altri a farlo. Studiare significa non accontentarsi della nostra immagine logico-razionale del mondo. Studiare significa accettare di sbagliare, e accettare gli sbagli degli altri. Come passi di un ininterrotto processo conoscitivo.
Aggiungo una cosa.
Come molti studenti e studentesse, alle scuole superiori mi ero imbattuta nella disputa secentesca tra natura corpuscolare e ondulatoria della luce. Ovviamente, abituata ad accendere il televisore di sponda, ho impiegato settimane a convincermi delle ragioni dell’ipotesi ondulatoria. Nella mia testa la luce era un flusso di biglie di luce rimbalzanti. Il mio cervello e il mio cuore, forse per la prima volta, erano in disaccordo. Provavo, con difficoltà, a immaginare la luce come un fluido denso di biglie piccolissime. Per convincermi, mi ripetevo D’altronde il vetro è un fluido molto denso, dunque scorre anche se molto lentamente. Come se non bastasse, tra Newton (teoria corpuscolare) e Huygens (teoria ondulatoria) preferivo quest’ultimo perché appassionato di gioco d’azzardo. A quel tempo, infatti, giocavo ancora ai dadi.
Suspense. Non racconterò qui come si è sviluppata e conclusa la disputa sulla natura della luce, diciamo però che a un certo punto è arrivato Maxwell con annesso diavoletto.
Questo scolio è per ringraziare mio padre che, impedendomi, col gioco del telecomando, di amare e accettare la teoria ondulatoria e godermi la storia dell’etere luminifero (è presto detto, se la luce è un’onda ha bisogno di un mezzo per propagarsi, tipo onde del mare nell’acqua), mi ha chiarito per sempre che alla soluzione di un problema spesso si giunge per tappe successive, errori, miscellanee di ipotesi contraddittorie. E convenzioni linguistiche.
© 2023 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano