Che rapporto abbiamo con i noi stessi del passato
Percepire una continuità nella propria storia personale o, al contrario, faticare persino a riconoscersi dipende da molti fattori
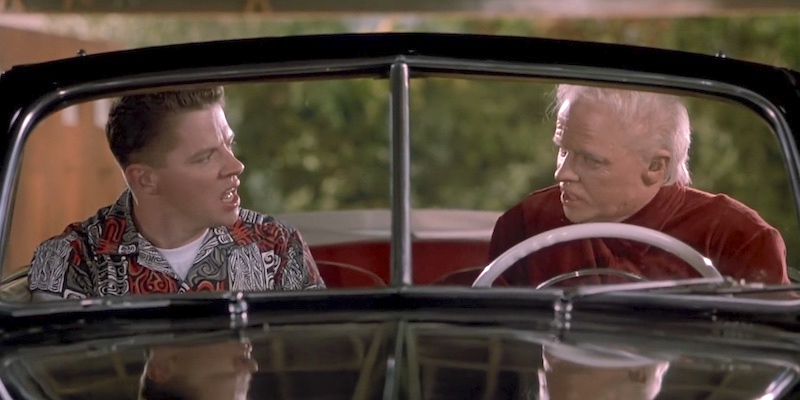
Pensando a come erano da adolescenti, o a come erano ancora prima, molte persone hanno l’impressione di essere cambiate moltissimo sotto diversi aspetti, a parte quello fisico. Osservano le tracce di gusti, abitudini e valori del loro passato – dalla musica all’abbigliamento, dalle inclinazioni politiche alle relazioni umane – e faticano a riconoscere sé stesse. Altre persone pensano invece di non essere poi così diverse da come erano un tempo, per certi aspetti, e altre ancora di non essere cambiate affatto.
Una volta, in un tentativo di accattivarsi le simpatie del suo elettorato durante la campagna presidenziale nel 2016, l’ex presidente americano Donald Trump, all’epoca settantenne, affermò di essere la stessa persona che era da bambino. Cosa non difficile da credere, considerato il suo comportamento solitamente impulsivo, scrisse nel 2020 un gruppo di psicologi neozelandesi e statunitensi nel libro The Origins of You: How Childhood Shapes Later Life, chiedendosi se a partire dal temperamento, dalle esperienze e dalla salute durante l’infanzia sia possibile prevedere la personalità degli individui in età adulta.
Esistono rari e ammirevoli tentativi di analizzare la questione da un punto di vista empirico ed “esterno”, cercando cioè di individuare elementi di continuità o discontinuità evidenti nello sviluppo delle persone nel corso di lunghissimi periodi di tempo. Bambini accomunati da una diagnosi di sindrome da deficit di attenzione e iperattività, per esempio, potrebbero presentare in età adulta determinati comportamenti o tratti caratteriali, e magari anche particolari inclinazioni e non altre verso sé stessi e il loro passato.
Ogni tentativo di inquadrare la questione in termini rigorosi, in una certa misura, si scontra tuttavia con una serie di limiti di queste ricerche. Qualsiasi raggruppamento di persone messe insieme per studiare nel tempo fenomeni comuni tende a trascurare inevitabilmente aspetti più individuali e difficilmente osservabili: aspetti che possono sfuggire alle categorizzazioni ma influenzare profondamente il rapporto che finiamo per avere con il nostro passato. Predisposizioni, percezioni e sentimenti nei confronti delle versioni passate di noi stessi hanno peraltro molto a che fare non soltanto con il nostro passato ma anche con il nostro presente e con le relazioni che instauriamo nel tempo, in un complesso sistema di condizionamenti reciproci.
– Leggi anche: Il complicato rapporto tra i progressisti e la genetica
Diversi articoli usciti nel 2022 hanno celebrato i cinquant’anni dalla pubblicazione di uno studio considerato prezioso e molto utile per questo genere di riflessioni e non solo, oltre che centrale nel libro The Origins of You.
Nel 1972, nella piccola città neozelandese di Dunedin, lo psicologo e ricercatore della University of Otago Phil Silva approfondì uno studio avviato da una pediatra della città, Patricia Buckfield, su 225 bambini e bambine. L’obiettivo iniziale era studiare l’impatto dell’utilizzo di alcune nuove tecnologie durante le nascite nell’ospedale ostetrico Queen Mary, ma lo studio fu esteso da Silva fino a coinvolgere in totale 1.037 bambini e bambine. Sarebbe dovuto durare soltanto tre anni: né Silva né Buckfield immaginavano che sarebbe diventato il Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, uno dei più citati e influenti studi longitudinali di sempre, tuttora in corso (sono definiti longitudinali gli studi che effettuano ripetute osservazioni dello stesso fenomeno in un lungo periodo di tempo, solitamente decenni).
Lo “studio Dunedin” – è l’abbreviazione più utilizzata per definirlo – ha continuato a seguire le vite dei partecipanti fino all’età adulta, fornendo dati che sono stati utilizzati nel tempo in oltre 1.300 ricerche, libri e studi peer-reviewed su argomenti di vario tipo: dal futuro rischio di ipertensione individuabile durante l’infanzia agli effetti a lungo termine della cannabis ai sentimenti di contrarietà ai vaccini contro il coronavirus.
Uno dei limiti noti e più evidenti dello studio – che oggi coinvolge poco meno di mille persone, note soltanto ai ricercatori – riguarda la composizione del campione: soltanto persone nate a Dunedin e dintorni negli anni Settanta (originariamente 535 bambini e 502 bambine, di cui 24 gemelli). È tuttavia generalmente apprezzato dagli studiosi il fatto che quelle persone siano cresciute in molti tipi di famiglie, anche molto diverse tra loro, e abbiano poi in gran parte (circa due terzi) lasciato Dunedin da adulte: fattori che rendono il campione relativamente più eterogeneo.
Le persone dello studio furono coinvolte una prima volta quando avevano tre anni, da Silva e Buckfield, e poi ancora a 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38 e 45 anni. E i ricercatori hanno spesso intervistato non soltanto i soggetti dello studio ma anche loro familiari e amici. Dopo che Silva andò in pensione alla fine degli anni Novanta, lo studio fu proseguito da altri ricercatori ed è oggi diretto dallo psicologo neozelandese Richie Poulton, coautore del libro The Origins of You, che raccoglie oltre ai risultati dello studio Dunedin quelli di altri studi correlati condotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per un totale di circa 4 mila persone seguite nel corso di decenni.
– Leggi anche: Sui figli unici circolano tanti pregiudizi
Le scoperte sulle relazioni tra il nostro passato e il nostro presente confermano in molti casi diverse idee comuni riguardo allo sviluppo umano. E in generale, per descrivere meglio l’idea stessa di “sviluppo umano” come un campo di studio multidisciplinare, gli psicologi infantili e i neuroscienziati autori del libro utilizzano la metafora del clima.
Cercare di comprendere in che modo diventiamo ciò che siamo, affermano Poulton e gli altri, riguarda la psicologia perché è una ricerca che richiede di analizzare emozioni, cognizioni e comportamenti. Ma riguarda anche le neuroscienze, la sociologia, la politica e le scienze biologiche, perché richiede di studiare la mente e il cervello, la famiglia e le altre relazioni sociali, e anche la genetica, la fisiologia e la salute pubblica. E ciascuno di questi fattori, come nei modelli climatici, interagisce con tutti gli altri in modi complessi nel tempo e nello spazio.
Relativamente all’aspetto psicologico e sociologico della questione, ritenersi assolutamente coerenti e immutabili nel tempo, per quanto ne dica Trump o chiunque altro, è soprattutto una questione di percezioni e convinzioni, ma non toglie niente al fatto che qualsiasi individualità sia il risultato delle interazioni di molte forze diverse. E non è facile prevedere quale sarà il risultato di determinati fattori, scrivono gli autori del libro: perché la meteorologia, come lo sviluppo umano, è una scienza probabilistica, non deterministica.
Il vantaggio di uno studio longitudinale come lo studio Dunedin, ha scritto recentemente il New Yorker, è che non è retrospettivo e aggira quindi sia possibili pregiudizi di selezione del campione che inevitabili limiti della memoria dei partecipanti. Alcuni sforzi compiuti nella ricerca scientifica per dimostrare, per esempio, che le persone che subiscono abusi da bambini ne portano i segni da adulte cominciano dallo studio di persone che mostrano determinati segni nel presente. E questo restringe inevitabilmente il campione di partenza.
Oppure, allo stesso modo, uno studio retrospettivo su un gruppo di adulti ansiosi potrebbe scoprire che molti di loro sono cresciuti con genitori divorziati: ma non direbbe niente dei molti figli divorziati che non hanno sviluppato ansia e non sono quindi stati coinvolti nello studio, scrive il New Yorker.
– Leggi anche: Per valutare il successo bisogna considerare il “pregiudizio di sopravvivenza”
I ricercatori dello studio Dunedin avviarono una prima classificazione del loro campione quando i soggetti avevano tre anni. Al termine di interviste di un’ora e mezzo ciascuna, valutarono diversi aspetti della personalità: irrequietezza, impulsività, caparbietà, attenzione, cordialità, capacità comunicativa e altri ancora. Sulla base di quei risultati, definirono quindi cinque diversi macro-gruppi.
Il gruppo più numeroso – circa il 40 per cento del campione – era formato da bambini «equilibrati», che presentavano una combinazione ricorrente di certi tratti della personalità. Un 25 per cento era formato da bambini più estroversi e sicuri di sé, che più di altri si trovavano a loro agio con estranei e in situazioni nuove. Un altro 15 per cento era più riservato e inizialmente diffidente. Un 10 per cento del campione fu infine classificato come «chiuso», formato da bambini particolarmente timidi e introversi, e un altro 10 per cento – con una leggera prevalenza di soggetti maschi – come «ipocontrollato» dal punto di vista degli impulsi, formato da bambini impulsivi, scontrosi e irrequieti.
Dopo le interviste effettuate nei decenni successivi, i ricercatori riuscirono a individuare alcuni modelli di riferimento quando i soggetti compirono 18 anni. Le distinzioni tra i soggetti dei primi tre gruppi erano diventate poco chiare: sebbene emergessero ancora delle vaghe corrispondenze tra determinati tratti della personalità e ciascuno dei singoli gruppi, i ricercatori decisero di accorparli in un gruppo unico. La loro attenzione si concentrò sui ragazzi e le ragazze del terzo e del quarto gruppo, che mostravano invece segni più evidenti di coerenza rispetto ai tratti che avevano mostrato fin dai tre anni.
Gli adolescenti del gruppo dei bambini «chiusi» erano «significativamente meno energici e determinati» di tutti gli altri, scrissero i ricercatori. Quelli del gruppo «ipocontrollato» descrivevano invece sé stessi come «alla ricerca del pericolo» e, rispetto agli altri adolescenti, erano «i meno propensi a evitare situazioni dannose, eccitanti e pericolose» o «a comportarsi in modo riflessivo, cauto, attento o programmato». Tendevano inoltre più spesso degli altri ad arrabbiarsi e a considerarsi «maltrattati e vittime» nei confronti del loro passato e del mondo.
– Leggi anche: I nomi e i cognomi influenzano le nostre vite?
Le interviste successive nell’ambito dello studio Dunedin mostrarono un progressivo «allontanamento dal mondo» da parte degli adulti del gruppo dei più introversi. Molti di loro seguirono stili di vita contraddistinti da particolare discrezione e avvedutezza, ma comunque senza che questo implicasse un disadattamento, e compiendo anzi scelte spesso gratificanti. Gli adulti del gruppo «ipocontrollato» mostrarono invece una progressiva e durevole inclinazione a «muoversi contro il mondo», e le ricerche svolte nei decenni successivi associarono a quel gruppo maggiori probabilità di licenziamento e di problemi legati al gioco patologico.
I ricercatori attribuirono queste tendenze ai feedback generati dal temperamento di quegli individui, descritto come una «macchina che ne modella un’altra»: l’ambiente sociale, che continua a influenzare lo sviluppo della persona nel corso del tempo. In un processo che coinvolge sia la persona che l’ambiente, e che gli psicologi definiscono «scelta di nicchia», ciascun individuo tende infatti a favorire situazioni sociali in grado di confermare o rafforzare disposizioni preesistenti.
Bambini «equilibrati», scrissero i ricercatori, tenderanno ad attendere con impazienza il passaggio alla scuola di grado successivo, per esempio, sapendo che faranno nuove amicizie: cosa che effettivamente poi accade, di solito, e che accresce indirettamente in quei bambini la sensazione di avere un controllo sul mondo. Al contrario i bambini «chiusi» proveranno ansia, in occasione di quel passaggio di classe, e di conseguenza finiranno per avere meno opportunità di fare nuove amicizie: cosa che ridurrà la loro sensazione di esercitare un’influenza sul mondo.
Nel caso dei bambini – e poi degli adulti – impulsivi e scontrosi, che «si muovono contro il mondo», le loro «scelte di nicchia» determineranno più facilmente feedback sociali negativi: una tendenza cioè a respingere le altre persone e a interpretare come respingenti le azioni degli altri, anche quelle di altri eventualmente ben intenzionati. E proprio in queste situazioni potenzialmente pericolose quegli adulti tenderanno a sentirsi più a loro agio.
Ovviamente non è tutto già scritto, affermano i ricercatori. Le tendenze e le inclinazioni descritte dallo studio Dunedin non implicano che non si possa uscire dai cicli avviati dalle scelte di nicchia. Lo stesso studio suggerisce che i soggetti respingenti possono cambiare le loro predisposizioni verso il mondo in senso più positivo, se incontrano la persona giusta o il mentore giusto.
– Leggi anche: A che età risalgono i nostri primi ricordi
Per quanto utile a fissare una serie di punti nella discussione, e comprendere quanto le differenze tra i bambini possano contare nel tempo, lo studio Dunedin non è sufficiente a esplorare ogni senso possibile della domanda iniziale: quale sia il rapporto di ciascuna persona con il proprio passato, e quali siano i fattori che determinano l’impressione di continuità o, al contrario, di discontinuità rispetto a quel passato.
E non è sufficiente perché, come ha scritto il New Yorker, «tutti noi rientriamo in un numero qualsiasi di categorie, ma quelle categorie non comprendono completamente le nostre identità»: cosa che complica il tentativo di accordarsi su un senso della domanda che sia largamente condiviso. Qualsiasi persona potrebbe considerare sé stessa diversissima da come era in passato, per alcuni aspetti, e considerarsi la stessa di sempre, per altri.
Citando come esempio estremo l’incredibile storia dei fratelli James e William Bulger, fuorilegge il primo e politico il secondo tra i più noti nella storia dello stato del Massachusetts, il New Yorker scrive che i tratti comuni nel temperamento dei due fratelli di certo non furono sufficienti a renderli due persone simili, benché in molti dicessero che fossero più simili che diversi. Perché ciò che siamo, prosegue, non è determinato soltanto da «come» siamo ma da ciò che facciamo.
– Leggi anche: Vi capita di ricordare in terza persona?
Esistono poi persone con una ridotta o del tutto assente inclinazione a pensare a sé stesse storicamente, a collocare il proprio sé all’interno di una narrazione continua nel tempo: persone sostanzialmente indifferenti al fatto che la loro vita formi un tutto, un insieme di parti. In un suo saggio degli anni Novanta, il filosofo inglese Galen Strawson le descrisse come persone più «episodiche» di altre. Che non significa che quelle persone non abbiano un’esperienza di sé: solo che quella esperienza è per loro del tutto occasionale e passeggera, un’esperienza come le altre.
L’impressione di essere persone diverse o simili rispetto al passato è inoltre inevitabilmente condizionata dalle impressioni di altre persone. Potremmo sentirci diversissimi da come eravamo un tempo, magari irriconoscibili, oppure avere di noi stessi un’esperienza soltanto «episodica», nel senso di Strawson. E ciononostante un’altra persona a noi vicina da tempo – e a sua volta influenzata da altri processi e condizionamenti – potrebbe invece riconoscere nel nostro presente tratti riconducibili a un passato anche molto remoto. O, al contrario, non riconoscere più in noi quei tratti. E quella sua percezione, come quella di altre persone, potrebbe in ogni caso avere un effetto sulle nostre.
Le storie che le persone raccontano a sé stesse sul fatto di essere o di non essere cambiate, conclude il New Yorker, sono spesso anche semplificazioni utili a mettere ordine nel disordine, modi diversi di resistere a eventuali avversità e favorire il proprio sviluppo personale. La percezione di non essere le stesse persone può essere associata a narrazioni a volte più incentrate sull’imprevedibilità, la libertà e l’autonomia delle proprie scelte, altre volte più incentrate sulla propria vulnerabilità e fragilità. E la percezione opposta, quella di non essere cambiati nel tempo, può invece servire a rafforzare un’idea di coerenza considerata come un valore prioritario del proprio agire.



