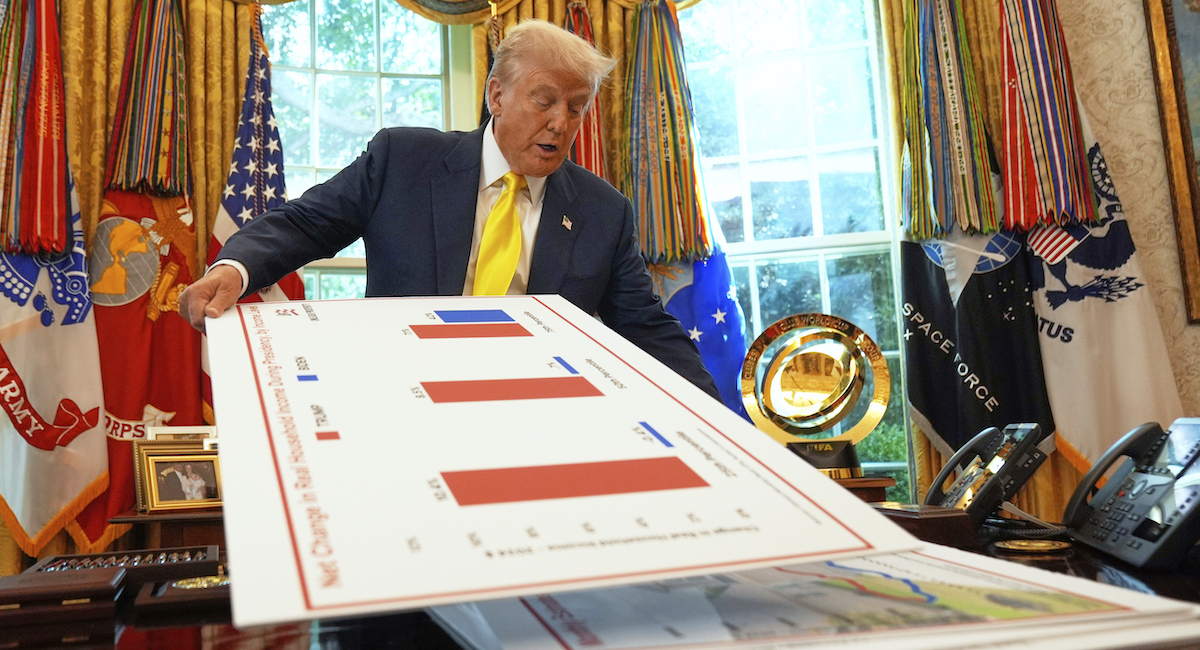Sarebbe davvero possibile introdurre la settimana lavorativa corta?
L'ha proposta il M5S nel suo programma, ma gli effetti di questa misura sul mercato del lavoro non sono ancora ben prevedibili
di Mariasole Lisciandro

Tra le proposte presentate durante questa campagna elettorale c’è stata anche quella del Movimento 5 Stelle sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. È un tema molto ricorrente, anche a livello internazionale, e la riduzione dell’orario di lavoro, chiamata anche “settimana corta”, è stata sperimentata in diversi paesi e aziende. Con la flessibilità sul lavoro ottenuta grazie alla pandemia da coronavirus, la riduzione dell’orario sarebbe un passaggio in più per ottenere un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata.
La proposta è sicuramente innovativa e ci sono molti vantaggi, soprattutto in termini di maggior benessere del lavoratore, ma gli economisti non sono ancora sicuri di quali potrebbero essere gli effetti.
Il Movimento 5 Stelle nel suo programma propone una «sperimentazione di una riduzione dell’orario di lavoro soprattutto nei settori a più alta intensità tecnologica. Le imprese che aderiscono al programma ottengono esoneri, crediti di imposta e incentivi aziendali per l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche e nuovi macchinari». Giuseppe Conte, in un’intervista alla Stampa, ha chiarito che si tratta di una sperimentazione su base volontaria, in modo da non imporla dall’alto alle imprese, con l’obiettivo di ridurre di quattro ore le tradizionali 40 settimanali.
Il tema si ritrova, con molto meno dettaglio e in forma quasi di accenno, anche nei programmi di Partito Democratico e in quello di Sinistra Italiana e Verdi.
Quanto si lavora oggi, in media
Dal dopoguerra a oggi, le ore di lavoro annuali per lavoratore sono scese in maniera significativa in quasi tutti i paesi OCSE, l’organizzazione che raggruppa i 35 paesi più sviluppati al mondo, grazie alla diffusione di migliori condizioni di lavoro. E si può dire che più una nazione è ricca, meno si lavora: all’interno dei paesi OCSE il paese in cui si lavora di più è il Messico, quello in cui si lavora di meno la Germania (almeno stando alle ore lavorate).
L’Italia si trova più o meno a metà della classifica, con 1.668,5 ore lavorate in media da ogni lavoratore in un anno. Vuol dire passare in media quasi un quinto del tempo a lavorare. Tra i grandi paesi europei è quello in cui si lavora per più ore (ma nell’Unione Europea si lavora di più in Grecia, Polonia, Irlanda, Estonia e Repubblica Ceca).
Oltre alle ore effettivamente passate al lavoro, una misura essenziale per capire la questione è la produttività, ossia quanto reddito si produce in un determinato periodo passato lavorando. Indica l’efficienza con cui è impiegato il lavoro all’interno nel sistema produttivo. Più si produce in un determinato lasso di tempo, più si è efficienti, più si è produttivi. La produttività può essere misurata in tanti modi, come il il PIL annuale per addetto o il PIL per ora lavorata.
Dipende da varie cose, come la tecnologia, la formazione dei lavoratori, le modalità con cui i lavoratori sono inseriti nelle dinamiche aziendali e così via. Ed è per questo che indirettamente le retribuzioni dei lavoratori sono legate alla produttività. Più un paese è produttivo e più, in media, gli stipendi saranno alti, perché è più alto il reddito che ogni lavoratore produce con il suo lavoro. È un fattore essenziale per la crescita e lo sviluppo, perché implica un uso efficiente delle risorse a disposizione.
L’Italia non è messa bene in termini di produttività: nel 2020 ogni ora lavorata ha prodotto circa 55 dollari di PIL, contro i 67 della Germania, i 68 della Francia e i 73 degli Stati Uniti. Fa peggio la Spagna, con 52 dollari. Non solo il valore è basso rispetto agli altri paesi, ma a confronto negli ultimi vent’anni è cresciuto anche molto meno meno: rispetto a 20 anni fa la produttività del lavoro in Italia è cresciuta del 4 per cento, contro il 19 per cento della Germania, il 18 per cento della Francia, il 16 per cento della Spagna e il 34 per cento degli Stati Uniti.
Non sorprende quindi che anche le retribuzioni non siano cresciute tanto quanto negli altri paesi. Secondo i dati dell’OCSE, rispetto a vent’anni fa la retribuzione media in Italia è cresciuta dello 0,5 per cento, contro il 20,1 per cento in Germania e il 23,9 in Francia. Anche in Spagna gli stipendi sono cresciuti di poco, dello 0,7 per cento, e oltretutto il livello medio è più basso di quello italiano.
Quali sono i pro e i contro di ridurre l’orario di lavoro
Gli argomenti a favore di questa misura sono molti. Secondo i promotori, concentrare in meno ore il lavoro garantirebbe un aumento della produttività, quindi nel lungo termine anche delle retribuzioni. Inoltre, sarebbe un passo ulteriore, dopo lo smart working, verso un miglioramento del rapporto tra vita privata e lavoro. E un lavoratore più appagato e meno stressato può essere anche più produttivo.
C’è poi chi sostiene che la riduzione dell’orario di lavoro sarebbe positiva per il raggiungimento della parità di genere, perché aumenterebbe la partecipazione al lavoro delle donne, grazie a una suddivisione più bilanciata della cura della famiglia.
Altro argomento a favore è che ridurre l’orario di lavoro porterebbe a un aumento dell’occupazione. La formula “lavorare meno, lavorare tutti” l’hanno proposta in molti e da tempo, anche se oggi non è questo l’argomento di punta dei sostenitori della riduzione dell’orario di lavoro.
Nel 1933 Giovanni Agnelli scrisse a Luigi Einaudi che «la riduzione proporzionale e generale delle ore di lavoro risolve il problema di distribuire il lavoro equamente fra tutti gli uomini, dando a tutti due ore addizionali di ozio». Nel 1997 la propose Fausto Bertinotti, leader di Rifondazione Comunista, durante il governo Prodi. E negli ultimi anni è stata rilanciata anche dal presidente dell’INPS, Pasquale Tridico.
Chi invece è contrario alla misura sostiene che concentrare il lavoro in meno ore rischia di sovraccaricare il lavoratore, causando più stress. Se poi la riduzione dell’orario viene introdotta a parità di stipendio, aumenterebbe il costo orario del lavoro, con un conseguente aumento degli oneri per un’impresa che deve assumere più dipendenti per compensare le ore lavorate in meno.
Inoltre, molti fanno riferimento ai lavori su turni, che non possono lavorare per obiettivi e concentrare semplicemente il lavoro in meno ore. Si pensi per esempio agli infermieri e ai commessi: se lavorano di meno devono essere sostituiti, con un aggravio dei costi per le imprese.
Dove è stata applicata, per ora
La Francia ha una legislazione sul tempo pieno a 35 ore settimanali. La riforma, che è sempre stata molto discussa, è stata introdotta in due fasi alla fine degli anni Novanta: nel 1998 con la legge Aubry I, che la introdusse su base volontaria, e nel 2000 con la legge Aubry II, che generalizzò per tutte le aziende una serie di agevolazioni fiscali, lasciò alle imprese stesse libertà di negoziare gli aspetti applicativi della riduzione e congelò i salari.
Sull’esperienza francese ci sono diverse valutazioni: c’è chi attribuisce l’effetto positivo sull’occupazione alla riduzione dell’orario di lavoro e chi invece alla maggiore flessibilità e alla riduzione delle imposte; alcuni hanno sottolineato l’intensificazione del lavoro e che, a qualche anno dalla riforma, l’orario medio sia tornato a crescere con il ricorso agli straordinari, e il fatto che le 35 ore siano costate moltissimo allo stato.
Anche in Portogallo nel 1996 è stato ridotto l’orario di lavoro, da 44 a 40 ore, a parità di salario e senza che fosse prevista una compensazione per le aziende. E in Italia nel 1997 l’orario massimo è passato da 48 a 40 ore. In questo caso, però, si è trattato di una riforma principalmente su carta, perché la maggior parte dei contratti collettivi prevedeva già 40 ore.
Negli ultimi anni sono state introdotte altre riduzioni. In Islanda è stato avviato un test nel 2015 che ha avuto esiti piuttosto promettenti: l’orario di lavoro è stato ridotto per 2500 lavoratori a 35 o 36 ore settimanali e senza ridurre la retribuzione. Oltre a un maggior benessere dei lavoratori, sembra che i servizi forniti non ne abbiano risentito e che anzi ci sia stata una maggior produttività.
In Belgio a inizio 2022 sono state accolte le richieste dei lavoratori introducendo per gradi la settimana lavorativa corta, ma a parità di ore, che vengono concentrate in quattro giorni invece che in cinque. L’accordo deve avvenire tra dipendente e datore di lavoro che dovrà fornire solide ragioni per poter rifiutare la richiesta. Dopo un periodo di prova di 6 mesi, entrambi decideranno se proseguire o meno.
Sperimentazioni di settimana lavorativa corta sono poi in corso in Spagna, con le ore che passano da 39 a 32, nel Regno Unito con i giorni di lavoro a settimana che passano da 5 a 4 in alcune aziende, e in Giappone dove, nel 2019, Microsoft ha concesso un giorno libero in più a settimana ai propri dipendenti con il risultato che la produttività è aumentata del 40%.
Si tratta ancora di sperimentazioni e a livello scientifico ed economico non si può dire ancora moltissimo sulla riduzione dell’orario di lavoro, perché non ci sono moltissimi studi al riguardo.
C’è però una recente ricerca di IRVAPP, l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, che ha misurato l’impatto di una misura del genere su occupazione, produttività e salari, analizzando le esperienze su cui ci sono più dati, come quelle degli anni Novanta. Lo studio rileva che ridurre l’orario di lavoro non ha avuto alcun effetto sull’occupazione, quindi né crea né distrugge posti di lavoro. In più, gli effetti positivi in termini di salari e produttività sono talmente piccoli da risultare insignificanti.
Andrea Garnero, economista dell’OCSE e uno degli autori dello studio, si dice sollevato dal tenore della discussione su questo tema: «Lavorare meno per lavorare tutti è uno slogan sessantottino e un’utopia. È apprezzabile però che le proposte in circolazione non abbiano come obiettivo l’aumento dell’occupazione, anche perché non c’è alcuna evidenza scientifica che una riduzione dell’orario di lavoro porti a una redistribuzione tra più lavoratori».
L’argomento più interessante della proposta «riguarda il migliore rapporto tra vita privata e lavorativa, su cui però manca totalmente l’evidenza scientifica. L’altro aspetto interessante è l’aumento della produttività, ma i risultati che ci sono non sono molto chiari. Per il momento esistono solo sperimentazioni a livello di impresa che sembrano dimostrarne un aumento, ma niente di validato a livello scientifico. Almeno, a differenza di un possibile aumento dell’occupazione, che proprio è un argomento non realistico, un aumento della produttività è una prospettiva quantomeno ragionevole e sensata».
Garnero poi sostiene che forse converrebbe invertire la questione: «La crescita economica si può redistribuire nel lavoro o aumentando le retribuzioni o dando più tempo libero ai lavoratori, che poi è quello che abbiamo visto storicamente. Rispetto a cento anni fa lavoriamo molto meno, sia in termini di ore che di giorni, abbiamo le ferie, la malattia, le pensioni. I nostri nonni e bisnonni non avevano niente di tutto ciò. La riduzione dell’orario di lavoro non dovrebbe essere vista quindi come la leva per aumentare la produttività, ma in senso opposto, al pari di un aumento salariale».
In ogni caso, Garnero ritiene che sarà difficile vedere una riforma cadere dall’alto su imprese e lavoratori: «Un altro punto che apprezzo di questa discussione è che si parla di sperimentazioni, incentivi e prove. Procedere alla francese oggi sarebbe un errore perché la situazione è troppo diversa da settore a settore».