I vagabondi del mare
Le vite e le scelte di chi lascia tutto per vivere in barca, raccontate nel nuovo numero di The Passenger dedicato all'oceano
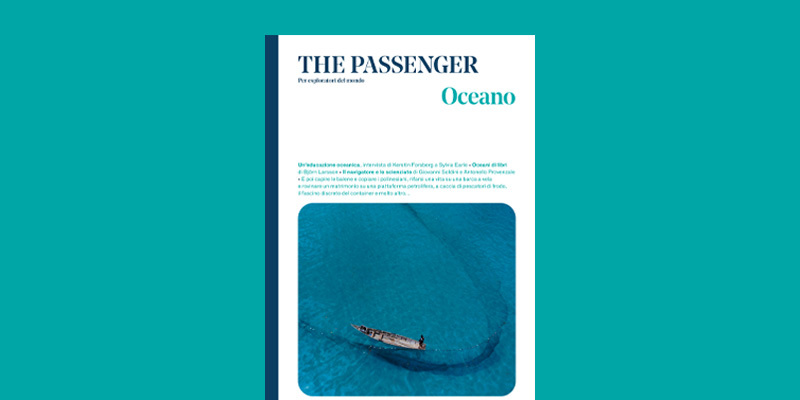
L’oceano è il protagonista dell’ultimo numero di The Passenger, il libro-rivista della casa editrice Iperborea dedicato a paesi, città e luoghi del mondo. È un invito a «essere meno terracentrici», ad avere una «visione del mondo meno antropocentrica» e a sviluppare interesse e empatia per i mari, i loro abitanti e le persone che ci vivono o lavorano: i dipendenti delle piattaforme petrolifere, i pescatori di frodo, gli impiegati nell’industria del trasporto marittimo e quelli che salpano su una barca e vanno in cerca di avventure. Hanno contribuito a questo numero, oltre a scrittori, fotografi e giornalisti, biologi marini, esperti di balene, ricercatori, attivisti, il velista Giovanni Soldini e Sylvia Earle, l’oceanografa più famosa del mondo. C’è anche una selezione di libri consigliati dallo scrittore svedese, e appassionato velista, Björn Larsson.

Uno squalo martello impigliato in una rete da pesca (Toby Matthews/The ocean agency)
Di seguito, l’inizio dell’articolo “I vagabondi del mare”, scritto dalla giornalista e consulente Valentina Pigmei, che racconta un po’ di storie di «persone normalissime» che lasciano tutto per passare la propria vita in mare.
***
I vagabondi del mare
di Valentina Pigmei
Secondo il filosofo delle scienze cognitive Roberto Casati alcuni di noi, ma solo alcuni, sono degli avventurieri, degli esploratori: scopritori di terre e di isole. «Sulla spiaggia davanti al mare aperto c’è chi incontra un limite e si ferma, e chi invece scorge una possibilità e s’imbarca. Quelli che vedono una possibilità immaginano un’isola, una terra al di là dell’orizzonte.» Secondo Casati, che ha sperimentato la navigazione oceanica e ha scritto Oceano. Una navigazione filosofica (Einaudi, 2022), questa distinzione tra sedentari e avventurieri ha probabilmente origini antiche, e si sovrappone all’opposizione tra comportamenti filopatrici e disperdenti. I primi per riprodursi ritornano al nido – sempre che si siano spostati. I secondi vanno sistematicamente altrove per riprodursi; in parte per gusto del rischio, in parte per alleggerire la pressione della sovrappopolazione sulla terra di origine. Partire verso il mare aperto, senza conoscere che cosa ci aspetta, vuol dire accettare il rischio di naufragare. Andare verso l’ignoto significa accettare di fallire, perdere certezze. Si tratta, dicono gli studiosi, anche di una ragione genetica. Gli intraprendenti sono una specie umana che tiene vivo il gene dell’avventura. «Se sono stati selezionati gli intraprendenti, è proprio perché il mare resta un luogo inabitabile, profondamente disumano.»
Eppure la vastità e la pericolosità del mare non hanno impedito ad alcuni intraprendenti di partire con imbarcazioni di fortuna per affrontare traversate impensabili. Ancora oggi succede in Mediterraneo centrale, con esiti spesso disastrosi. In passato l’intera Polinesia è stata colonizzata da popolazioni che venivano presumibilmente dal Sudest asiatico su delle piroghe a bilanciere e navigavano senza carte nautiche né sestanti – senza, cioè, quegli strumenti che gli europei consideravano allora indispensabili (come ancora oggi, per la verità). Sono esistiti «popoli del mare», tribù oceaniche: i polinesiani, appunto, o anche i portoghesi, esploratori per eccellenza. Oggi sopravvivono sparute popolazioni nomadi come i moken in Birmania o i baju polinesiani. Questi gitans de la mer vivono in house boats o in palafitte, pescano a mani nude e conoscono talmente bene il linguaggio del mare da essere riusciti a sfuggire allo tsunami del 2004.

Un rimorchiatore nel porto di Göteborg, in Svezia, è sovrastato dall’immensa stazza della Mary Maersk che si prepara a salpare per Bremerhaven, in Germania (Andrew Testa per il New York Times)
Tuttavia si può azzardare che oggi il «popolo del mare» sia un altro. Accomunate non da una nazionalità, ma da una scelta, sono quelle persone che hanno lasciato la terraferma per vivere una vita frugale in barca a vela. Sono circa tremila le barche a vela che attraversano l’Oceano Atlantico o il Pacifico ogni anno. Una scelta non certo dettata dalla necessità, ma nemmeno esclusivamente per privilegiati: si tratta talvolta di persone che hanno fatto dell’oceano la loro professione o della barca il loro ufficio galleggiante, talvolta di gente che vive semplicemente a bordo, magari lavorando su barche altrui o nei cantieri nautici. La loro è una vita essenziale, attenta ai consumi, a basso impatto ambientale. Producono pochi rifiuti, riciclano l’acqua del mare per lavarsi e cucinare, per le loro necessità usano l’energia cinetica dell’acqua, quella solare o l’eolica, e naturalmente la forza del vento per spostarsi. Sono tra gli ultimi anticonsumisti del pianeta, o meglio: spenderebbero migliaia di euro in una vela o in sartiame, ma difficilmente compreranno indumenti o scarpe, che tanto non userebbero, né altri oggetti superflui. Hanno imparato a fare il pane, i formaggi, i salumi, le conserve. Ma più di ogni altra cosa queste persone parlano una lingua condivisa, quella della «comunità indigena» dell’oceano. Sono persone normali, con mestieri ordinari, quasi mai hanno lasciato a casa patrimoni, ma spesso hanno rinunciato a mestieri sicuri per una vita meno comoda e più rischiosa. E lo hanno fatto perché hanno intravisto la speranza di un’esistenza migliore: la «possibilità di un’isola».
Sono stata abbastanza in giro per mare da incontrare alcuni di questi vagabondi dell’oceano. Ogni volta ne ho invidiato l’audacia di compiere scelte drastiche, ho ammirato la loro coerenza esistenziale più ancora che le loro doti marinare o performance nautiche. Il coraggio della scelta «intraprendente» devi averlo innato, addirittura genetico, come si è visto, il resto s’impara. Ho conosciuto donne e uomini che hanno lasciato un lavoro, una casa, un gatto, una vita per trasferirsi su una barca umida e, per quanto comoda, mai comoda come un’abitazione. Persone a cui interessa vivere più che esistere, «liberarsi dalla piatta banalità del quotidiano», per usare le parole famosissime di Jack London.

La barca Maistracc di Andrea Pestarini e Chicca Bono in Antartide (Andrea Pestarini e Chicca Bono)
Nel 1912 Jack London scrive un articolo intitolato «The joy of small boat sailing» («Le gioie della navigazione con una piccola barca»), pubblicato in Inghilterra sulla rivista Yachting monthly, dove esalta la bontà della scelta di partire in barca a vela. «Senz’altro si andrà incontro a rischi e disavventure» scriveva. «Ma ricordatevi che gli incidenti domestici non sono meno numerosi di quelli che si verificano sull’acqua. Uccidono più ragazzini le case surriscaldate che le barche, piccole o grandi che siano.» L’anno prima London aveva pubblicato La crociera dello Snark, il resoconto, modernissimo e ricco di humour, della sua traversata del Pacifico a bordo dello Snark, un 43 piedi (13 metri) autocostruito. I capitoli iniziali del reportage sono dedicati alla costruzione e a varie riflessioni su quello che sarebbe dovuto essere un viaggio di sette anni, poi interrotto prima del tempo a causa della rara malattia tropicale che colpì London e lo costrinse a tornare in California. Lo scrittore, all’apice del successo editoriale, avrebbe potuto intraprendere un viaggio più confortevole, avrebbe potuto imbarcarsi con un marinaio, invece sceglie una piccola barca senza equipaggio. Il motivo è semplice: «È bello cavalcare la tempesta e sentirsi divino.» Perché avventurarsi nei mari, nei venti e nelle onde di tutto il mondo? Perché affrontare questo «ambiente feroce»? «Mi piace. Sono fatto così. È la mia particolare forma di vanità, questo è tutto» conclude London.




