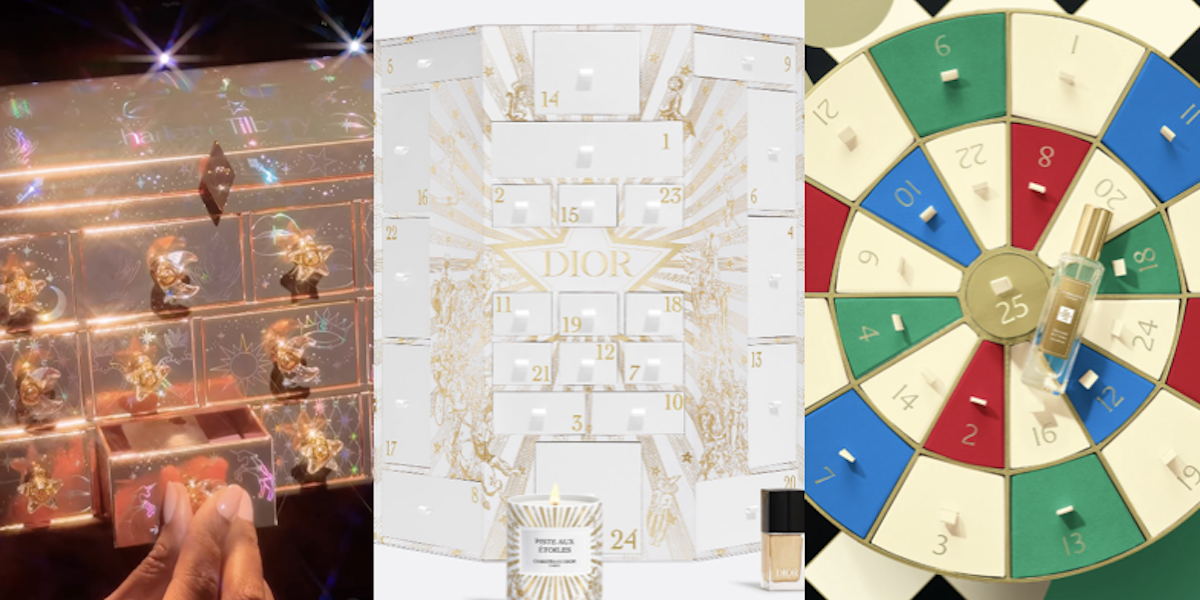Il problema della filantropia
Non è la beneficenza in sé ma le relazioni di subordinazione che tende a instaurare, indebolendo le istituzioni democratiche, scrive il New Yorker

Nel De Beneficiis, un trattato politico realizzato intorno al 62 d.C. ai tempi della Roma neroniana, il filosofo Lucio Anneo Seneca rifletté sulle implicazioni sociali della filantropia e sui rapporti tra coloro che elargiscono un bene e coloro che ne beneficiano. Descrivendo la beneficenza come una pratica che esige un difficile equilibrio tra le parti, Seneca chiarì da subito i rischi sempre presenti dell’utilitarismo e dell’ingratitudine. Come scrisse nel primo dei sette libri di cui si compone il trattato, «quasi niente è più indegno del non saper donare né saper ricevere doni» e «non è facile dire cosa sia più ignobile fra il negare un beneficio o richiederlo in cambio».
Molte delle questioni poste dalla beneficenza sul piano etico, politico e sociale e discusse da Seneca quasi duemila anni fa sono ancora oggi valide e sono alla base di una serie di problemi non soltanto teorici ma anche pratici e normativi. Chi intenda donare un bene deve decidere, per esempio, a chi destinarlo – se a un’altra persona, a un gruppo di persone o alla comunità – e anche l’entità e la natura del dono, attributi che influiranno probabilmente anche su una certa aspettativa di ricompensa. I destinatari di quel bene dovranno a loro volta decidere se e come accettarlo, a quali condizioni, e quali atteggiamenti assumere successivamente nei confronti del benefattore. E la comunità dovrà intanto decidere se e come regolare gli scambi di benefici tra i suoi membri.
In un recente articolo intitolato “Il mondo sarebbe migliore senza filantropi?” il New Yorker si è chiesto se la filantropia, in contraddizione con i nobili scopi morali che il più delle volte esprime e promuove, non finisca per interagire in modo dannoso con le istituzioni democratiche e le relazioni sociali egualitarie. Se, in altre parole, gli autori di cospicue donazioni ricorrenti non esercitino un qualche forma di potere e di influenza sulle persone destinatarie di quelle donazioni e gli istituti incaricati di gestirle, perpetuando disuguaglianze sociali anziché ridurle.
La filantropia – che deriva da una parola greca, philàntropos, e significa letteralmente amore per l’umanità – è molto spesso intesa in termini positivi, come una faccenda che riguarda persone ricche e generose che fanno donazioni a enti e istituti che sostengono cause nobili (contrastare gli effetti del cambiamento climatico, per esempio). Nella peggiore delle ipotesi è invece intesa come un modo per le persone ricche di migliorare la propria reputazione pubblica o sostenere indirettamente i propri interessi. Sia in un caso che nell’altro, la questione è definita sostanzialmente in termini di qualità morali del donatore.
Ma nel concreto, scrive il New Yorker, più che una questione di moralità la filantropia è molto più spesso una questione di interazioni quotidiane e trattative tra i filantropi e gli istituti che dipendono da quelle donazioni, come università, enti di beneficenza e musei. E l’oggetto della trattativa riguarda lo scopo e il controllo delle donazioni, la forma di credito concesso, le condizioni contrattuali dettate dal donatore affinché la donazione si realizzi.
L’Università di Yale, uno degli atenei privati più importanti e ambiti degli Stati Uniti, ha recentemente istituito un comitato interno che si occupi delle relazioni dell’università con i propri donatori. La decisione è stata presa dopo che una docente di storia si era dimessa lo scorso anno in segno di protesta contro quello che aveva descritto come un tentativo di condizionare i programmi universitari e l’assunzione dei docenti da parte di due importanti donatori, uno dei quali aveva versato 500 milioni di dollari, la più grande donazione nella storia di Yale.
– Leggi anche: Quella di Zuckerberg è beneficenza?
Posta in questi termini, la filantropia è un fenomeno tipicamente americano. Senza contare il tempo e il lavoro, l’insieme delle donazioni fatte negli Stati Uniti nel 2020 superava 470 miliardi di dollari: più di qualsiasi altro paese al mondo, in parte perché gli Stati Uniti sono «più favorevoli al mercato rispetto alla maggior parte dei paesi ricchi» e hanno «più ricchezza privata e meno disposizioni governative», fa notare il New Yorker. Ed è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni forme molto diverse rispetto al passato, quando le donazioni di diversi fondatori di grandi società industriali furono determinanti per la creazione di ospedali, università e musei.
Quello che si è mantenuto nel tempo, scrive il New Yorker, è una certa relazione stabile tra la politica e le ricchezze private. Le persone ricche dipendono da condizioni politiche favorevoli che permettono loro di costruire e mantenere la loro ricchezza, e i grandi filantropi utilizzano parte di quelle ricchezze per influenzare le azioni del governo molto più di quanto riuscirebbero a fare soltanto attraverso il voto al momento delle elezioni. Possono per esempio creare associazioni che promuovono determinate politiche che loro approvano, e possono anche impiegare risorse pubbliche.
Le charter school – un tipo di scuole americane, soprattutto primarie e secondarie, finanziate sia attraverso fondi pubblici che privati e dotate di uno statuto di maggiore autonomia rispetto a quelle pubbliche – sono un citato esempio di filantropia in grado di creare un’alternativa su larga scala a un asset, il sistema scolastico, tipicamente sostenuto dai contribuenti. E un altro esempio è la Schmidt Futures, la fondazione di beneficenza istituita dall’ex CEO di Google Eric Schmidt, che ha pagato gli stipendi di un certo numero di dipendenti presenti e passati dell’Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche, un organo del governo americano che fornisce consulenza al presidente in merito all’impatto della scienza e della tecnologia sulle politiche interne e su quelle internazionali.
Come raccontato dal giornalista britannico e laico della diocesi anglicana di Manchester Paul Vallely nel libro Philanthropy: From Aristotle to Zuckerberg, la divisione dei compiti tra il governo e la filantropia e la corretta gestione delle donazioni pongono questioni secolari. Ma l’avvento della «grande filantropia», in larga parte supervisionata dal personale salariato delle fondazioni, ha ampliato la scala di quelle questioni e reso più problematiche le ripercussioni della filantropia, man mano che i filantropi si facevano carico di compiti tradizionalmente associati ai governi.
– Leggi anche: Che cos’è la “Lotteria Filantropica”
«Le fondazioni non devono rendere conto a nessuno, né politicamente né in termini di disciplina di mercato: sono rette da amministratori fiduciari eletti non dal pubblico ma da amministratori già esistenti», scrive Vallely, segnalando quanto siano «in questo senso profondamente antidemocratiche». Attraverso le fondazioni i filantropi non si limitano a distribuire le loro donazioni, magari all’interno degli stessi gruppi di beneficiari di anno in anno: stabiliscono invece priorità, fanno dichiarazioni di intenti e assumono impegni finanziari limitati nel tempo che hanno poi un impatto concreto.
Vallely la definisce «filantropia strategica», una beneficenza che pone problemi relativi alla volontà e alle capacità dei filantropi di esercitare un’influenza sulle trasformazioni della società. E parla invece di «filantropia reciproca» per riferirsi a un altro tipo di complicazioni: quelle, in parte descritte anche da Seneca, che la filantropia determina nelle relazioni di subordinazione tra donatore e beneficiario.
Secondo i principi definiti da Seneca nel De Beneficiis, il criterio che dovrebbe in generale regolare nella società il comportamento e le relazioni tra le persone in merito alla questione del dare e ricevere un beneficio è la voluntas, una virtù descritta come l’intenzione di arrecare un beneficio ad altre persone ricavandone piacere e riconoscenza. Virtù che non dipende dallo status giuridico né dalla fortuna di una persona: chiunque può arrecare un beneficio, se dotato della giusta voluntas.
La virtù alla base del beneficio – inteso come atto di generosità spontanea, «quel genere di credito dal quale bisogna recuperare tanto quanto viene restituito spontaneamente», quindi diverso dal prestito – è anzi, secondo Seneca, proprio ciò «che lega nel modo più saldo la società umana» perché suscita in chi lo riceve un sentimento di riconoscenza. Riconoscenza che si traduce nella disponibilità ad aiutare il benefattore non appena si presenti l’occasione per farlo, e che instaura un circolo virtuoso in grado di estendersi a ogni livello della società.
Nella società imperiale romana, l’esempio concreto posto da Seneca, il sovrano può arrecare un beneficio ai suoi sudditi ottenendone in cambio riconoscenza, obbedienza e solidarietà. Ma questi sentimenti e i comportamenti che ne derivano vincolano a loro volta il donatore al suo ruolo di sovrano buono e giusto.
Le gerarchie su cui si fonda la società imperiale e che in larga parte dipendono dai casi della fortuna, secondo Seneca, dovrebbero sempre essere considerate da chi si trova in posizioni di potere un’occasione di arrecare un beneficio. E dato che al beneficio è legato il sentimento della gratitudine – e i comportamenti che ne conseguono – non c’è di fatto alcuna condizione sociale che non sia un’occasione di arrecare un beneficio. Né può essere soltanto inteso come un servizio, secondo Seneca, ciò che lo schiavo fa nei confronti del padrone quando supera i limiti di ciò che le leggi impongono di fare, a volte anche a costo della vita stessa: «qualsiasi azione vada oltre la norma del dovere, ciò che si fa non in seguito a un comando ma spontaneamente è un beneficio».
– Leggi anche: Qual è il modo migliore per dare in beneficenza 8 miliardi di euro?
Nei contesti contemporanei e democratici, secondo la ricercatrice americana Emma Saunders-Hastings, docente di scienze politiche alla Ohio State University e autrice del libro Private Virtues, Public Vices: Philanthropy and Democratic Equality, tutte le forme di filantropia che mettono i donatori nella condizione di poter esercitare una smisurata influenza politica e personale possono invece generare una «disuguaglianza relazionale» in grado di indebolire le istituzioni democratiche stesse.
In molti casi, afferma Saunders-Hastings, i filantropi finiscono per controllare il comportamento dei beneficiari delle loro donazioni, e in merito a ciò che è nel loro interesse presumono di avere un’idea migliore di quella dei beneficiari stessi. E non è soltanto una questione di importo e frequenza delle donazioni: anche singole donazioni specifiche possono portare a successive espressioni di gratitudine in cui sono presenti sfumature di inferiorità sociale.
In opposizione rispetto alla filantropia, descritta come «l’usurpazione da parte di una persona ricca del controllo sulla vita pubblica e sulle questioni di interesse pubblico», Saunders-Hastings descrive la democrazia come una condizione di gran lunga preferibile: «la manifestazione politica del rispetto per lo status delle persone come uguali». In un certo senso, prosegue, le donazioni dei filantropi non sono significativamente diverse dalle donazioni ai comitati di azione politica o ad altre organizzazioni analoghe: «sono entrambi modi delle persone ricche di utilizzare i propri soldi per influenzare risultati sociali e politici».
Uno degli argomenti più utilizzati dai sostenitori della filantropia e alla base di una lunga tradizione di organizzazioni di beneficenza della società civile è che questo approccio favorisca riforme sociali più difficili da raggiungere attraverso l’approccio governativo. Ma nel contesto attuale, osserva Saunders-Hastings, le donazioni filantropiche non derivano dalla società civile ma da persone smisuratamente ricche, peraltro in un contesto di maggiore disuguaglianza sociale rispetto al passato. Ed è un fatto discutibile, scrive, che «le cose che sono dovute ai beneficiari per ragioni di giustizia siano fornite (esclusivamente) attraverso la beneficenza discrezionale piuttosto che attraverso i diritti politici».
– Leggi anche: Qualcuno nella Chiesa cattolica vuole cambiare modo di fare beneficenza
Saunders-Hastings ritiene che, se l’obiettivo è raggiungere ciò che lei definisce un «egualitarismo relazionale», continuare ad acquistare altri yacht, ville e beni di lusso sarebbe da parte delle persone ricche un’azione moralmente preferibile rispetto alla filantropia. Sarebbe meno paternalistico, e alla lunga potrebbe peraltro declassare dallo status di miliardarie a quello di milionarie le persone che spendono nell’acquisto di quei beni.
Il New Yorker si chiede tuttavia se sia possibile dedurre una serie di principi generali per una filantropia moralmente accettabile e che non comporti i rischi descritti da Saunders-Hastings. Da questo punto di vista, scrive, «la piccola filantropia è meglio della grande filantropia perché non provoca le stesse disparità di potere». La raccolta delle offerte in chiesa o le donazioni alle organizzazioni laiche locali, per esempio, comportano probabilmente meno rischi. Così come è preferibile fare donazioni in forma anonima e senza vincolarle ad alcuna condizione.
Parlando dell’infanzia dello scrittore rumeno di origine ebraica Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto e premio Nobel per la pace nel 1986, Saunders-Hastings cita un’usanza del villaggio in cui Wiesel crebbe. Durante la Pasqua ebraica (Pesach) le persone in grado di farlo lasciavano in forma anonima una somma di denaro in un piatto a disposizione del villaggio, da cui le persone bisognose potevano attingere in qualsiasi momento.
Nella prospettiva assunta da Saunders-Hastings sarebbe infine preferibile la filantropia che non interviene in attività che dovrebbero essere finanziate da un governo democratico. Per contrastare la povertà, per esempio, i programmi finanziati attraverso fondi pubblici sono preferibili rispetto alla carità. E non importa quanto inadatto sia quello sforzo pubblico o quanto un governo sia lontano dal tutelare «l’obiettivo democratico di garantire che i cittadini condividano continuativamente la decisione dei risultati sociali e politici che li riguardano», scrive Saunders-Hastings. L’importante è che non sia apertamente consentito alle persone ricche di decidere le politiche.
– Leggi anche: Che fine farà la fondazione di Bill e Melinda Gates
Quello che i più accaniti critici della filantropia sembrano tuttavia sottovalutare, conclude il New Yorker, è che nel mondo reale la filantropia finisce spesso per rispondere in concreto a bisogni che non dovrebbero esistere. Le donazioni dell’imprenditore e filantropo statunitense di origine scozzese Andrew Carnegie, uno dei più influenti industriali della storia americana, furono fondamentali per la costruzione di quasi duemila biblioteche. Così come la Gates Foundation di Bill e Melinda Gates, considerata oggi una delle più ricche e influenti fondazioni private al mondo, ha finanziato la ricerca e le misure di salute pubblica per contrastare le malattie tropicali perché, ricorda il New Yorker, «queste cose erano scandalosamente sottofinanziate».
Quanto alla critica riguardo al paternalismo, non è detto che quel paternalismo denunciato nella filantropia non si manifesti su scala molto più ampia anche nei programmi dei governi. «Forse è perché il pubblico votante ha le sue inclinazioni paternalistiche», scrive il New Yorker, citando come esempio il caso in cui i governi stanziano contributi straordinari per determinate categorie di persone ma impediscono che quei contributi possano essere utilizzati per acquistare prodotti come sigarette e alcolici.