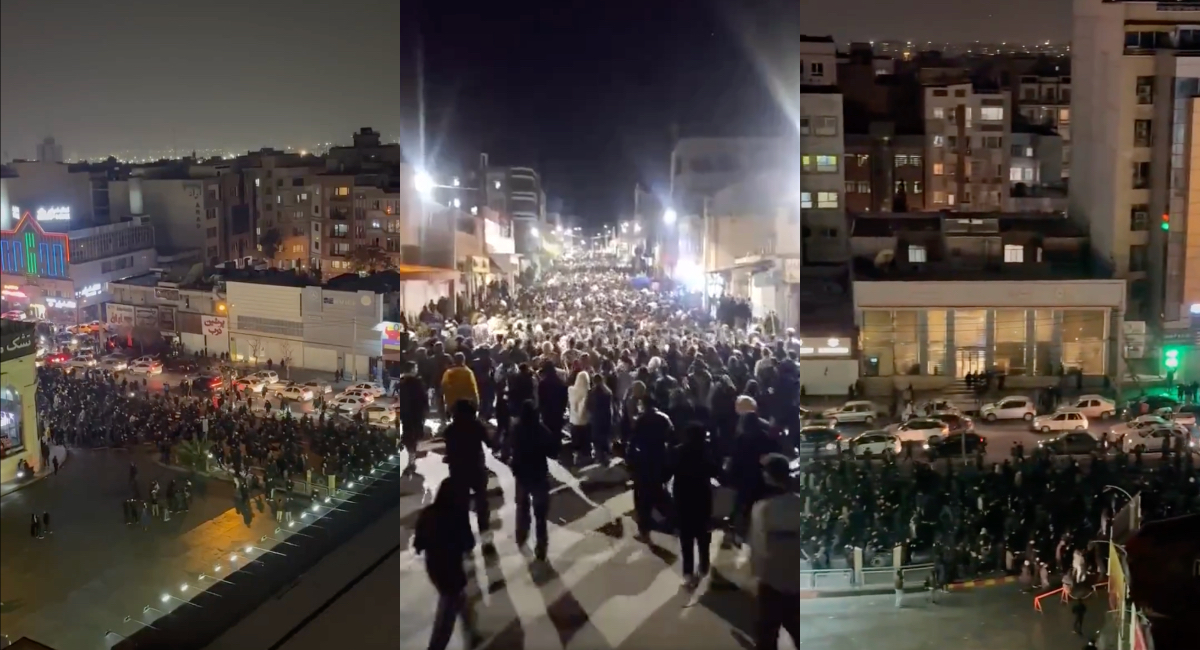Una nuova inchiesta sui centri in cui vengono detenuti gli uiguri
14 giornali internazionali hanno pubblicato il contenuto di migliaia di documenti riservati della polizia cinese, con foto e resoconti

Migliaia di documenti della polizia cinese della regione dello Xinjiang sono stati consegnati a un ricercatore tedesco, verificati e pubblicati oggi da quattordici giornali internazionali. L’inchiesta è stata chiamata “Xinjiang Police Files” e descrive, dall’interno, l’organizzazione dei cosiddetti «centri di rieducazione e formazione» che diverse inchieste giornalistiche, testimonianze e rapporti dell’ONU hanno rivelato essere campi di prigionia dove sono detenuti migliaia di uiguri, la minoranza cinese turcofona prevalentemente musulmana. Il governo cinese ha sempre negato la repressione sistematica contro gli uiguri, giustificandola come una campagna antiterroristica e negando l’esistenza stessa di programmi di detenzione di massa.
Gli Xinjiang Police Files sono stati consegnati all’antropologo tedesco Adrian Zenz, già autore di diverse ricerche sulla persecuzione degli uiguri, da una fonte che non ha posto condizioni per la loro pubblicazione. I file sono stati verificati per diversi mesi e poi pubblicati tra gli altri da Der Spiegel, BBC, Le Monde, El País e, in Italia, dall’Espresso. I documenti vanno dal 2000 al 2018 e sono estratti dagli archivi informatici delle forze di sicurezza di due prefetture della regione autonoma dello Xinjiang: Konasheher e Tekes.
I file comprendono, tra le altre cose, 452 registri contenenti più di 20 mila nomi di persone tenute sotto stretta sorveglianza: ad ognuna di loro è associato un numero con un codice identificativo e per gli internati nei centri di detenzione viene specificata la durata della detenzione e il tipo di accusa. I documenti permettono di giudicare l’arbitrarietà dei motivi dell’arresto, che molto spesso si basano su vaghi riferimenti all’appartenenza religiosa. In uno si dice, ad esempio: «Ha iniziato a farsi crescere la barba lunga nel 2014. Si è rifiutato di raderla quando gli è stato chiesto dall’ufficiale del comitato del villaggio. Famiglia con una forte appartenenza religiosa». Oppure: «Ha indossato il velo dal 2012 al 2013. Marito condannato a 11 anni di carcere. Nel 2014 ha violato le regole della pianificazione familiare e ha avuto più di un figlio».
I file contengono inoltre circa 5 mila foto scattate tra gennaio e luglio 2018 a Konasheher. Tra le 2.884 persone registrate come detenute il più giovane ha 15 anni e il più vecchio 73. In base a questa documentazione, spiega L’Espresso, «i cronisti sono riusciti a raggiungere alcune famiglie di uiguri emigrate all’estero, che hanno riconosciuto le foto dei loro parenti e confermato il loro arresto. O la loro sparizione, seguita dalla totale mancanza di notizie ufficiali».
La maggior parte dei documenti contiene informazioni sulla struttura dei campi, sull’apparato di sicurezza al loro interno, e sulle modalità della detenzione degli internati o della loro cosiddetta “trasformazione educativa”. «Le immagini evidenziano che si tratta di strutture carcerarie di massima sicurezza sorvegliate da forze militarizzate e mostrano una situazione di detenzione e segregazione, in palese contrasto con le foto diffuse finora dalla propaganda di regime», dice L’Espresso. Si vedono persone in manette, incatenate, incappucciate o circondate da poliziotti. Ci sono foto di persone che ricevono iniezioni in infermeria mentre sono in manette o foto di interrogatori sulle “sedie della tigre”, strutture d’acciaio con sbarre di ferro e manette incorporate per bloccare i detenuti in posizioni dolorose, e considerate dall’ONU come strumento di tortura.
I documenti contengono anche indicazioni su come affrontare i tentativi di evasione o di ribellione: «Se gli studenti non ascoltano le istruzioni, la polizia armata può sparare colpi di avvertimento. Se gli studenti non si arrendono alla dissuasione, se continuano a far aumentare la tensione, se tentano di scappare o se si impossessano delle armi degli ufficiali, questi li uccideranno». Le forze di sicurezza, ma solo quelle di etnia han, quella maggioritaria in Cina, sono armate con mitra e fucili di precisione. Le altre guardie hanno lunghi bastoni di legno, manette e scudi. Si dice che il controllo deve essere particolarmente severo verso coloro che manifestano determinati comportamenti: saranno puniti coloro che «organizzano risse», che «tentano di organizzare i detenuti per uno sciopero della fame collettivo», coloro che «disturbano l’ordine». «Conservare libri religiosi, impegnarsi in attività religiose o manipolare altre persone», si legge ancora, è sanzionato con un mese di isolamento, due in caso di recidiva.
– Leggi anche: Il “genocidio demografico” degli uiguri
Nei centri citati dai documenti si spiega che i detenuti sono sorvegliati con un rapporto di circa un poliziotto ogni dieci e vengono descritte le tattiche da utilizzare nelle varie circostanze, tutte molto violente. Le foto, spiega L’Espresso, mostrano poi che «gli spazi interni sono chiusi con sbarre e recinzioni di ferro, le stanze e i corridoi non hanno finestre, solo lucernari in alto, i cortili sono bloccati da alti muri di cemento, tutto è sorvegliato da squadre di guardie armate».
Una parte dei documenti è dedicata alle telefonate dei detenuti. Si parla dell’installazione di un telefono fisso ogni cinquanta “studenti”, con non più di sei postazioni per piano, possibilmente in una stanza chiusa in cui devono essere presenti almeno due guardie di sicurezza. Le telefonate alle famiglie possono avvenire una volta ogni dieci giorni, e non possono durare più di dieci minuti. L’amministrazione del centro, infine, deve conoscere l’oggetto della conversazione il giorno prima della chiamata.
Gli Xinjiang Police Files dicono che almeno diecimila persone, nei due distretti di Konasheher e Tekes, sono state schedate come pericolose o arrestate utilizzando un programma informatico di sorveglianza di massa che riuscirebbe a prevedere, in base a una serie di parametri, le attività illecite future delle persone. Molto spesso le motivazioni degli arresti si basano sui legami con altri detenuti. Nel fascicolo di Tohti A., 31 anni, arrestato il 3 maggio 2018, ad esempio, si specifica che il fratello della moglie, accusato di terrorismo, era già detenuto. E si segnalano altre quattro persone a lui vicine da tenere sotto sorveglianza. Intere famiglie, dice Le Monde, vengono così internate «semplicemente perché vicine ad un altro detenuto, presunto colpevole o condannato». Nel fascicolo di Qasimjan M., 17 anni, detenuto, si dice che sei membri della sua famiglia sono stati a loro volta internati perché i loro pensieri erano “instabili”.
– Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di genocidio degli uiguri
I giornalisti che hanno collaborato all’inchiesta hanno inviato una serie di domande alle autorità cinesi chiedendo ad esempio quanti centri siano ancora aperti o se sia ancora valido l’ordine di «sparare per uccidere». Il governo cinese, come riporta L’Espresso, ha risposto alle 23.30 di ieri, 23 maggio, alla vigilia della pubblicazione degli articoli, attraverso una nota firmata da Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti. Nella risposta si ribadisce che «i problemi dello Xinjiang riguardano, in sostanza, la lotta al terrorismo, alla radicalizzazione e al separatismo, non i diritti umani o la religione». Si dice poi che lo Xinjiang da diversi anni «non ha più assistito ad alcun caso di violenza terroristica», e che sulla questione sono state diffuse molte notizie false: «La regione dello Xinjiang ora gode di stabilità sociale e armonia, così come di sviluppo economico e prosperità. La popolazione locale sta vivendo una vita sicura, felice e piena di soddisfazioni».