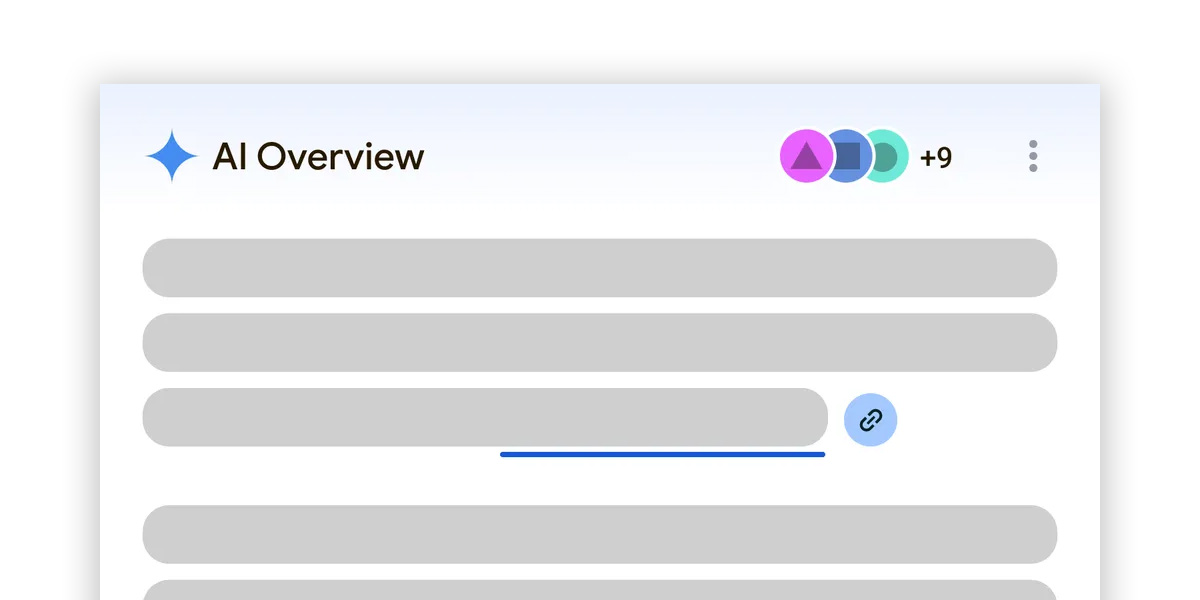A Palermo il pizzo non è solo una questione di paura
In alcune zone c'è una forte contiguità tra vittime e clan mafiosi, e molti pagano gli estorsori per abitudine o per avere servizi

Secondo l’ultimo dato disponibile nella provincia di Palermo, da gennaio a ottobre del 2021, sono state accertate delle forze dell’ordine circa 220 estorsioni. Poche però sono state quelle denunciate dalle vittime. Molte per paura, ma molte altre per convenienza, perché hanno interesse ad avere un appoggio nella cosca mafiosa, o per abitudine. Giuseppe De Liso, comandante provinciale dei Carabinieri, ha detto di aver seguito «115 episodi estorsivi, ma le denunce ricevute sono state solo sette».
A Palermo il fenomeno del pizzo, o come viene detto in gergo mafioso della “messa a posto”, è ancora molto presente anche se negli ultimi vent’anni le operazioni di magistratura e forze dell’ordine hanno colpito pesantemente le organizzazioni mafiose. Non si è tornati indietro agli anni in cui le denunce si contavano, in un anno, sulle dita di una mano: il numero di chi si rivolge a forze dell’ordine e magistratura, con l’aiuto delle associazioni antiracket, è cresciuto.
Ma chi lo fa rimane una minoranza: molti commercianti non denunciano, e anzi spesso anche dopo le operazioni delle forze dell’ordine negano di aver mai pagato. Per molti pagare il pizzo è come un attenersi a un adempimento burocratico che legittima la possibilità di operare sul mercato. Ma, appunto, c’è anche chi paga per convenienza: si rivolge alla cosca mafiosa come se si trattasse di una società di servizi, pagando il pizzo come se fosse un abbonamento a un’entità che risolve i problemi.
Non è una novità, ma solo di recente è una situazione che sta iniziando a essere descritta pubblicamente e con chiarezza. Salvo Caradonna, socio fondatore e avvocato dell’associazione Addiopizzo, spiega che «siamo abituati ai racconti, sulla stampa, di una città dove tutti pagano il pizzo per terrore oppure al contrario dove all’improvviso ci sono rivoluzioni con la rivolta dei commercianti che si ribellano al racket». Questi due fenomeni esistono, ma «ogni zona, ogni periodo, ogni cosca e anche ogni vittima ha la sua peculiarità».
Caradonna dice che «se restiamo ai fatti bisogna dire che non c’è solo chi paga il pizzo perché ha paura, ma anche chi lo fa perché ha interesse a pagarlo, perché così si assicura un servizio da parte dell’organizzazione criminale, oppure perché semplicemente vive e lavora in quella zona da 30 anni e così è stato abituato a fare». Se a un certo punto queste persone rifiutassero il pizzo andrebbero con ogni probabilità incontro a ritorsioni violente: ma non è questo il motivo principale per cui pagano. La storia e le condizioni sociali ed economiche di alcuni quartieri di Palermo hanno reso il pizzo parte del panorama, una tassa a cui è normale adeguarsi.
Nell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo, il presidente della Corte d’appello Matteo Frasca ha spiegato che c’è stato un aumento di denunce di estorsioni ma che «tale incremento, purtroppo si è manifestato a macchia di leopardo: mentre nel mandamento mafioso di Porta Nuova ben 15 imprenditori, soprattutto del settore edile, indicavano compiutamente gli autori dei reati, nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli non una sola vittima di estorsione si è fatta avanti».
Il caso di Brancaccio-Ciaculli, quartiere a sud est del centro, è emblematico. Nel luglio del 2021 16 persone furono arrestate per 50 episodi estorsivi ricostruiti dalle forze dell’ordine. Nessuna vittima però aveva denunciato, e nemmeno confermò in seguito di essere stata colpita da estorsione. Eppure, per qualsiasi esercizio commerciale nella zona, qualsiasi locale o negozio, si doveva pagare il pizzo: supermercati, concessionarie di auto, autodemolitori, bar, farmacie, discoteche, panettieri, imprese edili. Addirittura, dalle intercettazioni telefoniche ordinate dalla magistratura risultò che un commerciante ambulante doveva pagare 5 euro di pizzo per potere sistemare la propria merce in un mercato domenicale.
A gestire le estorsioni era tra gli altri Giuseppe Greco, figlio di Salvatore “il senatore”, a sua volta fratello di Michele Greco, “il papa”, chiamato così per la sua abilità di mediatore tra le varie famiglie mafiose. Fu lui che durante il maxiprocesso del 1986 chiese la parola e disse rivolto alla giuria: «Io desidero fare un augurio. Vi auguro la pace signor presidente, a tutti voi auguro la pace perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza e per il compito che vi aspetta la serenità è la base fondamentale per giudicare». È una famiglia, quella dei Greco, che non si è mai spostata da Brancaccio e che continua ad avere il controllo del territorio. Tra gli estorsori c’era anche Gaspare Sanseverino, nipote di Gaspare Spatuzza, uno dei più famosi pentiti di mafia.
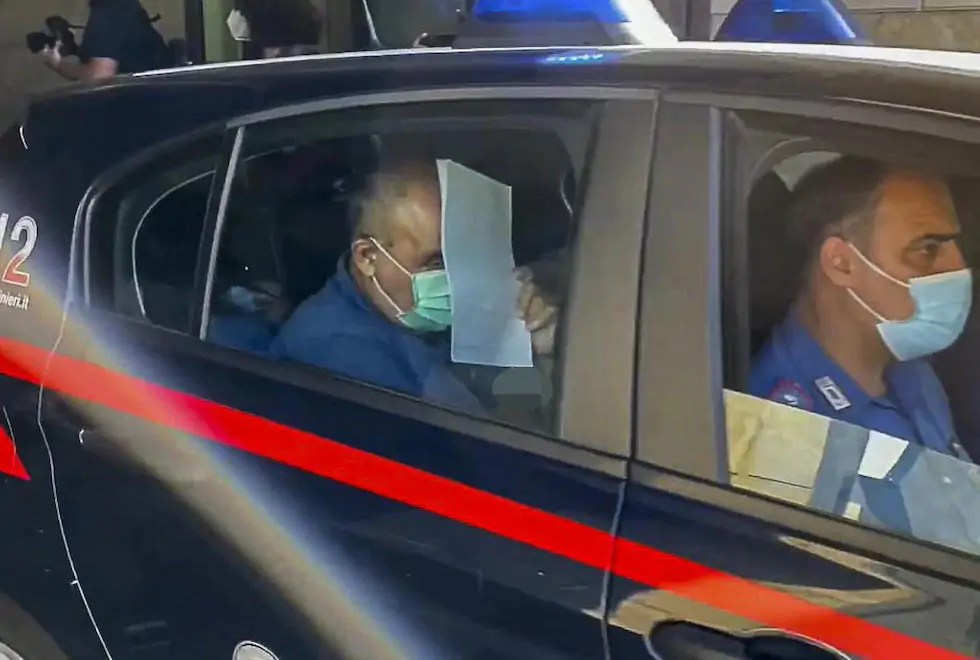
Giuseppe Greco, uno degli arrestati per le estorsioni nel quartiere Brancaccio di Palermo (ANSA / IGOR PETYX)
Gli interrogatori e le intercettazioni dell’operazione effettuata dalle forze dell’ordine nel quartiere Brancaccio spiegano bene alcuni dei motivi che stanno alla base della decisione di non denunciare e di sottomettersi all’ordine mafioso. «È una delle aree», dice Caradonna, «in cui al di là dell’incessante opera di repressione di magistrati e forze dell’ordine e del lavoro di poche realtà sociali e scolastiche, il territorio è caratterizzato da una forte relazione di contiguità culturale ed economica tra vittime ed esattori».
Un commerciante per esempio disse esplicitamente all’estorsore di non aver nessun problema a pagare, bastava però non comparire in quello che chiamava «libro mastro». Un altro commerciante suggerì all’uomo della cosca cosa dire alle forze dell’ordine nel caso lo avessero fermato con i soldi fuori dal negozio. C’è poi il caso dell’ambulante che, in vista di un concerto di un cantante neomelodico nel parcheggio di un centro commerciale, chiese al suo estorsore di fare in modo che un suo concorrente quella sera non fosse presente. Anche il concorrente però pagava il pizzo e questo creò non pochi dilemmi agli uomini della cosca.
C’è chi si affidava ai propri estorsori per recuperare un credito da un’altra persona e chi per impedire che nella sua zona aprisse un negozio concorrente. Molti pagavano perché vivevano in quella zona da 30 anni ed è quello che avevano sempre fatto. «C’è anche il caso del commerciante che pagava il pizzo a suo cognato: l’estorsore era suo parente», dice ancora Salvo Caradonna. «Pensate che ne avesse paura? No, semplicemente è una cosa che andava fatta. Non bisogna pensare sempre che chi paga è un vigliacco che sia terrorizzato. Le situazioni sono diverse, di volta in volta». Caradonna fa l’esempio di «un imprenditore edile che arriva in una zona per un lavoro e però non vive lì, magari non è nemmeno di Palermo, denuncerà più facilmente di un panettiere che vive da sempre in un quartiere e per sempre ci vivrà».
Dalle intercettazioni durante le indagini svolte a Brancaccio, ha spiegato il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, «è emerso un quadro inquietante dove addirittura l’estorto viveva la sua condizione come fosse affetto dalla “Sindrome di Stoccolma”. La vittima vedeva il suo estorsore come il necessario percorso per giustificare l’esborso delle somme richieste».
Dalle indagini sulle estorsioni nella zona di Brancaccio è emersa anche la difficoltà per il clan, durante il lockdown, di esercitare il lavoro di riscossione. Questo comportò di conseguenza un problema con le famiglie dei mafiosi in carcere, a cui la cosca assicura un sostegno mensile. Lo spiegò il questore di Laricchia illustrando i risultati dell’operazione: «Dovevano giustificarsi con i parenti dei detenuti e affrontare le minacce delle mogli che dicevano “se non arrivano i soldi sapete cosa ci resta da fare”, alludendo alla possibilità che i familiari si pentissero».
Santo Lo Bocchiaro, un artigiano che aprì quattro anni fa un laboratorio di restauro a Brancaccio, raccontò di essere stato avvicinato poco dopo l’apertura della sua attività da un uomo dei clan che gli disse: «Perché si trova qua? Chi le ha detto di venire?». Poi l’uomo aggiunse: «secondo lei è giusto che i carcerati non abbiano neanche una cassata per le feste?». Lo Bocchiaro si rifiutò di pagare, e poco dopo ricevette una busta con due proiettili. Denunciò e i suoi estorsori vennero arrestati. Chiuse comunque l’attività e andò via da Palermo, in cerca di un lavoro: «Ancora oggi aspetto che lo stato mi dia il primo risarcimento stabilito dai giudici due anni fa» ha detto a Repubblica.
Durante il lockdown conseguente alla pandemia le cosche si sono comportate in maniera molto diversa l’una dall’altra. In alcuni mandamenti (le zone controllate da una famiglia o da una alleanza di famiglie mafiose) gli estorsori hanno continuato a esigere pagamenti regolari, nonostante le difficoltà dei commercianti. In altre zone invece il clan mafioso ha assunto l’aspetto di una società di mutuo soccorso. Ne ha parlato Annapaola Porzio, a capo dell’ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che presentando la relazione annuale 2020 ha descritto l’esistenza di un «welfare mafioso di prossimità, ovvero quel sostegno attivo alle famiglie degli esercenti di attività commerciali e imprenditoriali in difficoltà o in crisi di liquidità».
Alcuni clan hanno attinto alla loro enorme disponibilità economica per aiutare imprese, locali ed esercizi commerciali in difficoltà e senza chiedere niente in cambio, ma con l’obiettivo poi di subentrare o di avere un ruolo in quell’azienda o in quell’attività. Secondo Annapaola Porzio, questo «ha determinato un’impennata del livello reputazionale delle conventicole criminali foriera di gravi conseguenze per il futuro». La mafia, in pratica, ha cercato consenso ed è riuscita a ottenerlo.
Non è sempre così. Accade anche che molti commercianti riescano a unirsi e, con l’aiuto delle associazioni antiracket, decidano di denunciare. Avvenne nel 2016 quando un gruppo di commercianti di via Maqueda, in maggioranza bengalesi ma anche di altri paesi, denunciò soprusi ed estorsioni da parte di un clan composto da nuove leve della mafia. I commercianti erano sottoposti a minacce e violenze se esitavano a pagare. Yusupha Susso, un giovane gambiano che reagì a un atto di sopraffazione, venne ferito con un colpo d’arma da fuoco alla testa.
Arrivò quindi la reazione dei commercianti e fu la prima volta che un caso di denuncia collettiva coinvolse un gruppo di persone immigrate. Vennero arrestate e rinviate a giudizio nove persone. «È stato un episodio importante», dice Caradonna, «ma senza attendere ribellioni collettive di questo tipo, va comunque registrato che le denunce contro il racket sono costanti, non ancora tante come sarebbe auspicabile però ci sono».
Certamente la situazione è molto cambiata da quando Libero Grassi, il 10 gennaio 1991, pubblicò sul Giornale di Sicilia la lettera aperta ai suoi estorsori. Cominciava così:
«Volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. (…) Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al “Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui».
Libero Grassi venne ucciso sette mesi dopo, il 29 agosto 1991. Dopo la sua morte divennero sempre più numerose e più forti le associazioni antiracket. Dal canto loro i clan mafiosi hanno continuato a imporre il pizzo in ogni zona della città, pur subendo colpi durissimi dagli arresti e dalle condanne, mantenendo vivo quello che, dopo lo spaccio di droga, è storicamente il loro ramo d’attività più redditizio.