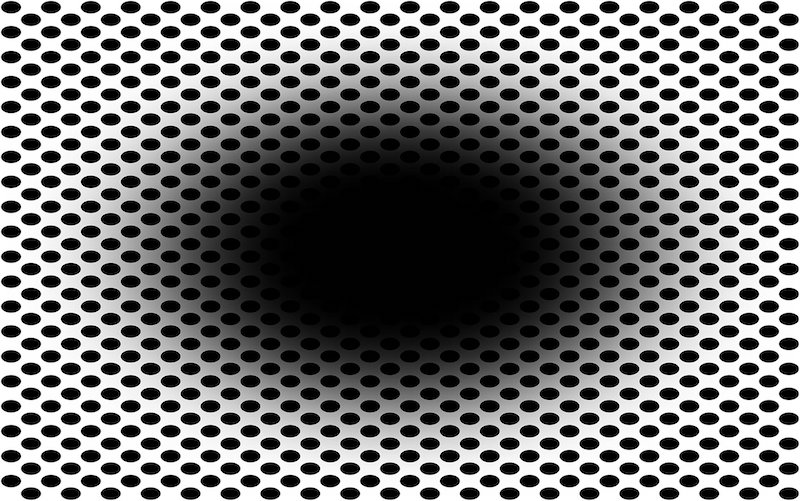Nel packaging c’è di tutto
È fondamentale, nel suo tenere insieme tantissime cose, ma ci facciamo caso solo quando non va

Sebbene non lo si consumi, da ormai diversi decenni il packaging è parte integrante del consumismo, e di conseguenza del nostro stile di vita. Scatole, bottiglie, sacchetti, buste e contenitori vari in vetro, latta, plastica, carta, cartone, alluminio o cellophane determinano e influenzano il modo in cui prodotti di ogni tipo sono creati, distribuiti, venduti e usati. Un buon packaging deve tenere insieme tantissime cose, in molti casi una l’opposta dell’altra: sostenibilità e riconoscibilità, attrazione verso i clienti e sicurezza per i bambini, praticità nel trasporto e riconoscibilità sugli scaffali, usabilità e sicurezza, chimica e design, richieste di marketing e necessità pratiche, esigenze delle aziende e desideri dei consumatori.
Il packaging, ha scritto Thomas Hine in Total Package, «pervade le nostre vite quotidiane e sta in ogni nicchia e in ogni anfratto delle case e dei luoghi di lavoro, eppure riesce a volare al di sotto del radar analitico di molti di noi». Tanto che «ci facciamo caso quando qualcosa non va, quando non riusciamo ad aprire qualcosa». Non è però solo un problema dei consumatori: come ha scritto il Wall Street Journal, anche da parte delle aziende il packaging risulta spesso essere «un aspetto trascurato, talvolta perfino un pigro pensiero secondario» riservato a qualcosa che, in effetti, è perlopiù destinato a finire nella pattumiera. Si compra il contenuto, il contenitore serve solo a promuoverlo e proteggerlo.
Per chi se lo trova tra le mani, il packaging è un problema quando non si apre – magari sotto la doccia mentre si è bagnati e insaponati – e quando nel tentativo di aprirlo ci si taglia e si finisce al pronto soccorso. Quando dovrebbe richiudersi dopo un uso e prima di un altro, e invece non lo fa. Quando non sembra esserci modo di alloggiarlo comodamente in un frigorifero, sopra una mensola o dentro una credenza. Oppure in quelle situazioni in cui il contenuto dovrebbe uscire e non lo fa, o al contrario esce quando non dovrebbe. Per esempio, ogni volta che c’è ancora dentifricio ma non sembra esserci modo di farlo uscire dal tubetto, quando i pretagli non funzionano o le linguette delle lattine di tonno si rompono. O ancora, più semplicemente, quando è efficace nel farsi notare e comprare ma poi, nel momento del bisogno, si rivela poco pratico nel dichiarare, per fare un esempio ben noto, quanto accidenti ci vuole per far cuocere uno specifico formato di pasta o un determinato tipo di riso.
Quasi mai un consumatore fa invece caso ad accorgimenti e tecnologie che, per esempio, stanno nei molti strati (a volte fino a sette) di un sacchetto di patatine, e a come sono funzionali a prevenire l’irrancidimento dell’olio, o la perdita di fragranza e croccantezza, o a quanto l’aria nei sacchetti serva a proteggere quelle patatine dagli urti. O a quanto possa essere complesso pensare a forma e grandezza di certi flaconi sapendo che però possono variare di molto le dimensioni delle mani che si troveranno a usarli.
Per chi lo produce, trasporta, inscatola o inscaffala, il packaging è un problema quando non si fa notare e quindi vendere, quando non assolve alla sua funzione primaria di preservare il contenuto da luce, calore o pressione, o in tutti quei contesti in cui risulta poco efficiente accumulare confezioni in un camion o dentro un supermercato.
Così come quello che contiene, ha scritto il Wall Street Journal, anche il packaging «è un esercizio di equilibrismo» tra creatività, usabilità e sostenibilità. Il guaio, però, è che spesso «ognuno di questi attributi si raggiunge a scapito degli altri». Da qualche anno, in particolare da quando è iniziata la pandemia, a tutto questo si aggiungono «le complicazioni dovute al fatto che molti prodotti devono ormai essere adatti a canali di vendita diversi, ognuno con le sue necessità, i suoi modi e i suoi tempi».
– Leggi anche: La crisi dei commerci mondiali, spiegata
Una prima ragione per cui in certi casi il packaging risulta inadatto ai suoi scopi sta nell’urgenza con cui è pensato e realizzato. Succede infatti che prima si pensi al contenuto e solo in un secondo momento, magari con tempi strettissimi e risorse piuttosto scarse, al contenitore. Anziché testare il prodotto sul campo e capire insieme ai consumatori cosa non funziona, può capitare per esempio che ci si limiti a test fatti nei laboratori o da dipendenti, senza gli ostacoli e le complicazioni della vita vera.
In altri casi, il produttore può essere ben cosciente di determinati limiti, ma sceglie comunque di non investirci tempo o risorse. Gianluca Diegoli, esperto di marketing e autore del libro Svuota il carrello, spiega che «spesso, per certi beni, il costo del packaging è molto rilevante rispetto al prezzo di vendita», sicché «basta anche pochissima variazione nel costo del packaging per modificare di un bel po’ il bilancio del prodotto». Ci sono casi in cui, grazie a margini estremamente alti, si può puntare molto su packaging e sull’effetto-wow dell’unboxing (come fa Apple, dalle cui confezioni «sembra quasi che l’aria esca piano»), altri in cui «la coperta è corta» e, molto semplicemente, «l’azienda deve tenere tutto insieme facendo quadrare i conti».
Sempre Diegoli parla poi della necessità di sottostare a determinate economie di scala: «pensiamo sempre che il packaging sia creato all’interno dell’azienda, ma spesso non è così e chi fa le confezioni per lo shampoo, le fa un po’ per tutti, grazie a catene di montaggio, di creazione e di stampaggio che sono ben collaudate». Ne consegue che «per differenziarti devi pagare il prezzo di dover uscire da quello che è lo standard», cosa che a molti non conviene fare.
C’è poi il fatto che per fini di marketing molti prodotti devono cambiare anche quando il packaging andrebbe invece bene così com’è. Nell’articolo “The Package Is the Message”, l’Atlantic ha scritto: «le cose nuove diventano ordinarie molto in fretta, quindi chi sviluppa nuovi prodotti e nuovi packaging deve sempre inventarsi il modo per renderle nuove». Visto che c’è un numero finito di ulteriori lamette che si possono aggiungere a un rasoio, di tipi di pasta che si possono creare e di funzionalità che uno spazzolino elettrico può assolvere, spesso si punta quindi quasi tutto sul marketing o sul packaging.
Chiara Alessi, esperta di design e autrice del libro Tante care cose, fa l’esempio di Barilla. All’inizio, quando i prodotti iniziarono a non essere più venduti sfusi e si iniziò a pensare ai packaging, Barilla «fu la prima a fare packaging per la pasta». Lo fece, molto in breve, «con una sottile allusione al fatto che il suo logo richiamasse un uovo» e con un packaging «che era una scatola di cartone con le sofisticate righine azzurre, per richiamare la tovaglia della casa degli italiani ma anche l’originario colore della carta da zucchero in cui era venduta la pasta». Quella scatola aveva inoltre «una finestrella bucata da cui si poteva vedere il contenuto», per far capire che formato di pasta si comprava. Barilla decise poi di «chiudere la finestrella, per illustrare cosa c’era nella confezione, mettere solo la foto del prodotto». È tuttavia curioso, dice Alessi, «che a un certo punto tornarono sia la foto che la finestrella», che poi ora è sparita di nuovo, per agevolarne il riciclaggio.
Secondo Alessi, il caso di Barilla è «emblematico perché», probabilmente in risposta a un cambio d’approccio da parte dei consumatori, «passa dal massimo della visionarietà e della sperimentazione fino al super-didascalico, evidentemente perché prima i consumatori erano forse molto più spericolati».
Un altro problema, che non riguarda Barilla, si verifica quando – quasi sempre per soli fini di marketing – si decide di cambiare il prodotto, senza curarsi di come questo potrebbe impattare sul packaging. In questo senso, i problemi maggiori si verificano quando un nuovo prodotto è ottenuto attraverso una diversa formula chimica, senza fare sufficienti verifiche sulla sua piena compatibilità con il vecchio packaging.
È opposto ma simile l’ostacolo che si incontra quando – per risparmiare sulla quantità di packaging o per andare incontro a esigenze di sostenibilità – si cambia il packaging senza cambiare niente nel prodotto, anche in questo caso creando possibili complicazioni. Il Wall Street Journal fa l’esempio di un packaging modificato per essere più sottile, senza che però sia modificata la temperatura usata per la termosaldatura necessaria per chiudere il packaging in questione, e aggiunge: «fateci caso la prossima volta che, nel tentativo di aprire un sacchetto di patatine che non ne vuole sapere, ne farete volare metà per la stanza». Ed è simile il caso che si verifica quando, in conseguenza della riduzione di plastica usata nel packaging, si accorcia anche la data di scadenza, con possibili problemi sia per i supermercati che per i consumatori.

(Tim Boyle/Getty Images)
Non è però tutta colpa dei produttori. Anzitutto, perché le aziende spesso sanno che i consumatori tendono a essere molto abitudinari e legati a certe tradizioni. Poi perché spesso e volentieri prestano poca attenzione al packaging. «È difficile», dice Diegoli, «che si decida di non comprare più uno yogurt perché è complicato da aprire». Se l’ostacolo non è stato altissimo, ce ne si dimentica «magari perché è in offerta», oppure «perché nei pochi secondi di tempo in cui decidi cosa comprare non stai lì a fare grandi valutazioni» e «il packaging non è una leva poi così importante».
Alessi fa invece l’esempio di un tipo di packaging secondo lei parecchio migliorabile, che però è così diffuso e accettato da essere ormai difficilmente modificabile: il cartone della pizza. «È incredibile come il cibo più diffuso nell’asporto, che ci viene consegnato dopo un viaggio», spesso arrivi in condizioni tutt’altro che ottimali. «È un problema che abbiamo tutti», dice, «ma che accettiamo come parte del consumare la pizza d’asporto».
Al contempo, è però pure vero che i consumatori mostrano un certo grado di attenzione verso certe faccende. Diegoli spiega per esempio che sono «leggende metropolitane di marketing» quelle secondo cui «per aumentare il fatturato certe aziende allargano il collo delle loro bottiglie», così da far consumare più prodotto. Questo perché «fatta eccezione per una minima parte di prodotti e di consumatori incredibilmente fedeli, c’è tanta infedeltà» e quindi «non è detto che accelerare il consumo di un tuo prodotto ti porti chissà quale vantaggio». Anche Alessi ammette che, sebbene certi packaging potrebbero essere ripensati e migliorati, è pure vero che «non c’è solo l’utente finale» e idee che magari funzionano bene sul lato promozionale, poi sono inattuabili.
Seppur nella percezione di molti il packaging resti di frequente parecchio secondario rispetto al prodotto, ci sono poi argomenti per sostenere che le cose stiano cambiando. Ora, ha scritto l’Atlantic, «lo sviluppo del contenitore va di pari passo con quello del contenuto, non è più l’ultimo passo da fare prima di venderlo». C’è insomma una maggiore coscienza sul ruolo che il packaging gioca nei processi decisionali che ci portano a scegliere cosa comprare tra le decine di migliaia di prodotti in un supermercato, o tra quelle ancora più numerose vendute online.
«Le persone normali» ha notato l’Atlantic «hanno sempre maggiore familiarità con il linguaggio del branding» e si sono fatte «più sofisticate, più critiche verso i modi in cui un packaging è ed appare, sia in termini fisici che emotivi». Anche nelle recensioni online è diventato più facile trovare «opinioni e considerazioni sul packaging, non solo quando quest’ultimo è essenziale per l’uso di un prodotto, come succede per esempio nel caso di un rossetto».
Più padronanza dell’argomento e maggiore attenzione al packaging non significano però che il packaging possa smettere di essere un «esercizio di equilibrismo». Lo è anzi di più, per esempio perché c’è chi dice di esigere più attenzione all’ambiente ma poi fa acquisti incoerenti con queste dichiarazioni. Oppure perché se è vero che l’acquisto online ha reso il packaging meno importante per fini di vendita, è anche vero che, come ha scritto l’Atlantic, aprire a casa un prodotto appena acquistato «è ormai parte dell’attentamente orchestrato crescendo emozionale della consumer experience».
L’acquisto online permette però anche di saltare certi passaggi e di sperimentare nuovi modi per impacchettare e imballare prodotti. Diegoli fa l’esempio dei prodotti spediti in abbonamento, «in cui le persone devono rimanere super soddisfatte e super emozionate» e parla della possibilità, per qualcuno, di sfruttare la situazione per provare a proporre qualcosa di nuovo. È il caso, per esempio, di Dollar Shave Club, azienda che già qualche anno fa iniziò a spedire a domicilio rasoi e prodotti di cosmetica, e che nel 2016 fu comprata da Unilever per un prezzo vicino al miliardo di dollari. Sebbene l’azienda si limitasse a vendere semplici rasoi di un produttore coreano, ebbe grande successo – soprattutto tra i consumatori più giovani – solo grazie al modo in cui decise di impacchettare e vendere online quei prodotti.
Per il futuro, Diegoli si immagina che certi packaging «ormai diventati un simbolo, che addirittura possono permettersi di trascendere l’usabilità, continueranno a esistere». Che ci saranno altri casi come quello del Dollar Shave Club, in cui qualcuno riuscirà a sfruttare qualche idea e occupare qualche nicchia: per esempio quel brand – «in questo caso non una leggenda metropolitana del marketing» – «che ha fatto le etichette al contrario così che nelle storie vengano dritte», e quindi andando contro la praticità». Ma anche che si possa andare, o forse tornare, verso packaging più semplici e meno curati. «Da qualche anno» dice «sul packaging incombono molto anche i distributori, come Esselunga o Coop, che con i loro marchi hanno semplificato molto le cose».
Da una parte, nei prossimi anni potrebbe esserci un certo ritorno al periodo prima del packaging, o quantomeno a un contesto in cui certi contenitori siano pensati per essere conservati e certi contenuti venduti più o meno sfusi. Dall’altra, però, è possibile che si vada verso un futuro in cui il packaging possa diventare qualcosa di riutilizzabile e consumabile direttamente a casa oppure che si affermino infrastrutture logistiche parecchio migliori che possano garantire suoi maggiori e più efficaci riutilizzi.
– Leggi anche: Il paradosso delle borracce, nel ciclismo