Sempre stato maschio
«Cosa sarebbe accaduto se avessi potuto decidere il colore dei miei abiti? Se avessi potuto andare in piscina con il costume con il quale mi sentivo più a mio agio? Sono certo che sarei giunto a quella decisione senza tutta la sofferenza e tutta la fatica che, per tanti anni, hanno condizionato la mia esistenza».
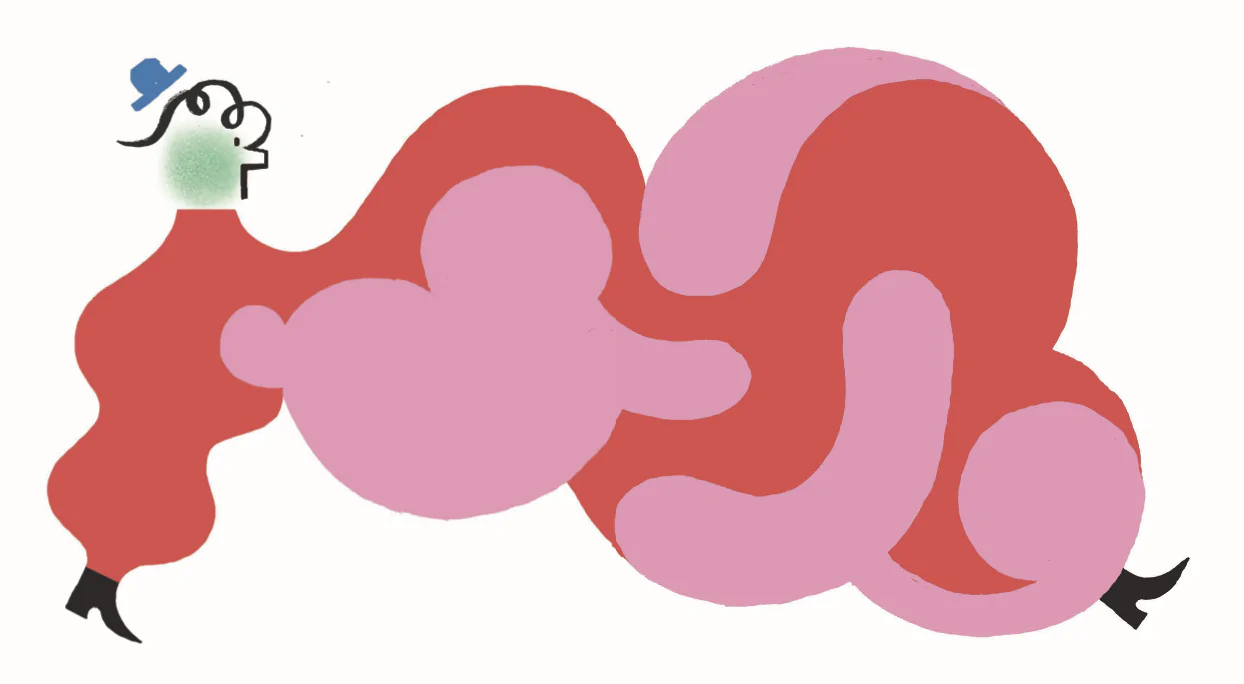
Una delle domande che mi rivolgono spesso è: «Quando hai capito di essere un maschio?» La risposta è che non ho mai «capito» di essere un maschio: il genere maschile è quello in cui mi sono sempre percepito spontaneamente. Al contrario, a un certo punto, a dispetto e contro il mio naturale sentire, scoprii di essere nato femmina. Non ricordo esattamente quanti anni avessi, credo prima dell’inizio delle scuole elementari.
A quell’epoca non c’era molta differenza tra me e gli altri bambini e bambine. Facevo ciò che mi veniva naturale, quindi giocavo con ogni oggetto che avessi tra le mani in maniera spontanea. Mia mamma si ricorda ancora oggi che una delle mie passioni era smontare qualsiasi giocattolo mi venisse donato. Nessuno, in quegli anni, mi disse che non era un gioco da femmine e che sarebbe stato meglio giocare con le bambole. Sono dunque cresciuto, per i primi anni della mia vita, con la spensieratezza di essere un bambino come tutti. Ricordo anche che a quell’epoca chiedevo a mia mamma quando mi sarebbero cresciuti i genitali maschili, convinto che prima o poi sarebbero comparsi.
La scoperta di una netta differenza tra maschi e femmine risale alla prima elementare. Le bambine portavano il grembiule lungo, i maschietti corto. Io ovviamente ricevetti quello lungo, con un odioso ornamento in pizzo al colletto, che regolarmente finiva nascosto nelle tasche appena uscivo di casa. Mi chiedevo quando mi avrebbero dato il giubbino corto come ai miei amici. Ricordo anche che uno dei primi giorni di scuola venne il sindaco a salutarci e io fantasticavo sul nome che mi avrebbero dato quando si fossero accorti che «Maria» sicuramente non poteva essere quello giusto. Le mie fantasie viaggiavano di pari passo alla mia crescita che, però, si sviluppava in un senso completamente diverso. Sognavo di diventare un ragazzo e stavo diventando, mio malgrado, una ragazza. Per i primi anni della mia vita non ebbi il minimo scrupolo nell’esporre pubblicamente le mie preferenze in tema di giochi e vestiti, e anche a protestare ogni volta in cui ero richiamato al rispetto per tutto ciò che era, sotto il profilo degli stereotipi, femminile. Ma da lì a poco il mio mondo si sarebbe accartocciato, con me al suo interno.
Mi piaceva giocare a calcio con i miei amici ma smisi di farlo quando mia madre mi impose un completino rosa. Non lo potevo sopportare. Non mi appartenevano, quei vestiti, e non mi sarei mai fatto vedere abbigliato in quel modo. Il giorno in cui riuscì a farmelo indossare, anziché correre al campo sportivo scappai in camera mia piangendo. Smisi anche di andare in piscina perché mi piaceva portare solo gli slip e non pensavo di dover indossare il reggiseno. Una volta vennero a casa nostra alcune organizzatrici del centro estivo a cui stavo partecipando e avvisarono mia mamma che, se non avessi indossato anche il pezzo di sopra, non avrei più potuto andare in piscina perché il mio torace, con il seno crescente, stava mettendo tutti in imbarazzo. La vera domanda insomma non è tanto quando abbia iniziato a sentirmi maschio, ma quando e quanto la mia relazione con il mondo esterno abbia inciso sulla mia vita.
Ognuno, nel contesto in cui cresce, è educato a ciò che è femminile e a ciò che è maschile. Le regole e le abitudini sono confortanti e rassicuranti perché consentono una percezione di stabilità, e la validità delle tradizioni, comprese quelle che riguardano il genere, è uno dei pilastri su cui si basa la convivenza con gli altri all’interno della società. Ma che impatto hanno queste tradizioni sulla vita delle singole persone? Avrei transizionato se fossi nato in una società nella quale vivere con un corpo femminile (in termini puramente biologici) non mi avrebbe impedito di scegliere quale grembiule indossare a scuola? Cosa sarebbe accaduto se avessi potuto decidere il colore dei miei abiti? Se avessi potuto andare in piscina con il costume con il quale mi sentivo più a mio agio? Sto scrivendo della mia esperienza e premetto che queste riflessioni riguardano esclusivamente me: dal momento che fin dalla più tenera età sentivo che al mio corpo mancava qualcosa, penso che probabilmente avrei fatto comunque lo stesso percorso. Ma sono certo che sarei giunto a quella decisione senza tutta la sofferenza e tutta la fatica che, per tanti anni, hanno condizionato la mia esistenza.
Non desideravo crescere perché mi era abbastanza chiaro che più mi allontanavo dall’infanzia, quando ero stato libero di essere me stesso, più aumentava il divario tra la mia visione di me stesso e quella che avevano gli altri. Erano gli anni Ottanta e nessuno parlava apertamente di termini come «transizione» o «identità di genere», quindi pensavo di essere uno scherzo della natura, un diverso, una persona che doveva stare da sola.
La poca voglia di vivere mi portò ad autosabotare la mia crescita: smisi di mangiare. Sono stato per anni nella spirale dei disturbi alimentari, altro tema del quale, in quegli anni, non si parlava apertamente e nulla o poco si sapeva. La difficoltà di calarmi in un mondo nel quale nessuno era come me, e le privazioni alimentari alle quali mi ero condannato, mi allontanarono completamente dalla società.
I miei abiti maschili, il mio taglio di capelli e la mia passione per la moto suscitavano sguardi e reazioni di disappunto e il non essere conforme alle regole causava momenti di disagio che si riflettevano anche sulla vita delle persone a me vicine. Ancora oggi la mia mente si affolla di domande quando sento parlare di maschile e femminile. Cos’è davvero maschile e che cos’è femminile? Credo che nessuno abbia una risposta. Tutto quello che abbiamo sono semplicemente tradizioni e paure. Tutti devono fare ciò che si è sempre fatto, in modo che ogni cosa sia sotto controllo.
Non a caso ci sono voluti quarant’anni dalla promulgazione della legge 164 del 1982 per arrivare – peraltro attraverso pronunce dei tribunali – ad affermare che le persone transgender non possono essere obbligate a intervenire sui caratteri sessuali per ottenere il riconoscimento della propria identità anche sotto il profilo burocratico. Per decenni per lo Stato la chirurgia è stata obbligatoria: prima di poter accedere alla rettifica dei dati anagrafici era necessario dimostrare a un giudice di essersi sottoposti agli interventi richiesti. Negli articoli della legge del 1982 non c’era nessun riferimento a tale obbligo, ma un inciso, più precisamente la parola «quando» contenuta nell’articolo 3 («Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza»), è stata interpretata nel senso che gli interventi dovessero essere realizzati in tutti i casi in cui la persona non vi si fosse già sottoposta in precedenza. Il potere dello Stato così si insinuò sui genitali dei suoi cittadini e delle sue cittadine, con ordini precisi rispetto alla loro conformazione. La popolazione transgender ha dovuto attendere fino al 2015 perché una sentenza della Corte costituzionale (221/2015) e una della Corte di cassazione (15138/2015) stabilissero che l’intervento chirurgico non era un prerequisito per la rettifica dei dati anagrafici.
Dalla promulgazione di quelle sentenze l’iter burocratico si è semplificato, ma fino al 2015 la persona transgender doveva fare due processi. Con un primo procedimento doveva domandare l’autorizzazione a sottoporsi al bisturi. Una volta operatasi e ricevute le cartelle cliniche, era costretta a rivolgersi nuovamente al tribunale con un secondo processo, per chiedere la rettifica dei dati anagrafici. Col venir meno dell’obbligo di intervento chirurgico i due procedimenti sono stati sostituiti da un unico processo, con cui è possibile chiedere sia l’autorizzazione agli interventi chirurgici (se desiderati) che la rettifica dei dati anagrafici.
Tuttavia i procedimenti sono ancora un percorso complicato. Fino al 2011 le cause per il riconoscimento formale dell’identità di genere erano avviate con un ricorso: oggi, in seguito a una modifica introdotta da un decreto legislativo, serve invece un atto di citazione con cui la parte deve citare in giudizio, se presenti, il coniuge e i figli. Non è chiaro perché una persona transgender debba essere costretta a citare in giudizio il proprio coniuge, se è sposata, oppure i propri figli, se ne ha, anche perché questi soggetti non avrebbero alcun titolo per impedirle il riconoscimento di un’identità di genere diversa da quella attribuitale alla nascita. Per le persone che non sono sposate e non hanno figli, l’unico modo per instaurare il processo è citare la procura della Repubblica che, da parte interveniente necessaria in un processo all’esito del quale ci sarà una modifica degli atti di Stato civile, diventa una vera e propria controparte.
Altri aspetti critici dei procedimenti sono la durata e le pratiche a cui devono sottoporsi le persone transgender. Il codice di procedura civile prevede espressamente che tra il giorno della notifica e la data dell’udienza debbano intercorrere novanta giorni. L’udienza si svolge in camera di consiglio e dunque partecipano solo la parte, il suo avvocato, il pubblico ministero e, se esistono e vogliono costituirsi, il coniuge e gli eventuali figli. Alla prima udienza, il giudice procede con il libero interrogatorio della persona mediante domande che riguardano il suo percorso. Normalmente cerca di ottenere conferma di quanto illustrato nelle relazioni dei medici e di verificare l’esistenza delle caratteristiche richiamate anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, ovvero la definitività e l’irreversibilità del procedimento realizzato. L’ulteriore istruzione probatoria, nella maggior parte dei casi, è documentale, cioè si basa sulle relazioni dei medici che hanno accompagnato la parte durante il suo percorso di transizione.
Solo quando il giudice ritiene di aver bisogno di un approfondimento ulteriore nomina un consulente tecnico d’ufficio (ctu). In questo caso il processo è rinviato a un’udienza in cui il ctu dovrà giurare di adempiere all’incarico conferitogli, chiederà al magistrato un termine per depositare il proprio elaborato, e fisserà l’inizio delle operazioni peritali, cioè una serie di colloqui con la persona. La nomina di un ctu problematizza il procedimento sia per le tempistiche sia per i costi. Infatti, fatta eccezione per i casi in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il consulente dovrà essere pagato direttamente dalla persona transgender.
Il procedimento si conclude con una sentenza che è immediatamente utilizzabile per gli eventuali interventi chirurgici, mentre per arrivare alla rettifica dei dati anagrafici occorre che trascorra il tempo per il suo passaggio in giudicato. Tale termine, in via ordinaria, è di sei mesi: affinché passi in giudicato nel termine breve di trenta giorni è necessario che l’avvocato la notifichi alle controparti. Trascorso questo termine dovrà essere chiesta la trasmissione della sentenza al Comune di nascita perché avvenga la rettifica dell’atto di nascita e la conseguente variazione sul registro dell’anagrafe della popolazione residente.
Da quel momento in poi l’unico documento dal quale è possibile risalire al procedimento effettuato è proprio l’estratto integrale di nascita, mentre la precedente identità non emerge dall’estratto per riassunto. La persona transgender, una volta ottenuta la rettifica dell’identità burocratica, ha diritto a essere identificata in ogni documento con l’anagrafica aggiornata. Questa è sempre una fase un po’ delicata, perché molto spesso le persone si ritrovano a dover risolvere problemi dovuti a dinieghi degli istituti scolastici a ristampare i diplomi, oppure dall’impreparazione dei datori di lavoro nel gestire i dati.
Nella mia professione di avvocato ho accompagnato molte persone nei percorsi di transizione, sia prima che dopo il 2015. Questa esperienza mi ha permesso di verificare quell’ingerenza dello Stato a cui ho accennato. Molte delle persone che ho assistito in tribunale e che avevano richiesto l’autorizzazione agli interventi chirurgici, poi effettivamente realizzati, mi hanno confidato che, se avessero potuto scegliere, quegli interventi non li avrebbero mai fatti. Ho provato una profonda tristezza ma anche un senso di grande sconfitta scoprendo che ciò che i miei assistiti e le mie assistite avevano affermato era in realtà un insieme di frasi che sentivano di essere obbligate a pronunciare per poter vivere liberamente la propria vita. Oggi la condizione giuridica delle persone transgender è migliorata rispetto al passato, ma la necessità di conformarsi non è ancora stata definitivamente superata.
La situazione più complicata è quella vissuta dalle persone le cui istanze sono di fluidità rispetto ai generi. Sempre più spesso questa è la condizione vissuta dai giovani, meno ingabbiati degli adulti rispetto a «come si è donne» e «come si è uomini»: si trovano incastrati tra un mondo rigido e una mente plastica che consente loro di trovare in sé la forza di autodeterminarsi ed esprimersi. Assistiamo a un modo di essere delle nuove generazioni che non tutti riescono a comprendere, perché appaiono così libere da sembrare sovversive rispetto a ciò a cui, per secoli, siamo stati indottrinati.
[…] Attualmente sono le vite delle persone che hanno transizionato in senso classico, trasformando il proprio corpo da un genere al suo opposto, a essere maggiormente comprese dalla società. Credo che questo dipenda dal fatto che chi di noi ha compiuto una transizione di questo tipo, suo malgrado, ha contribuito a rafforzare il binarismo di genere. Questo stato di cose però non è privo di conseguenze nemmeno per noi che, talvolta, restiamo vittime del ruolo di genere. Le donne transgender spesso si sentono obbligate a rispecchiare un certo modo di essere donna e, parimenti, molti uomini transgender si sentono spinti a rivestire lo stereotipo del maschio, nel timore di non essere accolti e riconosciuti. Chi desidera esprimere sfumature che si situano in una posizione intermedia tra il maschile e il femminile si trova molto spesso a doversi giustificare, e a dover rassicurare il prossimo sulla definitività della sua scelta, quasi come se dovesse convincerlo che, anche se non incarna lo stereotipo del maschio o della femmina, è uomo oppure donna. La transizione non finisce mai, è un delicato equilibrio tra quello che si è stati e l’identità finalmente raggiunta, ma il sistema è così binario che le situazioni di potenziale destabilizzazione sono sempre possibili.
Nella popolazione transgender molto spesso si parla di «euforia di genere», intendendo quella situazione di meraviglioso benessere che si sperimenta già dalle prime modifiche corporee. Quest’euforia è però frustrata dal sistema delle relazioni, che porta a quella che a me piace definire «disforia sociale».
Vivere a lungo con una fisicità che esprime un genere e un documento che dichiara il suo opposto è una condizione che ha delle conseguenze sul piano psicologico. Questo periodo, il «real life test», dovrebbe servire alla persona transgender per sperimentare il genere di elezione all’interno della società e viene monitorato da psicologi, endocrinologi o psichiatri per certificare la definitività della scelta compiuta, ma quanto più è lunga questa fase tanto più numerose sono le situazioni nelle quali la persona è sottoposta a un fortissimo stress.
Non è sempre facile riuscire a rendersi conto di quante siano le occasioni nelle quali siamo chiamati a mostrare i documenti di identità. Essendo un gesto abituale le persone che non affrontano un percorso di transizione non vi pongono particolare attenzione, ma sono molteplici e potenzialmente critiche. Anche solo per ritirare una raccomandata bisogna mostrare un documento d’identità. In aeroporto serve per imbarcarsi. Le forze dell’ordine quando operano i controlli su strada chiedono di esibire la patente. Per accedere a un colloquio di lavoro è necessario presentare un curriculum vitae in cui sono espresse le generalità. Abbiamo un sistema nel quale siamo molto attenti alla privacy, la quale sembra diventare una perfetta sconosciuta quando si tratta di accertare l’identità di una persona in transizione.
Ecco allora che di fronte agli sportelli di un ufficio postale o all’accettazione di un pronto soccorso, si è costretti a spiegare ad alta voce, davanti a persone mai viste prima, che quel documento davvero ci appartiene nonostante la nostra immagine esprima un genere differente. Ci sono poi situazioni in cui i nostri gesti dichiarano a quale genere apparteniamo. I bagni sono divisi, nei seggi elettorali ci sono le file per i maschi e quelle per le femmine, in ospedale i reparti sono maschili e femminili, e così nelle carceri.
Immaginate che cosa può succedere quando una donna transgender deve mettersi nelle file riservate ai maschi solo perché non ha ancora il documento rettificato. Oppure provate a immedesimarvi in un uomo, magari con la barba, che deve essere ricoverato in ospedale e si ritrova nel reparto femminile. Se a una prima lettura queste possono sembrare situazioni non gravi, o rare, posso garantire che producono danni profondi. Non sono poche le persone che hanno smesso di votare pur di non affrontare le difficoltà che si creano ai seggi. Conosco persone che non sono andate al pronto soccorso, anche in situazioni di salute compromesse, perché il personale del triage non è sufficientemente formato e, ogni volta, sono costrette a dare spiegazioni dettagliate.
Io stesso anni fa ebbi un’esperienza che mi traumatizzò. Con febbre e dolori insopportabili andai in pronto soccorso e chiesi di parlare con una ginecologa. A quell’epoca avevo già i documenti rettificati quindi il mio nome e il genere erano maschili. In accettazione mi dissero che sarebbe stato meglio che andassi in un altro ospedale perché, in quello, le persone come me non erano ben viste. In un’altra struttura ricevetti un trattamento ancora peggiore e dovetti tornare nella prima: giunto infine di fronte alla ginecologa constatai che l’ignoranza, l’impreparazione e la discriminazione della dottoressa erano tanto gravi quanto insopportabili, dato che provenivano da una medica che aveva giurato di occuparsi del benessere dei pazienti.
Questo è solo un esempio ma ce ne sono stati altri e sempre in ambienti nei quali si penserebbe di trovare un clima di accoglienza e intelligenza. Un altro episodio accadde nel palazzo del giudice di pace. Ero ancora agli inizi della transizione e qualche pelo della tanto attesa barba aveva fatto la sua comparsa. Per 35 anni ero stato abituato ad andare nel bagno delle donne e non mi sentivo pronto a varcare la soglia di quello degli uomini. Alla fine entrai in quello delle donne, ed ecco che una signora mi fece notare che quello non era il mio bagno. Cercai di spiegarle che la situazione era più complessa di quanto potesse apparire, ma la signora, che poi avrei scoperto essere una giudice di pace, aprì la porta e con aria seccata, davanti a un corridoio pieno di persone, disse: «Questo è il simbolo delle femmine e quello il simbolo dei maschi, cosa non le è chiaro?»
Nella mia professione difendo le persone e non ho esitazioni a reagire con determinazione, ma nella vita privata non è sempre così. Eppure quella mattina ci fu una svolta: guardai quella persona e con fermezza ribattei: «E se le dicessi che ho una vagina come lei? Le sembrerebbe tutto così semplice?» Un istinto di ribellione al maltrattamento ingiustificato fece capolino e, da quel giorno, ho messo in campo ogni energia per rispettare me stesso, per farmi rispettare ma anche per fare in modo che nessuno e nessuna dovessero vivere situazioni come quelle che avevo vissuto fino a quel momento.
In un mondo caratterizzato da ingiustizie e violenze non c’è davvero bisogno di alimentare l’aggressività: quindi, in prima battuta, ho tentato la strada della mediazione e della comprensione delle difficoltà di chi incontravo. La mia transizione non è stata solo corporea ma anche caratteriale, da persona chiusa e insicura ho cercato di migliorarmi e coltivare la gentilezza. In strada, in tv, negli ambienti in cui si discorre di politica siamo sommersi dalle grida di chi si sente in una competizione in cui vince la voce in grado di sovrastare quella degli altri. Nella mia esperienza, invece, ho verificato che nella maggior parte dei casi aprirsi e donarsi è una strada per incontrarsi anziché scontrarsi. Abbasso la voce di fronte a chi urla, racconto la mia infanzia a chi crede che i bimbi e le bimbe siano messe in pericolo dalla fantomatica «teoria gender». Parlo con le persone, mi lascio esplorare e attraversare con la speranza di essere ascoltato e che, nel dialogo, ci sia la possibilità di un reciproco arricchimento.
Questo testo è tratto dal secondo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post, dedicato alle identità di genere, che comprende altri articoli che cercano di descrivere i temi delle transizioni e del genere con maggior chiarezza e completezza di quanto avvenga attualmente nel dibattito pubblico.
(l’illustrazione è di Sarah Mazzetti)
– Leggi anche: Luca Sofri – Cerchiamo di capirci



