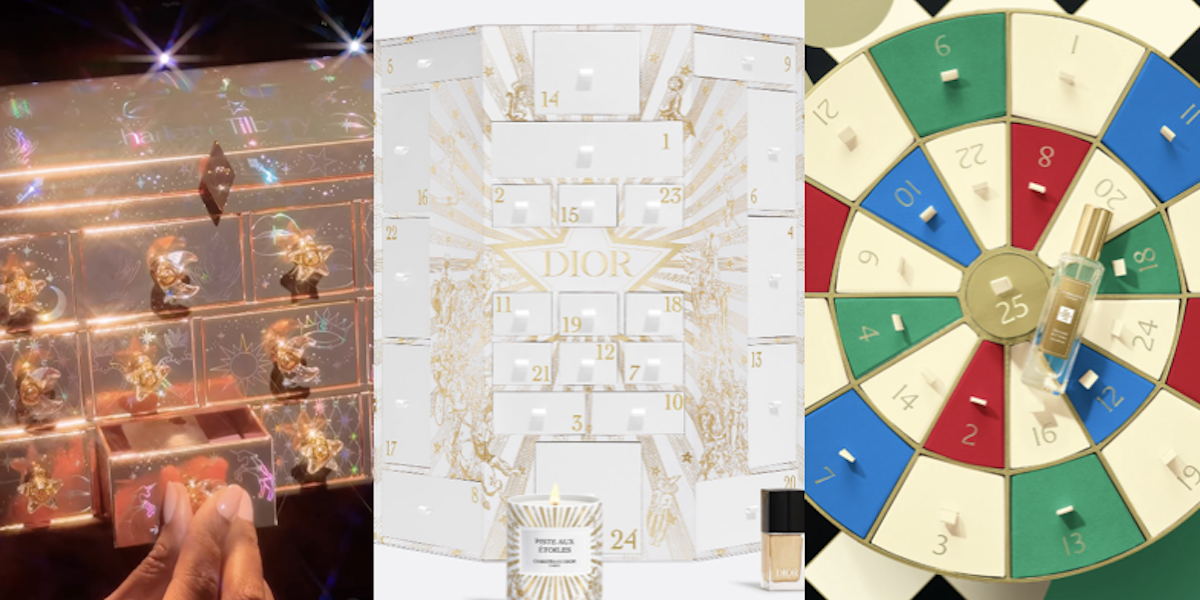Pat Martino diventò un grande chitarrista per due volte
È morto uno stimato jazzista che a metà carriera perse la memoria, e tra la sorpresa dei neurologi imparò daccapo a suonare
di Stefano Vizio

Lunedì è morto a 77 anni Pat Martino, un jazzista americano di grande talento che a un certo punto della sua carriera, dopo un’emorragia cerebrale dovuta a un problema congenito, perse completamente la memoria dimenticandosi come si chiamava, chi erano i suoi genitori e di saper suonare la chitarra come poche altre persone al mondo. Pian piano, nel giro di qualche anno, Martino imparò di nuovo a suonare, tornando a fare dischi e concerti e costruendo una seconda carriera in cui si riaffermò come uno tra i maggiori virtuosi dello strumento.
La vicenda di Martino diventò oggetto di diversi studi di neurologia e fonte d’ispirazione per persone vittime di incidenti simili. La sua storia eccezionale ha sollevato alcune intriganti e stimolanti domande sulla provenienza del talento artistico, aggiungendo elementi preziosi all’annosa discussione su quanto sia innato e quanto frutto di studio ed esercizio.
Nel 1980, quando perse la memoria, Martino aveva già pubblicato una dozzina di dischi, a partire da quello d’esordio El Hombre (1967), tuttora il suo più amato. Con la sua tecnica pulita e sofisticata, era stato paragonato a maestri della chitarra jazz come Wes Montgomery, e si era affermato tra gli strumentisti più virtuosi e raffinati del jazz e della fusion degli anni Settanta.
Era nato a Philadelphia in una famiglia di origini siciliane – di cognome faceva Azzara, ma si impossessò poi del soprannome “Martino” usato dal padre quando cantava nei locali della città – e fin dall’infanzia aveva sofferto di forti mal di testa, che si intensificarono dopo i trent’anni e iniziarono occasionalmente a diventare crisi epilettiche. Raccontando di un malore che lo colse nel 1976 mentre suonava a un festival in Francia, scrisse nella sua autobiografia Here and Now!: «Smisi di suonare e rimasi lì una trentina di secondi. In quei momenti di crisi sembra di cadere in un buco nero. È come se tutto sfuggisse a quel momento».
Diversi specialisti lo consigliarono male, ipotizzando una schizofrenia o un disturbo bipolare, e per curarsi provò anche l’elettroshock. Dovette smettere di fare concerti, dedicandosi all’insegnamento dello strumento. Ma le sue condizioni peggioravano, e a un certo punto un dottore gli diede poche ore di vita.
Il suo problema, si capì in seguito, era una congenita malformazione arterio-venosa dietro all’orecchio sinistro, un groviglio anomalo in cui arterie e vene non sono collegate come dovrebbero, e le prime riversano sangue direttamente nelle seconde. Si crea in questo modo uno scompenso di pressione vascolare che può provocare un’emorragia, come quella che lo colpì nel 1980.
Nell’operazione gli fu rimossa la malformazione e anche un pezzo del lobo temporale sinistro, una porzione della corteccia cerebrale collegata prevalentemente al linguaggio. Quando si svegliò, raccontò in seguito, non riconobbe le persone in piedi intorno al suo letto. Erano i suoi genitori.
«Quando non ricordi qualcosa non hai idea della sua esistenza. E risvegliandomi dall’operazione, non ricordavo niente. Ma non era un sentimento straniante. Se avessi saputo che ero un chitarrista, se avessi saputo che le due persone in piedi vicino a me erano i miei genitori, avrei provato i sentimenti che ci si aspetta in casi simili. Sarebbe stato molto doloroso capire che cosa stavano passando, e perché erano lì a guardarmi. Ma non era doloroso perché per me erano solo sconosciuti»
Martino non sapeva più come si chiamava, chi erano le persone care della sua vita, e aveva perso qualsiasi conoscenza e inclinazione musicale. «Non avevo interesse verso la musica, né la memoria muscolare di come si suona la chitarra» scrisse in seguito.
Ma la sua famiglia lo aiutò pian piano a ricordare, con le storie, con le foto, e con i suoi dischi. Era stato suo padre a farlo appassionare alla musica da bambino, utilizzando la psicologia inversa: gli proibì di suonare una chitarra conservata sotto il letto fino ai 12 anni. Per Martino fu una sofferenza nella sofferenza assistere al dolore del padre che lo vedeva senza memoria della grande musica che aveva composto e suonato negli anni precedenti. Musica di cui lui non ricordava niente, almeno all’inizio.
Quando cominciò a prendere in mano di nuovo la chitarra, «dovetti cominciare dalla prima casella» raccontò molti anni dopo. «Ma quando decisi di provarci, si attivarono familiarità istintive innate, come un bambino che non è andato in bicicletta per anni e ci prova di nuovo per andare in un posto». Applicandosi, «cominciarono a tornarmi gradualmente flash di memoria e di memoria muscolare».
Ci mise pochi anni a ricordarsi che sapeva suonare. A metà degli anni Ottanta cominciò di nuovo a esibirsi dal vivo, e nel 1987 uscì The Return, il suo primo disco dopo l’operazione. Aveva lo stesso tocco di prima, la sua creatività era sempre lì, ma c’erano delle cose diverse nel suo stile, che in qualche modo sembravano collegate a tutto quello che gli era successo. Jon Pareles, storico critico musicale del New York Times, scrisse di un suo concerto a Manhattan del 1986:
«Può zigzagare tra le armonie delle sue canzoni, ma spesso stravolge le convenzioni del bebop. Inizia su battiti inaspettati, interrompe l’improvvisazione per insistere su una singola nota o riff, inserisce dei pattern di durata anomala nei classici fraseggi, e cambia gli accenti nelle battute. Il suo stile è articolato e imprevedibile, prende i pezzi da angolazioni strane e si imbarca in deviazioni appaganti. Rende la forma delle canzoni sfuggevole e misteriosa».
Nel 2000, dopo un concerto al Blue Note di Manhattan, il celebre attore Joe Pesci andò a salutarlo nel camerino. Lui si disse suo grande fan, menzionando alcuni dei suoi film più famosi, e Pesci gli disse: «Non ti ricordi, vero? Ti dirò cosa bevevi nel 1963 allo Small’s Paradise: il Grasshopper». Martino, stimolato dal nome di quel cocktail, improvvisamente ricordò di quando quarant’anni prima era stato un caro amico di Pesci, che all’epoca faceva il cantante nei club di jazz.
Nella seconda parte della sua carriera Martino registrò più di quindici dischi, compreso l’apprezzato All Sides Now del 1997, a cui collaborarono altri importanti chitarristi come Les Paul, Joe Satriani e Mike Stern. Per altri trent’anni fece tour in tutto il mondo, suonando spesso in Italia e ritirandosi solo per un problema respiratorio cronico – lo stesso che ne ha causato la morte – dopo alcuni concerti a Milano, Padova e Ferrara nel novembre del 2018.
Il caso di Martino fu indagato in studi specializzati di neurologia, che provarono a capire le cause di un recupero così straordinario delle capacità motorie e cognitive necessarie per diventare per una seconda volta uno dei più importanti chitarristi jazz al mondo. Nel 2014, il neurochirurgo spagnolo Marcelo Galarza scrisse sul World Neurosurgery che «per quanto ne sappiamo, questo caso rappresenta la prima osservazione clinica di un paziente che mostra una riabilitazione completa da una profonda amnesia, e che ha recuperato il suo precedente stato di virtuoso».
A Martino era infatti stato rimosso circa il 70 per cento del lobo temporale sinistro, che è coinvolto, oltre che nella memoria, nella formulazione e nella comprensione del linguaggio. Gli effetti erano stati strani: Martino non sapeva indicare il nome degli oggetti, per esempio osservando la foto di un cavatappi, oppure ricordava più o meno l’anno del primo tour americano dei Beatles, ma nemmeno un titolo di una loro canzone. Ma a essere stata danneggiata non era solo la memoria semantica, quella legata alle nozioni, bensì anche quella episodica, cioè delle esperienze personali, probabilmente come effetto collaterale dell’operazione.
Come scrisse il sito scientifico Nautilus esaminando il suo caso, secondo i neurologi probabilmente in Martino si conservò soprattutto la memoria procedurale, quella che consente di eseguire quasi senza rendersi conto gesti e operazioni manuali come camminare, andare in bicicletta o suonare la chitarra, e che non ha sede nel lobo temporale sinistro. I tessuti nervosi da cui dipende probabilmente non vennero danneggiati, e anche se lui all’inizio non se ne rendeva conto i ricordi quasi istintivi su come muovere le dita sulla tastiera erano probabilmente rimasti intatti e quiescenti, in attesa di essere riattivati.
Secondo la psicologa esperta di memoria Lynn Nadel, Martino riuscì forse a ricostruire e recuperare la sua personalità proprio grazie a quelle memorie motorie ormai scritte in profondità nel suo sistema nervoso, che gli consentirono di ritrovare la sua identità artistica. Un’altra ipotesi fu che la sua eccezionale plasticità cerebrale, la capacità del cervello di modificare la sua struttura, sia stata perlomeno aiutata da decenni passati a improvvisare allo strumento, un’attività che si pensa possa portare benefici a questa funzione. Altri hanno addirittura ipotizzato che, ancor prima della lobectomia, la stessa anomalia congenita nel suo cervello potesse aver influito sul funzionamento del suo lobo temporale sinistro in un modo che finì per stimolarne la creatività e l’originalità.
Dopo l’emorragia, e in modo probabilmente comprensibile, Martino rivalutò molte priorità della sua vita. Diventò una persona più spirituale e in molte interviste confutò quelle che sono solitamente delle abitudini consolidate dell’ambiente musicale, perfino quella di definirlo “chitarrista” (non voleva essere «spersonalizzato» nel suo strumento).
In una scena del documentario Martino Unstrung, osservando le lastre che mostravano il suo cervello dopo l’operazione, Martino disse, riferendosi al periodo successivo all’intervento: «mi manca lo sconforto, il giudizio degli altri, i dilemmi che rendono la vita così difficile. E a essere onesti mi fa bene». Prima, aggiunse, gli interessavano soprattutto le recensioni, il riconoscimento altrui. «Dopo l’intervento non significano più niente per me. Mi interessa più il momento, la sua essenza e il suo godimento».