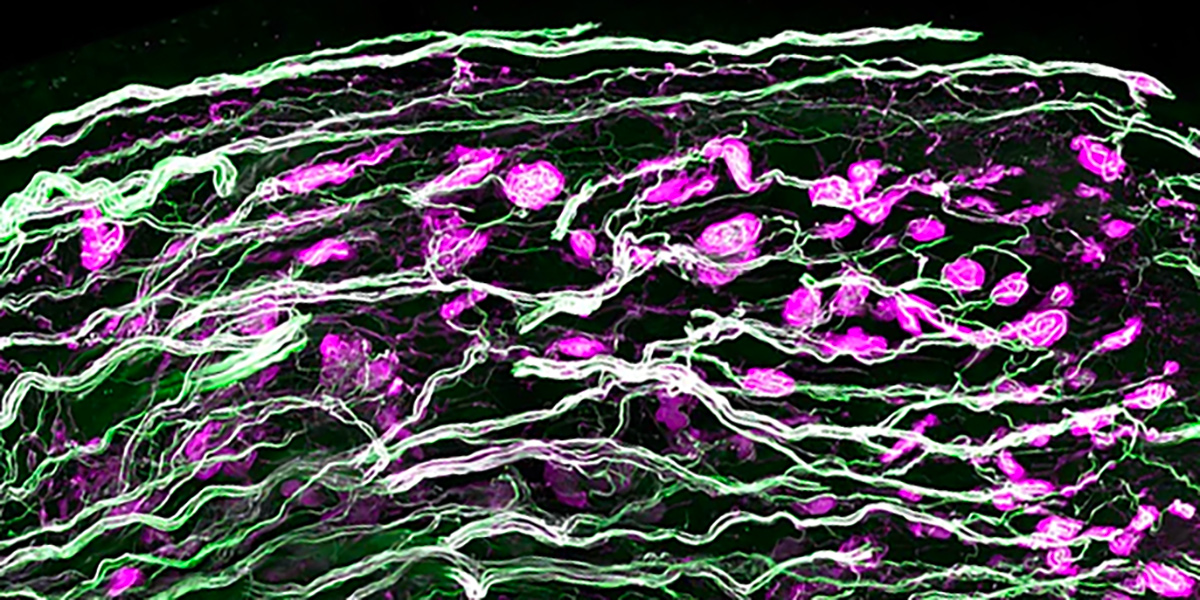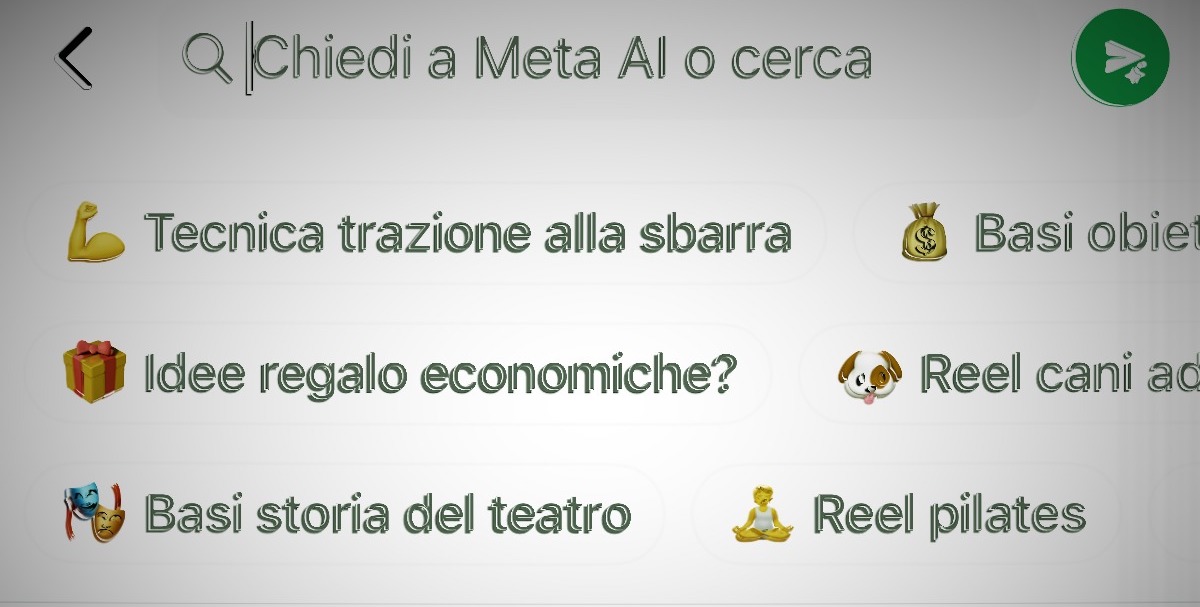Come i criteri di Netflix influenzano i nostri gusti
Categorie e algoritmi condizionano le scelte degli utenti e ridefiniscono costantemente generi tradizionali e pratiche culturali

Tra la fine del 2019 e il 2020 il popolare servizio di streaming Netflix introdusse nell’interfaccia principale di presentazione dei contenuti disponibili per gli utenti una lista delle 10 serie tv e dei 10 film «più visti» sulla piattaforma. Non rese noti i parametri specifici utilizzati per compilare quelle classifiche quotidiane, ma in seguito aggiornò i criteri di calcolo delle visualizzazioni nella compilazione delle statistiche periodicamente riferite agli azionisti: conta come una visualizzazione, ancora oggi, qualsiasi visione di almeno due minuti di una serie o di un film durante i primi 28 giorni di programmazione.
In base a questi criteri e ai dati forniti dall’azienda, la recente serie sudcoreana Squid Game è stata definita la serie originale prodotta da Netflix più vista di sempre: ne hanno visto almeno due minuti circa due abbonati su tre, per un totale di 142 milioni di account.
Le metriche utilizzate da Netflix per la classificazione dei contenuti non sono sempre state queste e potrebbero non essere queste in futuro. Prima dell’introduzione delle liste dei 10 contenuti più visti, una singola visualizzazione era definita come la visione di almeno un episodio di una serie o almeno il 70 per cento di un film. Come riportato in una recente lettera agli azionisti, Netflix ha in programma di introdurre nei prossimi mesi un ulteriore aggiornamento delle modalità di compilazione delle statistiche sui suoi contenuti originali più visti: saranno classificati in base alla quantità di ore totali visualizzate anziché al numero di account che hanno visto almeno due minuti di quei contenuti.
– Leggi anche: Una serie sudcoreana
Recentemente, e in particolare dopo il grande successo di Squid Game, diverse riflessioni condivise tra esperti di tecnologia, sociologi, giornalisti e critici del cinema hanno ripreso un dibattito esistente su quanto i criteri e i procedimenti algoritmici utilizzati dalle grandi piattaforme di streaming, e in particolare da Netflix, nella definizione della “popolarità” dei contenuti, nella classificazione di quei contenuti e nella personalizzazione dell’esperienza degli utenti influenzino le scelte e i gusti collettivi di milioni di spettatori.
È parte di una discussione molto ampia, che riguarda altre grandi piattaforme e i condizionamenti che esercitano sulla cultura popolare ordinando e suggerendo attraverso tecnologie complesse e automatizzate ciò che leggiamo, guardiamo e ascoltiamo tutti i giorni. Ed è una discussione resa ulteriormente complessa dal fatto che l’utilizzo di questi strumenti da parte di ciascuna delle aziende che gestiscono le piattaforme sia regolato essenzialmente in funzione degli interessi economici delle aziende stesse.
Le dinamiche attraverso cui 142 milioni di utenti finiscono per vedere lo stesso programma, a fronte di migliaia di possibilità alternative presenti nel catalogo, sono conosciute solo in parte. Al netto delle visioni molto parziali e quindi poco rilevanti, secondo documenti interni citati da Bloomberg Netflix stima che l’89 per cento delle persone che hanno iniziato a guardare Squid Game abbia visto più di un episodio (almeno 75 minuti) e che il 66 per cento degli spettatori – circa 87 milioni di persone – abbia finito la serie nei primi 23 giorni.
«Netflix differisce dagli studi cinematografici e dalle reti televisive in quanto non genera vendite basate su titoli specifici, ma utilizza il suo catalogo e nuove uscite a ritmo costante per attirare clienti ogni settimana. Ma l’azienda dispone di una grande quantità di dati relativi a ciò che guardano i suoi clienti, dati che l’azienda utilizza per determinare il valore derivato dai singoli programmi», ha scritto Bloomberg.
È noto che servizi come Netflix utilizzino algoritmi per organizzare i contenuti e orientare l’attenzione degli utenti all’interno di un’offerta generale eccezionalmente vasta. Sulla base delle preferenze espresse dagli abbonati attraverso la loro attività sulla piattaforma e attraverso un sistema di valutazione (un pollice in su o in giù), Netflix propone di volta in volta contenuti diversi perfezionando l’offerta in funzione dei gusti e del probabile gradimento di ciascuno degli abbonati. I processi di personalizzazione dell’esperienza dell’utente basati sull’apprendimento automatico, fin dal primo accesso alla piattaforma, sono quindi finalizzati a mantenere l’utente “attivo” e rendere più semplice per lui scoprire contenuti che potrebbe trovare interessanti.
– Leggi anche: Netflix vuole evitare che passiate la serata a scegliere cosa guardare
I dati raccolti nel corso del tempo e su larga scala sono poi aggregati e analizzati per prevedere il successo di determinati contenuti, in base alle stime delle probabili dimensioni del pubblico interessato. Queste previsioni, per esempio, possono servire all’azienda per promuovere il marketing di determinati contenuti o prepararne in anticipo doppiaggi e sottotitoli in paesi in cui contenuti simili a quello promosso hanno già riscosso ampio successo in passato.
Secondo il sociologo inglese David Beer, esperto di nuovi media e docente all’Università di York, molte pratiche culturali sono oggi significativamente condizionate dai processi di automazione delle piattaforme di streaming, che si sovrappongono ai fattori – esperienze, retroterra sociale e culturale, classe di appartenenza – che in precedenza regolavano e influenzavano quelle pratiche. «Questi algoritmi non rispondono soltanto ai nostri gusti, ma li modellano e li influenzano», ha scritto Beer su The Conversation, sostenendo che le modalità di organizzazione dei contenuti sulle piattaforme di streaming – non soltanto quelle visibili agli spettatori – siano oggi responsabili di una profonda trasformazione culturale.
L’effetto degli attuali e più diffusi sistemi di classificazione dei dati digitali – sistemi comuni a diverse grandi piattaforme, incluse quelle musicali – sarebbe in sostanza una ridefinizione dei generi tradizionali. Oltre che utili a distinguere le varie forme di espressione artistica e culturale, quei generi contribuivano a modellare identità e visioni del mondo largamente condivise. Beer utilizza invece l’espressione «immaginazione classificatoria» per articolare una nozione di “genere” meno rigida, più contingente e transitoria, propria dei «media decentralizzati». La intende come una sorta di classificazione culturale continua che riflette l’elasticità delle categorie utilizzate dalle piattaforme e la loro capacità di definire costantemente nuovi generi individuando nuove connessioni nei dati analizzati.
– Leggi anche: Su Netflix c’è sempre più clickbait
A delineare i generi musicali fino a 50 anni fa, per esempio, contribuivano – a parte i media tradizionali di settore, le radio e la critica – le esperienze delle persone nella condivisione di musica tra amici e nella ricerca attraverso i diversi scaffali nei negozi di dischi. L’uso di quei generi, pur tra molti limiti e frequenti forzature, era parte di più estese pratiche sociali. Oggi, dalla consultazione dei consueti resoconti condivisi alla fine dell’anno sulla musica più ascoltata, si stima che su Spotify siano presenti 5.071 generi musicali distinti, tra cui etichette apparentemente prive di senso come “escape room”, “taprun”, “chamber psych” o “sound”.
L’ingegnere del suono e data analyst Glenn McDonald è noto per aver collaborato alla creazione di una grande mappa sviluppata per Echo Nest, una piattaforma di proprietà di Spotify, che raggruppa centinaia di micro-generi musicali. In un’intervista nel 2018 spiegò che l’apprendimento automatico utilizzato per la creazione della mappa valuta la musica in base a numerosi «attributi psicoacustici soggettivi delle canzoni», attributi anche molto trasversali come la durata o i battiti per minuti (bpm). L’algoritmo rintraccia quindi somiglianze tra musicisti diversi in base a quegli attributi e definisce nuovi generi che, pur avendo «nomi inventati», corrispondono effettivamente ai gusti di gruppi di persone reali.
Secondo il riassunto del mio anno su Spotify, il mio terzo genere più ascoltato è il “chamber psych”, e non sapevo nemmeno fosse un genere fino a oggi. Posso confermare che in effetti è uno dei miei generi preferiti.
Sono a volte gli stessi utenti di Spotify a coniare nuovi generi, quando creano delle playlist. «Siamo costantemente riforniti di nuove etichette e categorie mentre consumiamo musica, film e televisione», afferma Beer ponendo l’attenzione sulla continuità dei processi di catalogazione dei servizi di streaming. Attraverso queste categorie dettagliate e particolareggiate, prosegue, i nostri gusti possono essere più specifici e più eclettici, e allo stesso tempo modellabili.
Categorie sempre più specifiche vengono create e archiviate nei metadati – attributi non direttamente visibili – dei contenuti presenti sulle piattaforme, e sono quindi utilizzate per personalizzare i consigli di visione. Il modo in cui Netflix è organizzata attraverso i metadati, in sostanza, «decide cosa viene scoperto al suo interno», scrive Beer. E, come su Spotify, anche su Netflix sono presenti migliaia di categorie che superano di molto in quantità i generi tradizionali. In alcuni casi sono formulazioni più dettagliate di generi noti (“horror cult”) ma in molti altri definiscono una lunga serie di attributi diversi (“film stranieri irrealistici degli anni Settanta” o “horror di fantascienza e suspense degli anni Cinquanta”).
– Leggi anche: Le 76mila categorie nascoste di Netflix
Sebbene Squid Game sia catalogato come una serie di genere “Coreano, Thriller TV”, a questa serie sono associate attraverso i metadati molte altre categorie più specifiche non necessariamente note agli utenti. E Squid Game è inoltre un esempio molto illustrativo di come gli algoritmi possano rafforzare su larga scala un contenuto che è già popolare. «Come sui social media, una volta che una tendenza inizia a prendere piede, gli algoritmi possono orientare ancora più attenzione verso di essa», scrive Beer. E anche le categorie di Netflix lo fanno, prosegue, dicendoci quali contenuti sono di tendenza o popolari nella nostra zona.
«Nella musica, nell’arte e in molti altri ambiti, le nostre preferenze sono in gran parte il risultato della cultura in cui siamo cresciuti: una moltitudine di persone intorno a noi che ci dicono cosa è bello», ha scritto su Insider il giornalista di Brooklyn ed esperto di tecnologia Drew Austin. Secondo Austin, è come se le piattaforme di streaming si sforzassero invece di far finta che i gusti non siano un fenomeno profondamente sociale. Le loro raccomandazioni algoritmiche sembrano avere un effetto di «appiattimento e standardizzazione» dei gusti, un effetto ancora «più pronunciato quando la natura profondamente sociale dei gusti è ridotta al minimo e il contenuto è decontestualizzato».
Uno dei rischi associati all’uso di questi algoritmi per suggerire i contenuti è legato al fatto che abbiamo una comprensione ancora molto limitata del funzionamento di questi strumenti e delle conseguenze di una loro applicazione su larga scala. Inoltre la regolazione di questi sistemi avviene in genere in un contesto di scarsa trasparenza, in cui le aziende sono poco inclini a condividere i dati raccolti attraverso varie metriche, di cui tengono traccia internamente, per paura di offrire vantaggi competitivi alla concorrenza.
– Leggi anche: Non sappiamo più quanta gente guarda i film
«Netflix è un libro chiuso. Non sappiamo niente dei suoi numeri di spettatori a meno che non ce lo dicano, e anche allora, quei numeri sono vagamente sospetti. Sappiamo anche poco su come utilizzano i dati del pubblico per promuovere i loro spettacoli, o anche su come decidono cosa vive e cosa muore sul loro servizio – ragioni che sono sempre sembrate più specifiche del semplice “nessuno lo stava guardando”», scrisse a marzo 2020 sull’Independent il giornalista Adam White.
Secondo il giornalista Rob Horning, esperto di social media e curatore della rubrica Marginal Utility su The New Inquiry, l’obiettivo concreto degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme di streaming non è tanto quello di comprendere meglio i gusti degli utenti quanto quello di «rimodellare» quei gusti affinché gli utenti «sperimentino il desiderio in tempi previsti e in modi preformattati».
Niente esclude, pone infine Beer come esempio, che la classificazione culturale delle piattaforme di streaming possa tenerci lontano da determinate categorie o voci, limitando di fatto la nostra esperienza e modellando la cultura popolare in funzione di particolari necessità. E sebbene sia un discorso valido anche per altre piattaforme e intermediari che in passato regolavano di fatto l’offerta culturale in funzione della risposta degli utenti, le piattaforme di streaming possono oggi utilizzare strumenti di intelligenza artificiale su scale molto grandi. E possono prevedere il successo, ha scritto il giornalista canadese Jon Fingas su Engadget, «in modi che i numeri convenzionali del botteghino e i rapporti sugli ascolti di Nielsen probabilmente non potrebbero eguagliare».
Gli aspetti positivi di queste catalogazioni sono evidenti, secondo Beer, e cioè che nella maggior parte dei casi ci permettono di orientarci di fronte a un numero elevatissimo di possibilità e di trovare più rapidamente ciò che ci piace. Gli aspetti meno positivi riguardano il fatto che sia al momento difficile dare una risposta esauriente alla domanda su quali siano e a quali necessità rispondano le valutazioni alla base della decisione delle aziende di aggiornare determinati criteri, o generare nuove categorie, o promuovere determinati contenuti anziché altri, in un determinato pubblico anziché in un altro. E quali conseguenze significative abbiano tutte queste scelte sulle pratiche culturali del nostro tempo.