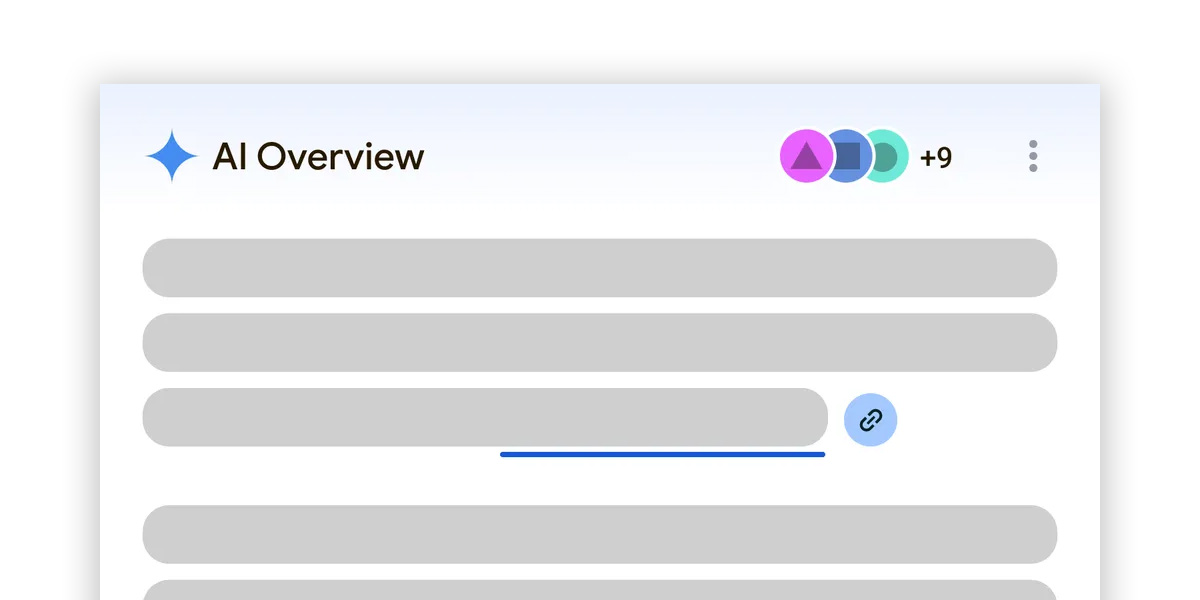Le droghe andranno regolamentate in modo diverso
Un esperto di psichedelici riflette su come limitare i danni e ottimizzare i benefici in un futuro di leggi e approcci sempre più progressisti

Le politiche di revisione delle leggi sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita della marijuana e degli psichedelici, sostenute negli ultimi anni in diversi paesi del mondo, hanno fatto emergere un approccio meno rigido al dibattito sulle droghe e, in generale, una progressiva riduzione delle avversioni ideologiche e delle strumentalizzazioni. L’impressione condivisa da molti osservatori è che i percorsi di legalizzazione, alcuni dei quali cominciati per via referendaria, siano stati favoriti dalla presenza significativa di sensibilità e percezioni differenti rispetto a quelle prevalenti nella coscienza collettiva nei decenni passati.
«Nessuna delle parti politiche, a quanto pare, ha lo stomaco per perseverare in una guerra [alla droga] che ha ottenuto così poco facendo così tanti danni, specialmente alle comunità di colore e alle nostre libertà civili», ha scritto l’apprezzato giornalista scientifico e scrittore Michael Pollan in un articolo pubblicato a luglio sul New York Times. Pollan, che insegna giornalismo all’Università di Berkeley ed è un noto autore di libri di successo sulla nutrizione, sull’igiene alimentare e sulle sostanze psicoattive, ritiene che all’interno del dibattito sulle droghe ci sia oggi maggiore spazio per affrontare senza pregiudizi la difficile questione della regolamentazione e della corretta definizione dei contesti e delle modalità d’uso di queste sostanze.
L’obiettivo di queste riflessioni dovrebbe essere prima di tutto quello di ridurre al minimo i rischi esistenti legati all’assunzione delle droghe. L’approccio «binario» – sì alle droghe, no alle droghe – largamente diffuso in passato, secondo Pollan, ha impedito per lungo tempo di compiere valutazioni basate sui dati e, prima ancora, di considerare le differenze tra una droga e un’altra. Il primo passo dovrebbe quindi essere «riconoscere che agli umani piace cambiare la coscienza», come attesta l’uso di piante e funghi psicoattivi da moltissimo tempo e in diverse culture per trascendere lo stato di «coscienza ordinaria».
– Leggi anche: Non sappiamo stare senza caffè
In molte comunità di nativi americani la droga allucinogena ottenuta dalla pianta del mescal o peyote (Lophophora williamsii) è utilizzata a scopo rituale per favorire la coesione sociale, in particolari cerimonie, oppure a scopo medico come antispastico. Negli anni Sessanta l’influente e controverso psicologo statunitense Timothy Leary, promotore della liberalizzazione dell’LSD, sostenne attraverso una serie di esperimenti che alcuni parametri sociali, psicologici e culturali – in particolare le aspettative e il contesto ambientale (“set and setting”) – sono alla base della risposta alle droghe psichedeliche.
Diversi ricercatori e studiosi ritengono che le idee di Leary non soltanto siano corrette ma possano e debbano essere estese a tutte le droghe, la cui assunzione determina reazioni non esclusivamente legate a fattori farmacologici. Pollan è di questo stesso parere ma sottolinea il rischio che il modello di regolamentazione futura della psilocibina – il composto chimico presente in alcuni funghi allucinogeni – possa essere sviluppato sulla scorta di quello più noto e collaudato della marijuana, la cui vendita a scopo terapeutico e ricreativo è ormai legale in diversi paesi del mondo.
La possibilità che i funghi allucinogeni possano essere venduti come la marijuana, secondo Pollan, dovrebbe spaventarci. Assumere una certa quantità di psilocibina è un’esperienza «potente, importante e rischiosa» e richiede una preparazione attenta oltre che la presenza di una guida. Queste attenzioni e cautele sono, per esempio, presenti e applicate nella psicoterapia, dove queste sostanze circolano già da qualche anno come coadiuvante nel trattamento della depressione e delle dipendenze.
I consueti processi di approvazione dei farmaci, incluso quello della Food and Drug Administration (FDA, l’agenzia governativa statunitense per la sicurezza di cibo e farmaci), dovrebbero essere sufficienti secondo Pollan a garantire l’emanazione di regolamenti che stabiliscano esattamente come, da chi e a chi potranno essere somministrate dosi di psilocibina per massimizzare la validità della terapia e ridurre i rischi di esperienze spaventose e spiacevoli (bad trips).
– Leggi anche: C’è un nuovo farmaco contro la depressione
Un po’ meno semplice e meno convenzionale potrebbe essere il processo di regolamentazione delle droghe per usi che non prevedano la presenza di diagnosi psichiatriche. Cercando possibili modelli di riferimento o anche soltanto esempi significativi, Pollan cita il caso della Chiesa nativa americana, una religione indigena praticata da circa 250 mila persone e diffusa tra i nativi americani in Canada, Stati Uniti e Messico, che in base a una legge del 1994 ha il diritto di usare il peyote durante lo svolgimento di un particolare rituale. Altre religioni, come la Chiesa del Santo Daime, utilizzano l’ayahuasca – un decotto psichedelico a base di diverse piante amazzoniche – come bevanda sacra.
Pollan non esclude e anzi ritiene piuttosto probabile che il riconoscimento legale di alcune droghe psichedeliche possa seguire percorsi di questo tipo, sfruttando un’ampia e favorevole giurisprudenza in materia di libertà religiosa. «Gli americani potrebbero presto essere in grado di andare in chiesa per avere un’esperienza psichedelica ritualizzata».
In contesti più laici, la somministrazione di psichedelici potrebbe inoltre essere presto regolamentata – dopo l’approvazione della FDA – nel modo in cui già vengono utilizzati altri stupefacenti, come la ketamina, nelle terapie assistite proposte da alcune cliniche speciali americane del gruppo Field Trip Health. Sono strutturati come una sorta di centri benessere in cui uno psichiatra esamina i pazienti e poi un medico o un infermiere somministra il farmaco. Altre persone con una preparazione specifica informano i pazienti riguardo a cosa aspettarsi e rimangono con loro durante l’“esperienza”, aiutandoli in seguito a elaborarla e a darle senso.
L’aspetto comune e più importante in tutti questi differenti contesti di somministrazione degli psichedelici, secondo Pollan, è il fatto che quella somministrazione avvenga in un ambiente controllato e che sia presente in tutti i casi una formalizzazione delle procedure. Che è proprio ciò che mancava, racconta Pollan, quando le sostanze psichedeliche si diffusero in Occidente a metà del secolo scorso, senza particolari istruzioni riguardo al loro utilizzo. «Non c’è da meravigliarsi che il bad trip sia diventato uno stereotipo così potente e che la cultura si sia rivoltata contro gli psichedelici».
– Leggi anche: Il ritorno degli psichedelici
Osservando le abitudini e le pratiche dei popoli indigeni che nelle loro diverse culture fanno uso di composti psichedelici per scopi rituali o medici, è possibile notare alcuni tratti in comune e che, secondo Pollan, sarebbe bene tenere a mente. Innanzitutto è rarissimo che quelle persone utilizzino gli psichedelici da sole o casualmente: c’è un motivo specifico e uno scopo. Inoltre è quasi sempre presente un anziano, che conosce il contesto ed è in grado di creare le condizioni più adatte per quell’esperienza, che si svolge invariabilmente all’interno di una struttura rituale.
La differenza tra il consumo di gruppo e quello individuale, per esempio, è ritenuta molto significativa anche nel consumo degli alcolici, spesso utile a individuare e definire il consumo patologico e cercare di limitare i danni provocati dall’alcol.
– Leggi anche: Beviamo da un pezzo
Secondo il medico e divulgatore statunitense Andrew Weil, citato da Pollan, «il rituale sembra proteggere individui e gruppi dagli effetti negativi delle droghe, stabilendo un quadro di ordine intorno al loro uso». Le persone che rimangono all’interno di questo rituale tendono a non presentare problemi legati all’uso delle droghe, mentre tendono ad averne quelle che fanno un uso «arbitrario» delle droghe.
Sotto questo aspetto, prosegue Pollan, la regolamentazione delle cosiddette “droghe pesanti” – droghe come l’eroina, la cocaina e la metanfetamina, che apparentemente le persone assumono per piacere – potrebbe essere più problematica. Uno dei principali limiti delle ricerche del passato, secondo Pollan, è che i pregiudizi su questo tipo di sostanze hanno per lungo tempo trovato sostegno nella convinzione piuttosto condivisa – ma poco dettagliata e approfondita – che queste molecole creino assuefazione e, di conseguenza, dipendenze nella vita delle persone. «Molte persone (me compreso) restano sorprese nell’apprendere che la stragrande maggioranza delle persone che assumono droghe pesanti lo fa senza sviluppare dipendenza».
La visione dell’uso delle droghe e della tossicodipendenza come una malattia mentale, secondo lo psicologo e neuroscienziato Carl Hart, docente alla Columbia University, serve a perpetuare politiche sulla droga irrealistiche e costose, oltre che discriminatorie e responsabili di profonde ingiustizie sociali. In base ai risultati delle sue ricerche, Hart sostiene che ad oggi non sia ancora stato individuato alcun dato biologico che possa servire a differenziare le persone non dipendenti da quelle dipendenti, e ritiene che una parte significativa delle dipendenze sia legata a disturbi psichiatrici e fattori socioeconomici poco analizzati, non a una capacità intrinseca delle droghe di generare quelle dipendenze.
Diversamente che in passato, le dipendenze dalle droghe sono oggi considerate meno una malattia e molto più un sintomo, di traumi psichici, disconnessione sociale o disagio economico, come peraltro suggerisce la distribuzione geografica dell’abuso di farmaci oppioidi e di droghe negli Stati Uniti, in ambienti in cui le prospettive economiche rappresentano un fattore importante nella probabilità di sviluppare dipendenze.
– Leggi anche: Il primo posto in Europa per morti causate dalle droghe
Riprendendo una serie di ricerche condotte dal giornalista e scrittore britannico Johann Hari nel libro “Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs”, Pollan racconta che molto di ciò che sappiamo sulla tossicodipendenza proviene dai risultati di esperimenti con i topi. «Se metti un topo in una gabbia con due leve, una che gli dà eroina o cocaina e l’altra acqua zuccherata, attendibilmente il topo opterà per la droga finché non sarà tossicodipendente o morto». Da questo genere di esperimenti si arrivò alla conclusione che la dipendenza fosse il risultato inevitabile e «biologico» dell’esposizione alle droghe.
Negli anni Settanta un diverso esperimento, condotto dallo psicologo canadese Bruce Alexander, dimostrò che se il topo non si trova in condizioni di isolamento e viene piuttosto trasferito in una gabbia più ampia e con più fonti di stimoli – giochi, cibo, altri topi con cui interagire o accoppiarsi – assume soltanto piccole quantità della morfina che ha a disposizione, cinque milligrammi al giorno anziché 25. Alexander intuì da questo esperimento che l’abuso di droghe non è una malattia ma una forma di adattamento alle condizioni dell’ambiente.
Un altro esempio tratto dalle ricerche di Hari fa riferimento alla dipendenza da eroina sviluppata da circa il 20 per cento dei soldati americani che ne faceva uso verso la fine della Guerra del Vietnam. Molti esperti temettero all’epoca che decine di migliaia di tossicodipendenti, di ritorno dalla guerra, sarebbero finiti per strada. Invece successe qualcosa di inaspettato: quando i soldati fecero ritorno a casa, circa il 95 per cento di quei tossicodipendenti smise di fare uso di eroina, senza differenze significative tra quelli che avevano e quelli che non avevano ricevuto cure specifiche.
Le considerazioni tratte da questi esperimenti scientifici ed esempi storici, secondo Pollan, sono assimilabili a molte delle valutazioni alla base dei recenti approcci normativi che mirano alla depenalizzazione delle droghe per ridurre i danni provocati dalle droghe. Alcune delle soluzioni proposte prevedono le cure farmacologiche anziché l’incarcerazione, oppure l’ingresso in strutture in cui i tossicodipendenti, sotto la supervisione del personale sanitario, possano assumere sostanze più sicure di quelle che possono procurarsi per strada, condizione che determinerebbe l’interruzione delle routine del tossicodipendente, la diminuzione delle morti per overdose e dei crimini commessi per ottenere le droghe.
Un rapporto sui risultati dell’approccio della Svizzera nella cura della dipendenza da eroina sostiene che i servizi offerti dallo Stato e distribuiti attraverso le strutture per le iniezioni possono ridurre i tassi di infezione da HIV, migliorare la salute e le condizioni dei tossicodipendenti e ridurre i tassi di criminalità. Questo genere di approccio, ritenuto tra i più ambiziosi al mondo, è sorto dalla diffusa convinzione che i danni delle droghe possano essere controllati più efficacemente attraversi programmi di sanità pubblica che attraverso politiche repressive e interventi delle forze dell’ordine.
– Leggi anche: Gli oppioidi sono un problema anche in Canada
In Svizzera, sintetizza Pollan, «il governo ti dà una prescrizione per l’eroina, ma poi si assicura che tu abbia un lavoro, un alloggio decente e un supporto terapeutico, sulla base della teoria per cui non avrai più bisogno della droga dopo che le tue condizioni saranno migliorate». Sebbene l’abuso di oppiacei sia indubbiamente causa di una gran quantità di danni agli individui e alla società, prosegue Pollan, contrariamente alle convinzioni sostenute per lungo tempo dallo stereotipo della “spirale delle droghe”, alcune persone riescono a usare abitualmente gli oppiacei mentre conducono una vita produttiva.
Pollan conclude con un parallelismo con «le droghe più distruttive in uso oggi: l’alcol e il tabacco». Afferma che rinunciare al proibizionismo ha storicamente posto le società di fronte alla necessità di regolamentare l’uso di quelle sostanze, introducendo gradualmente sia nuove leggi sia nuove abitudini. Dopo averne riconosciuto i rischi per la salute, il fumo è stato disincentivato attraverso regole che stabilivano dove fosse e dove non fosse consentito, circostanza che – insieme alle tasse più elevate – ha progressivamente portato a una disapprovazione culturale e a una sostanziale riduzione dell’uso del tabacco.
Vale in parte lo stesso discorso anche per l’alcol. «Come società, accettiamo che alcune persone finiranno per avere un rapporto malsano con l’alcol e che decine di migliaia di persone moriranno ogni anno per averne abusato. Ma molte di più useranno quella stessa droga con piacere e senza danno, né per se stessi né per la società». E anche in questo caso i rituali svolgono una funzione protettiva e suggeriscono un modello di consumo, per quanto imperfetto. La maggior parte delle persone, per esempio, non beve prima di una certa ora della giornata né senza la compagnia di altre persone, e soltanto durante i pasti. E una legge prevede sanzioni per chi si metta alla guida dopo aver bevuto.
Non sarà semplice né veloce, secondo Pollan, trovare il giusto equilibrio tra regolamenti formali, norme sociali e tasse, che definisce importanti perché da un lato scoraggiano l’uso e dall’altra servono a sostenere i costi sanitari della società. E il fatto che l’abuso di droghe – inclusi alcol e tabacco – abbia ripercussioni maggiori sui poveri, conclude, dovrebbe essere un argomento a sostegno di una guerra non alle droghe ma alla povertà, «alle condizioni di vita che fanno apparire l’uso di droghe una soluzione ragionevole o uno strumento di automedicazione».