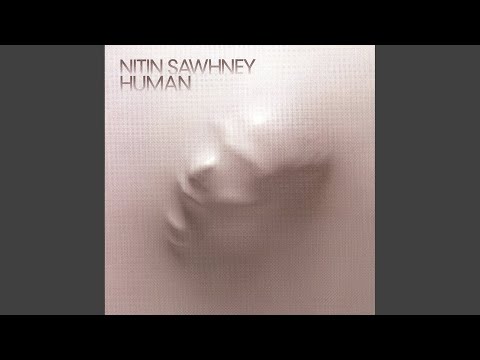Un’altra canzone di Nitin Sawhney
A un certo punto arrivò la "world music"

Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni sera, pubblicata qui sul Post l’indomani, ci si iscrive qui.
Il New York Times ha chiesto a molti musicisti – tra cui Carlos Santana, che ha scelto quella più facile – la loro cosa preferita di Brahms (facendosi però sfuggire il titolo “Le piace Brahms?“).
La scrittrice Margaret Atwood ha scritto un articolo per il Guardian su quel disco di Laurie Anderson, quello dov’era O Superman.
Due sere fa ho guardato quel film di Gus Van Sant che si chiama Don’t worry (il titolo originale aveva un senso, ma è stato ritenuto troppo ostico per il pubblico italiano, evidentemente), con Joaquim Phoenix: nel trailer c’è quella gran canzone di John Lennon che è Isolation.
Poi non so se capiti anche a voi, non è che un film sia brutto, ma magari interrompi un momento per prendere una cosa da bere o rispondere a una telefonata, e dopo ti pare che non valga più la pena riprendere. Come averlo già visto (a me capita con quasi tutto, non vado oltre pagina 50 di un romanzo da anni).
Però sono stato punito, perché allora ho attaccato a vedere quel film di Woody Allen a Roma, che mi ero perso, e quindi pur ricordando di essere uscito dal cinema Anteo di Milano dopo mezz’ora della Ruota delle meraviglie, non avevo previsto la dimensione dell’imbarazzo e quanto ci fossimo giocati Woody Allen (avrà un tenore di vita da mantenere, immagino, per fare questi “film”). E sto divagando, ma dovevo sfogarmi con qualcuno senza insultare anch’io direttamente Woody Allen, che ultimamente è una pratica troppo diffusa.
La ragione per cui ne scrivo qui è che nel primo film – quello che avevo abbandonato – mi era caduto l’occhio sull’autore della colonna sonora, che è uno dei nomi più frequenti sui titoli di testa degli ultimi 30 anni, avendone composte più di cento (con quattro nomination all’Oscar senza vincerlo mai): Danny Elfman. Il quale da giovane era stato in una bizzarra band di qualche fama, gli Oingo Boingo: adesso lui a 67 anni fa uscire di nuovo un suo disco che non è una colonna sonora.
Say hello
A un certo punto arrivò la “world music”: adesso è un termine che non si usa più, un po’ per ragioni simili a quelle della caduta in disgrazia dell’espressione “terzo mondo” – ovvero che quei “mondi” sono stati riconosciuti di più come equivalenti e non alternativi – e un po’ perché quella musica che venne chiamata così si è molto infiltrata ed è diventata più “normale”. Ma negli anni Ottanta – malgrado precedenti che duravano dal decennio precedente – l’idea che potessero avere del fascino e del successo dei suoni nati fuori dalle maggiori culture occidentali divenne mainstream (e anche un po’ compiaciuta e paternalistica, diciamolo) con un’accelerazione dovuta in particolare ad alcuni dischi di Paul Simon e Peter Gabriel, tra i più famosi.
Adesso che tutto è stato piuttosto assorbito, e che possiamo dire appunto che alcune di quelle eccitazioni erano un po’ volatili (l’anno in cui andavamo tutti matti del Buena vista social club, e a ragione, ma cosa ne è rimasto?), al setaccio sono rimasti quelli bravi davvero a mettere nei mercati occidentali i suoni degli altri continenti. Uno dei più bravi di tutti è Nitin Sawhney, (al quale il termine world music fa schifo) i cui successi e onorificenze avevamo già raccontato in questa newsletter.
“Nitin Sawhney ha l’età mia, ormai, mi ci sono imbattuto fortunosamente vent’anni fa e su Playlist l’avevo riassunto così.
A un certo punto, in Inghilterra, qualcuno intravide il formarsi di una corrente musicale angloindiana (“asian underground”). Gli artisti coinvolti (Nitin Sawhney, Talvin Singh, Cornershop, Panjabi MCs) facevano cose abbastanza diverse, ma con una comune componente di “suoni dal mondo”. Nitin Sawhney è forse il più eclettico, incline a frequentare voci orientali e testi in spagnolo, musica lounge e sinfonie classiche, colonne sonore e jazz, giornalismo e impegno politico.
Negli undici anni da allora Sawhney è stato persino nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (cioè, più dei Beatles, per capirsi), tanto vario e ricco è stato il suo ruolo nella cultura nazionale, e non solo nella musica”.
Il mese scorso ne ha scritto lungamente anche Carlo Massarini su Linkiesta. Lui, Sawhney, nel frattempo ha da poco pubblicato un disco nuovo, che si chiama Immigrants, ovvero le storie di cui si occupa da sempre, addolorate e allegre di volta in volta. È bello anche questo, di disco, e di grande sapienza nel mescolare lingue e suoni e musiche: proprio perché non li mescola, ma piuttosto li usa come se fossero un unico grande indistinguibile repertorio. Il disco nuovo è qui su Spotify.
Invece Say hello era nel suo disco del 2003 che si chiamava Human: come molte sue canzoni, la fa cantare da qualcun altro, Tina Grace in questo caso. Ha un testo semplice, preoccupato ma ottimista e prende da subito una gran dolcezza, ma di cui vi consiglio di sentire con le cuffie la quantità di suoni e cose che lui ci aggiunge strada facendo.
Say hello su Spotify
Say hello su Apple Music
Say hello su YouTube