La strategia di Biden in Asia
Possiamo provare a immaginarla, oppure possiamo leggerla nell'articolo scritto poco tempo fa dall'esperto diplomatico che dovrà tentare di metterla in pratica, tra molte difficoltà

C’è una storia che tra addetti ai lavori ci si racconta spesso quando si vuole mostrare quanto in fretta sia cambiato il mondo, e di conseguenza anche le priorità dei governi in politica estera. Ancora all’inizio di questo secolo, nel 2001, il dipartimento che si occupava di Europa dentro il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti era grande il triplo del dipartimento che si occupava di Asia, per funzionari e risorse. Già nel 2005 i due dipartimenti avevano più o meno le stesse dimensioni. Oggi il dipartimento che si occupa di Asia dentro il Consiglio di sicurezza nazionale è grande il triplo di quello che si occupa di Europa. Ed è successo in meno di vent’anni.
La crescita economica della Cina nel corso di questo ventennio è stata verticale, e non si è arrestata nemmeno quando Europa e Stati Uniti sono stati colpiti prima dalla crisi dei subprime e poi, la sola Europa, dalla crisi del debito. Persino nel 2020, mentre la grandissima parte dei paesi del mondo ha visto la propria economia contrarsi a causa della pandemia, l’economia cinese ha continuato a crescere. Oltre ad aver trascinato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone, la grande crescita economica cinese ha avuto tre grandi conseguenze.
La prima: la Cina non è più la cosiddetta “fabbrica del mondo”. La sua prosperità si basa sempre meno sulla produzione di merci a basso costo e sempre di più sull’innovazione tecnologica e digitale, le grandi infrastrutture e le esigenze di consumo di una classe media sempre più numerosa. La seconda: la crescita della suddetta classe media non ha indebolito il regime del Partito Comunista, come alcuni prevedevano, né ha creato una rilevante richiesta di libertà e democrazia. Al contrario, il sistema politico e istituzionale cinese sembra non essere mai stato più stabile di così: e l’attuale presidente Xi Jinping è talmente indiscusso da essere definito “presidente a vita”. La terza: la Cina è diventata una superpotenza globale con una forte rete di alleanze strategiche regionali, costruite attraverso grandi investimenti, forza militare, comportamenti assertivi e a volte rapaci.
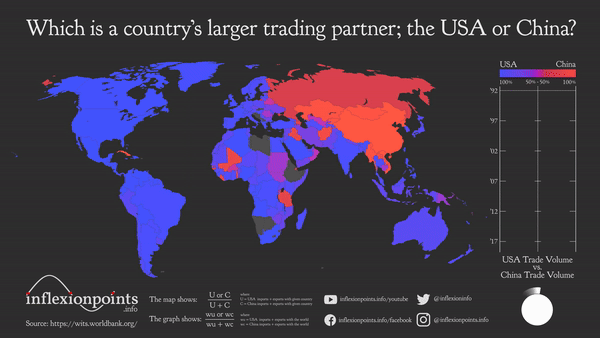
Era inevitabile che un fenomeno di queste proporzioni portasse prima o poi a una rivalità con l’altra superpotenza mondiale. Per decenni gli Stati Uniti hanno guardato la Cina dall’alto in basso, anche perché tutti i dati e i parametri mostravano grandissime differenze tra le due nazioni: una era ricca, solida, prospera e reduce dal secolo che l’aveva resa la più grande superpotenza al mondo; l’altra era in ascesa ma ancora molto arretrata, chiusa in se stessa e alle prese con problemi come la fame. L’idea dominante sulla Cina nella politica statunitense degli anni Novanta e Duemila era, in estrema sintesi: coinvolgiamola nella comunità internazionale, così nel tempo diventerà più simile alle nazioni occidentali e aprirà il suo enorme mercato alle imprese occidentali. La manifestazione più concreta di questa strategia fu l’aver permesso alla Cina di entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001. Come abbiamo visto, però, le cose sono andate diversamente.
L’amministrazione Obama aveva tentato di contenere l’avanzata cinese usando dei canali diplomatici, mantenendo buoni rapporti senza aprire direttamente un duro confronto, e tessendo alleanze commerciali con i principali paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico, Cina esclusa: gli sforzi avevano portato a un importante accordo commerciale, il TPP, che incontrò però forti contestazioni negli Stati Uniti sia da parte della sinistra radicale che della destra radicale, e fu poi stracciato da Donald Trump. La Cina ha ottenuto così un’altra vittoria: al posto del TPP è nato il RCEP, l’accordo di libero scambio più grande della storia, che comprende i paesi del TPP più la stessa Cina.
Con la presidenza Trump, infatti, il confronto con la Cina è diventato molto più duro di prima ma soprattutto è diventato un confronto diretto, bilaterale, che ha coinvolto meno e diversamente gli altri paesi della regione, che anzi gli Stati Uniti hanno spesso maltrattato: la Corea del Sud è stata oggetto di dazi, e insieme al Giappone ha visto gli Stati Uniti indietreggiare rispetto alla loro antica alleanza militare; i rapporti con l’Australia si sono deteriorati, così come quelli con le Filippine e con la Thailandia. Il tutto per guadagnare poco: i dazi hanno fatto male all’economia americana, lo squilibrio della bilancia commerciale degli Stati Uniti con la Cina invece che ridursi si è allargato, e il mandato di Trump si è concluso senza un accordo che risolvesse la guerra commerciale (e con Trump che parlava ogni giorno di “virus cinese”).
Ora a Washington c’è un nuovo presidente e una nuova amministrazione. Se l’urgenza della lotta alla pandemia e la necessità di far ripartire l’economia hanno portato in secondo piano i rapporti con la Cina, il presidente Joe Biden sa che l’esito del suo mandato – e più in generale il futuro degli Stati Uniti – dipenderà in modo significativo dal modo in cui si svilupperà il rapporto con la Cina, e da quanto riuscirà ad arginare la sua crescita di influenza e potere sul piano internazionale. Capire quale sia il piano di Biden è relativamente semplice, però: la persona che Biden ha messo a capo dei rapporti diplomatici con la Cina è un diplomatico di lunghissimo corso che si chiama Kurt Campbell, ha 64 anni, è molto esperto di Asia e Pacifico e ha descritto la sua strategia in un articolo pubblicato su Foreign Affairs proprio pochi giorni prima della sua nomina.

Kurt Campbell a Tokyo nel 2009. (Junko Kimura/Getty Images)
Campbell esordisce dicendo che ci sono delle somiglianze tra la situazione attuale della regione e quella dell’Europa dopo la Seconda guerra mondiale: entrambe le regioni sono in grande espansione economica e in cerca di forti alleati. Nel Dopoguerra gli Stati Uniti riuscirono a usare proprio il commercio e gli investimenti per costruire profonde e durature alleanze in Europa, e questa sembra essere la strada giusta anche stavolta. Ci sono però anche importanti differenze: la regione è più pacifica di quanto fosse l’Europa nel Novecento, e molto più connessa e integrata economicamente. «La nostra sfida stavolta non sarà creare ordine dal caos, come era stato in Europa nel Novecento, bensì modernizzare e rafforzare elementi di un sistema che esiste già».
Ci sono però due fenomeni che rischiano di rendere la regione più instabile. Il primo è l’assertività della Cina, che vuole plasmare l’area secondo i suoi interessi e, se serve, anche a muso duro. Campbell cita a questo scopo la costruzione delle isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, le incursioni militari nel Mar Cinese Orientale, il conflitto con l’India, le minacce di invadere Taiwan, la repressione interna a Hong Kong e nello Xinjang. «Un comportamento», scrive Campbell, «che combinato con le coercizioni economiche come quelle a cui di recente è stata sottoposta l’Australia, mette a rischio l’ordine della regione».
L’altro fattore di instabilità, paradossalmente, è proprio l’atteggiamento degli Stati Uniti negli ultimi quattro anni. «Trump ha messo sotto stress ogni singolo elemento di stabilità della regione», scrive Campbell, citando le pressioni esercitate su Giappone e Corea del Sud per rinegoziare il costo del sostegno militare americano, con la minaccia di un ritiro unilaterale; l’assenza di Trump dai vertici multilaterali internazionali che ha dato campo libero alla Cina, il mancato sostegno agli attivisti per i diritti umani a Hong Kong e nello Xinjang, per i quali Biden ha già mostrato più attenzione di quanto avesse fatto Trump. «Per certi versi l’Indo-Pacifico oggi sembra l’Europa prima della guerra: squilibrata, con un ordine ormai pericolante e senza una chiara coalizione di paesi che possa occuparsene. Il crescente potere cinese ha destabilizzato il delicato equilibrio della regione e ha rafforzato l’avventurismo territoriale di Pechino. Senza un riequilibrio, il comportamento cinese potrebbe compromettere la lunga pace della regione».
Nell’ottica di Campbell quel riequilibrio può arrivare inevitabilmente solo dagli Stati Uniti, innanzitutto in ottica militare. La Cina ha investito moltissimo in missili supersonici, balistici e a lungo raggio, droni sottomarini e armi a lunga gittata, mentre gli americani vanno ancora in giro con costosissime e lentissime portaerei che non fanno da deterrente e incentivano la Cina a fare provocazioni rischiose, come i frequenti sconfinamenti e la recente simulazione di un bombardamento su una base americana. Gli Stati Uniti dovrebbero cambiare approccio, scrive Campbell, dotandosi di una presenza militare che possa davvero fare da deterrente alle provocazioni cinesi.
– Leggi anche: Wargames (tra Cina e Stati Uniti)
Perché questa strategia funzioni, però, serve che gli Stati Uniti la percorrano con i propri alleati, aiutandoli a sviluppare la capacità di resistere all’assertività cinese, e non solo sul piano militare. «Invertire queste tendenze sarà complesso e richiederà finezza diplomatica, innovazione commerciale e creatività istituzionale da parte degli Stati Uniti», scrive Campbell. Il primo passo è semplice, e comporta il primo cambio di rotta rispetto all’amministrazione Trump: gli Stati Uniti dovranno smettere di «maltrattare gli alleati, saltare i vertici regionali, combattere l’integrazione commerciale e snobbare la cooperazione internazionale».
Sul piano economico, Biden non intende fare come se la guerra commerciale non fosse mai avvenuta: e anzi sicuramente trarrà dei vantaggi dal fatto che Trump abbia messo tutto sul tavolo, dalla proprietà intellettuale all’apertura del mercato cinese alle aziende americane, dai pannelli solari all’acciaio, dall’agricoltura alla sicurezza dei dati. Nessuno si aspetta un particolare ammorbidimento dell’atteggiamento di Biden sulla Cina, anzi: ma i negoziati riprenderanno, e dato che la guerra di dazi e sanzioni ha fatto male a entrambi i paesi, trovare una soluzione sarà nell’interesse di entrambi. Stati Uniti e Cina erano riusciti a firmare un accordo preliminare all’inizio del 2020, prima che la pandemia travolgesse tutto; una volta fuori dalla pandemia, l’amministrazione Biden proverà a ripartire da lì e arrivare a un accordo che permetta di eliminare almeno alcune delle sanzioni che i due paesi si sono reciprocamente inflitti.
– Leggi anche: Cosa farà Biden con la Cina?
Il punto di Campbell però è proprio che la questione dei dazi non è che una parte, e nemmeno la più importante, della rivalità tra Stati Uniti e Cina: il grosso dipenderà da quanto la Cina riuscirà a presentarsi nel mondo come la superpotenza di cui conviene essere alleati – usando volta per volta il bastone e la carota – prendendo il posto degli Stati Uniti nella comunità internazionale. Per questo, dice Campbell, la rivalità con la Cina non è bilaterale ma globale, e innanzitutto regionale. Anche a fronte di rapporti commerciali con la Cina che potrebbero restare a lungo tesi e complessi, quindi, gli Stati Uniti dovrebbero cercare di stringere rapporti più profondi con il Giappone, con la Corea del Sud, con l’India, con l’Australia, con l’Indonesia, con la Thailandia: e farlo con generosità.

Kurt Campbell con il dissidente cinese Chen Guangcheng, accolto negli Stati Uniti dall’amministrazione Obama. (U.S. Embassy Beijing Press via Getty Images)
Questo è il punto in cui lo scenario descritto da Campbell diverge di più dalle politiche dell’amministrazione Trump. Gli Stati Uniti non dovranno pensare di costringere questi paesi a scegliere se stare con loro o con la Cina, una scelta che non avrebbe senso per nessuno, ma proporsi come partner affidabili e con i quali sia conveniente avere relazioni durature e profonde. La parola chiave qui è conveniente: gli Stati Uniti dovranno “bussare con i piedi”, dare più di quello che ricevono, consapevoli che – come in Europa dopo la Seconda guerra mondiale – i loro investimenti e la loro generosità produrranno stabilità, pace e forti alleanze. Il contrario di “America First”. «Dal momento che la Cina fornisce investimenti e infrastrutture attraverso la Nuova via della Seta», scrive Campbell, «gli Stati Uniti dovranno fornire investimenti alternativi e assistenza tecnica».
Una volta costruite o consolidate alleanze più forti con i paesi della regione, e messo un freno all’avventurismo e alle provocazioni cinesi, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero «persuadere la Cina che ci sono grandi benefici nel far parte di una regione competitiva ma pacifica, e organizzata attorno ad alcuni principi cardine: un posto importante per Pechino nell’ordine regionale e nelle istituzioni sovranazionali, un ambiente commerciale prevedibile e determinato da regole che valgano per tutti; opportunità di collaborazione sul clima, sulle infrastrutture e su crisi come la pandemia».
Campbell non si fa illusioni sul fatto che sia semplice, o che tutto vada liscio. Anche in una situazione del genere, scrive, «capiterà che di tanto in tanto il comportamento di Pechino si scontri con i nostri interessi e con quelli dei paesi dell’area». In risposta, Washington non dovrà muoversi da sola ma con i suoi alleati, «rafforzare il sistema, fornire a Pechino incentivi perché si comporti produttivamente, e in ultima istanza comminare collettivamente punizioni nel caso la Cina intraprenda azioni che minino l’ordine regionale. Proteggere l’equilibrio e la legittimità del sistema richiederà forti coalizioni tra alleati, e un certo grado di acquiescenza da parte della Cina».
– Leggi anche: La Cina si sta prendendo l’ONU
Tutto qui?, si potrebbe dire. Che non vi sembri poco, risponde Campbell. «Sebbene l’idea che gli Stati Uniti debbano “lavorare con gli alleati” sia ormai quasi un cliché, farlo è molto difficile. Il mantenimento dell’ordine indo-pacifico richiederà inevitabilmente un’ampia coalizione, e gli stessi membri che potrebbero aderire potrebbero non vedere il valore di un tale approccio fino a quando il sistema attuale non sarà irreversibilmente danneggiato. La necessità di avere alleati e partner diventa spesso evidente solo dopo il ribaltamento dello status quo». E si ritorna ai paragoni con l’Europa del Novecento.
«I leader europei sono inevitabilmente meno preoccupati per l’assertività della Cina rispetto agli stati vicini dell’Indo-Pacifico. Di conseguenza, la principale sfida che gli Stati Uniti devono affrontare è collegare gli approcci europei e regionali alle sfide cinesi. Questo compito è reso più difficile dal potere economico di Pechino: il mese scorso la Cina ha trascinato con successo l’UE in un importante accordo bilaterale di investimento, nonostante le preoccupazioni che l’accordo possa complicare un nuovo approccio commerciale transatlantico sotto l’amministrazione Biden.
Date queste limitazioni, gli Stati Uniti dovranno essere flessibili e innovativi nel costruire le loro alleanze. Piuttosto che formare una grande coalizione valida per ogni questione, gli Stati Uniti dovrebbero cercare partnership ad hoc per ogni problema. Queste coalizioni saranno più urgenti per questioni di commercio, tecnologia, catene di approvvigionamento e standard.
Altre coalizioni potrebbero concentrarsi sulla deterrenza militare, ma anche stanziando investimenti infrastrutturali attraverso la cooperazione con Giappone e India e sostenendo i diritti umani con le due dozzine di stati che hanno criticato i campi di concentramento nello Xinjiang e l’assalto cinese all’autonomia di Hong Kong.
Lo scopo di queste diverse coalizioni – e di questa strategia più ampia – in alcuni casi sarà creare equilibrio, in altri sarà rafforzare il consenso su aspetti importanti dell’ordine regionale, in altri ancora inviare un messaggio alla Cina. Questo compito sarà tra i più impegnativi nella storia recente dell’arte diplomatica americana».



