Google blocca le pubblicità sui siti di news, se non gli piacciono
La più grande azienda pubblicitaria del mondo sta impedendo un accordo economico tra altre due società? (e una è il New York Times)
di Joshua Benton - NiemanLab
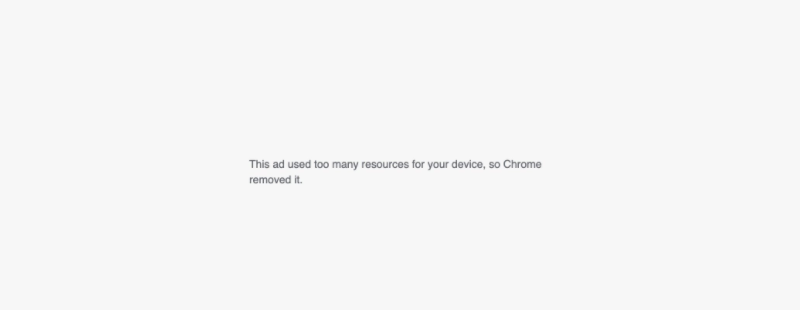
In un qualche giorno feriale, di recente, il New York Times ha venduto un’inserzione pubblicitaria a un’azienda. Non so il nome dell’azienda, o i termini dell’accordo, ma si riferiva allo spazio più importante e visibile che il New York Times offre, un grosso banner interattivo in testa alla sua homepage, quindi la cifra pagata doveva essere significativa.
Mercoledì scorso un lettore particolare del New York Times – in questo caso il suo ex giornalista Aron Pilhofer – ha deciso di visitare la homepage del sito. Inserzionista + Editore + Lettori è la classica equazione dei giornali sostenuti dalla pubblicità: una visita come la sua sembrava completare la somma.
Ma una società da 1.230 miliardi si è messa di mezzo.
First time I’ve seen this. pic.twitter.com/nY21Ty3RnK
— Aron Pilhofer (now here journa.host/@pilhofer) (@pilhofer) December 2, 2020
Per chi non presti attenzione alle scelte dei browser, quello mostrato nel tweet è uno screenshot di una pagina di Google Chrome in cui Chrome blocca la pubblicità che il New York Times ha venduto: “Questa inserzione consuma troppe risorse per il tuo computer, quindi Chrome l’ha rimossa”.
Non che sia una cosa inattesa: Google aveva annunciato a maggio che avrebbe bloccato le pubblicità molto “pesanti” su Chrome. Ha iniziato ad agosto con la versione Chrome 84.
E diciamocelo: a nessuno piacciono i banner che soffocano i browser e rallentano il caricamento delle pagine. Nessuno è solidale con le pubblicità che peggiorano l’esperienza d’uso degli utenti. I lettori preferiscono una pagina funzionale con un rettangolone grigio, piuttosto che una pagina faticosa con una pubblicità.
Eppure… come principio, non riesco a convincermi dell’idea che Google – la più grande azienda pubblicitaria del mondo, quotidianamente indagata dalle autorità di controllo per abusi della propria posizione dominante, criticata per il proprio impatto negativo sul business dell’informazione – possa decidere unilateralmente che una pubblicità che il New York Times ha venduto non sia mostrata a un lettore del New York Times.
Naturalmente non conosco il contenuto del banner in questione. Ma il New York Times ha standard per quello che gli inserzionisti possono o non possono fare, e dubito – a occhio – che abbia deciso di vendere la propria homepage a una società truffaldina di qualche genere. Con le pubblicità “programmatic” vendute da network terzi può capitare che un banner ingannevole che viola le regole sfugga a volte al controllo preventivo, ma non si vendono spazi importanti come quelli a questo tipo di concessionarie esterne: quel banner è stato quasi certamente venduto direttamente dal giornale a un inserzionista maggiore.
(potrebbe trattarsi di un banner autopromozionale del New York Times stesso, ma anche in questo caso la gestione passa da un meccanismo di vendita dello spazio, ndr)
Ma è anche probabile che lo stesso New York Times non sappia quale banner sia. Che un’inserzione sia troppo “pesante” è una scelta presa da un algoritmo rispetto alla singola installazione individuale di Chrome, e dipende da cosa sta succedendo su quel browser in quel momento, e da quanto sta facendo lavorare il processore del computer. In altre parole, lo stesso banner può caricarsi tranquillamente su una versione di Chrome appena installata su un MacBook Pro nuovo, ma essere invece “pesante” su un vecchio Lenovo di qualcuno che ha 872 schede aperte su Chrome e una ventina di estensioni installate (non che io ne sappia qualcosa). E come ha detto a Digiday un importante pubblicitario lo scorso agosto, «è difficile giudicare in astratto quanto sia “pesante” una pubblicità e se possa essere bloccata dai nuovi filtri, difficoltà aumentata con le campagne pubblicitarie progettate per adattarsi diversamente ai diversi dispositivi».
Quindi quell’inserzione che qualcuno ha pagato al New York Times perché Aron la vedesse verrà (a) contata erroneamente come visualizzata o (b) ritenuta venduta, ma non mostrata. Può essere un problema, per il New York Times? Macché. Probabilmente è stata venduta per una cifra forfettaria, che non subisce le variazioni di un centesimo di dollaro per ogni visualizzazione. E queste rimozioni sono comunque un’occorrenza rara: a maggio Google aveva detto che capita allo 0,3 per cento di tutte le inserzioni.
E però.
Guardate, io penso che la gran parte delle critiche contro Google rispetto al business dei giornali siano esagerate. Google non è entrato nelle redazioni a mano armata rubandosi i soldi dei ricavi pubblicitari: ha battuto gli editori e la loro raccolta pubblicitaria facendo concorrenza con un prodotto migliore.
Questo, però, malgrado il suo minuscolo impatto sulla grande maggioranza dei siti, è assolutamente un caso di abuso di posizione dominante. Google è il più grande venditore di pubblicità del mondo e controlla anche il browser più usato del mondo (circa il 66 per cento del mercato), Chrome. Sta usando quest’ultimo per danneggiare la concorrenza sul suo primo business.
Per quanto i produttori di banner farraginosi non siano le vittime con cui si tende a solidarizzare, stiamo parlando di Google che impedisce l’applicazione di un accordo economico tra altre due società. Un conto è che un utente decida di bloccare i banner che vede; altro è che lo decida Google.
Io credo che avesse ragione Tom Kershaw, dirigente tecnologico nel business della pubblicità, quando ad agosto ha detto: «Non discuto che le pubblicità che danneggiano gli apparecchi degli utenti non debbano essere mostrate. La mia preoccupazione è che Chrome stia iniziando a costruire un proprio set di giudizi e reazioni nella sua tecnologia e che questo sia parte dell’autoproclamata missione di essere il solo giudice, giuria e polizia del business pubblicitario».
Joshua Benton è direttore del Nieman Journalism Lab. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata lunedì 7 dicembre.



