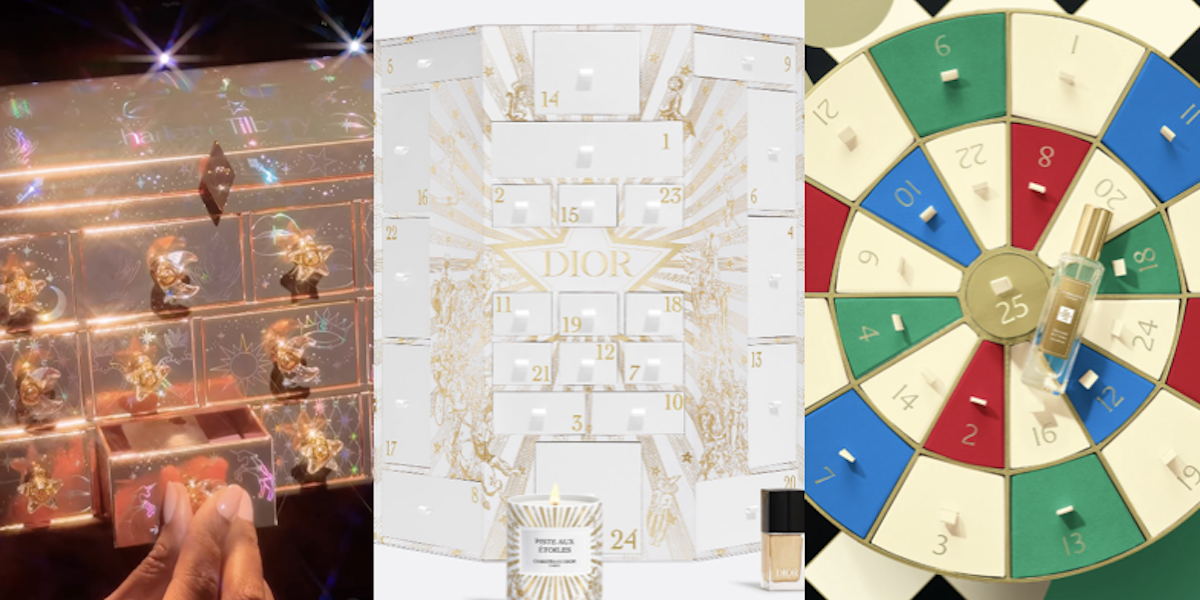Tutti seguirono Charlie Parker
Nacque cento anni fa il sassofonista che inventò il bebop e cambiò per sempre il jazz, in una vita corta e piena di problemi
di @stefanovizio

Una sera del 1936 o del 1937, in un buio e fumoso locale di musica dal vivo di Kansas City, stava suonando la band di Papa Jo Jones, un grande batterista dell’epoca. A un certo punto si unì al gruppo un adolescente per suonare il sassofono in “I got rhythm”, un celebre standard jazz, ma al momento del suo assolo, dopo un grande inizio, perse il tempo e la melodia facendo innervosire gli altri musicisti, tanto che Jones gli tirò un piatto della batteria per farlo smettere e cacciarlo. Il giovane sassofonista se ne andò mortificato, giurando che avrebbe studiato e sarebbe tornato per fargliela vedere.
Si chiamava Charlie Parker, e pochi anni dopo avrebbe cambiato la musica jazz come forse non fece nessun altro prima e dopo di lui. Ebbe poco tempo per farlo. Era nato il 29 agosto 1920, cento anni fa, e cominciò la sua rivoluzione nella prima metà degli anni Quaranta: poco più di dieci anni dopo, a 34 anni, sarebbe morto consumato da una vita breve e piena di difficoltà, prima causa e poi conseguenza della sua grave dipendenza dalla droga e dall’alcol.
Prima di Parker, il jazz era la musica delle big band, i complessi formati da una dozzina di elementi o più, guidate da musicisti popolarissimi come Duke Ellington, Benny Goodman e Count Basie. Suonavano lo swing, una musica che faceva ballare e divertire la gente e che dava lavoro a centinaia di musicisti nel paese, quasi esclusivamente afroamericani, che arrivavano solitamente da contesti poveri e disagiati e smaniavano per trovare posto in una band e girare gli Stati Uniti.
Ma col finire degli anni Trenta lo swing delle big band stava cominciando a stufare i jazzisti più giovani, che si sentivano soffocati dalle rigide partiture che dovevano seguire pedissequamente, e dalle limitate possibilità consentite dagli spazi dedicati agli assoli, durante i quali i virtuosismi e le invenzioni erano sempre subordinati a far ballare la gente.
– Ascolta il podcast: Il più grande anno della storia del jazz
Tra questi jazzisti scalpitanti c’era anche Parker. Era cresciuto a Kansas City, tra la parte del Kansas e quella del Missouri, figlio unico di un padre cameriere sui treni e di una madre impiegata notturna, appassionandosi al sax quando gliene regalarono uno a 14 anni. Per un po’, il sax non fu al centro della vita di Parker, ma a un certo punto, nella seconda metà degli anni Trenta, qualcosa cambiò: qualcuno sostiene che fu proprio la figuraccia fatta con Jo Jones, fatto sta che si mise a studiare maniacalmente anche per quindici ore al giorno, diventando un fenomeno nel giro di qualche mese. Cominciò a suonare con le band dell’epoca, finché capitò in quella del pianista Jay McShann, il vero punto di svolta della sua carriera.
Con quella band, Parker cominciò a frequentare sempre più spesso Chicago e soprattutto New York, i posti dove succedevano davvero le cose nuove del jazz: ci si trasferì nel 1939 e pian piano venne notato da gente che come lui voleva fare musica diversa da quella delle big band. Nei primi anni Quaranta, nei locali di Harlem e della Cinquantaduesima strada di New York, musicisti come Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Miles Davis e Charlie Christian stavano sperimentando un genere nuovo e fatto per gruppi più piccoli e agili, con strutture musicali più originali e flessibili, pensato per un pubblico seduto e attento, e disposto anche a farsi sorprendere.
– Leggi anche: Uno come Miles Davis
Parker ebbe la sua rivelazione nel 1939, suonando lo standard “Cherokee”: si accorse che quando improvvisava poteva aprirsi spazi fino ad allora abbastanza sconosciuti utilizzando le note più lontane che componevano gli accordi, creando linee melodiche nuove che univa e armonizzava tra di loro sfruttando i cromatismi, cioè gli intervalli più piccoli tra una nota e l’altra, anche uscendo dalle canoniche scale usate dai jazzisti negli assoli.
Non era un’intuizione particolarmente cervellotica, ma era una specie di affronto per gli schematismi con cui si era abituati a pensare e suonare il jazz. Unita al suo straordinario virtuosismo sviluppato nelle ore e ore di studio da ragazzo, Parker suonava come un torrente in piena, inondando il pubblico di note che spesso sembravano storte e fuori tempo o fuori tonalità, ma che sapeva tenere insieme perfettamente sviluppando e sciogliendo tensioni che tenevano la gente sul bordo della sedia. Parker componeva, disfaceva, ripeteva e variava le frasi dei suoi assoli con una musicalità incredibile, sapeva suonare in una grande varietà di registri, da quelli più squillanti a quelli più soffusi, e fu tra i primi a usare il silenzio tra le note come vera componente melodica, e non come pausa per riprendere fiato.
Parker era nel posto e nel momento giusti. Come lui, altri giovani musicisti newyorkesi stavano aggiungendo un pezzetto ciascuno gli ingredienti che avrebbero creato una musica nuova, che avrebbe completamente e irreversibilmente ribaltato il jazz. Alle cadenze compassate dello swing, sostituirono un accompagnamento ritmico più nervoso e imprevedibile, trascinato dai piatti più che dalla grancassa della batteria. Anche il pianoforte cambiò radicalmente ruolo, passando da tappeto sonoro a strumento ibrido, un po’ solista e un po’ d’accompagnamento, spesso contemporaneamente. I fiati furono ridotti in numero, e iniziarono a suonare molte più note. E fu stravolta la struttura dei pezzi, che cominciarono a sfruttare progressioni armoniche più originali e sofisticate.
– Leggi anche: Dizzy Gillespie voleva fare tutto
Era nato il bebop, un genere nuovo e dal quale il jazz non sarebbe mai più tornato indietro. Tutto quello che accadde dagli anni Cinquanta in poi, dall’hard bop al jazz modale, dal free jazz alla fusion, passò da quello che fecero in quei pochi anni quel manipolo di musicisti di New York ispirati e guidati da Parker, che per questo fu il più citato maestro di diverse generazioni di jazzisti, e la cui influenza e le cui invenzioni sconfinarono in tutta la musica della seconda metà del Novecento, attraverso la forza distruttiva e innovativa del genere che aveva inventato.
Il bebop attirò da subito grandi attenzioni nelle principali città americane, specialmente tra il pubblico più colto ed esigente, come gli scrittori beat che iniziarono a venerare Parker e soci. Il bebop non era stato pensato come una musica respingente ed elitaria, perché continuava a mettere al centro la melodia sia nei temi degli standard, sia nelle improvvisazioni dei solisti. Ma per un po’ fu percepito come eccessivamente cerebrale dalla maggior parte degli ascoltatori, che rimase scettica nei confronti di una musica che non si poteva ballare e che non sembrava essere pensata per svagarsi.
La diffidenza nei confronti del bebop aveva anche altre radici. A suonarla, come gran parte del jazz, erano musicisti afroamericani, che però non erano più inquadrati nella rassicurante cornice delle big band, con i completi coordinati e i piedistalli in fila. Lo swing era popolarissimo tra i bianchi, e il bebop lo fu molto meno: anche perché i musicisti neri che lo suonavano si consideravano artisti, e non intrattenitori, ed esibivano l’emancipazione raggiunta con il proprio talento con atteggiamenti che erano spesso percepiti come scandalosi e disdicevoli.
Tra i giovani jazzisti, la droga e l’alcol erano effettivamente un grosso problema: le carriere di tanti furono rallentate, ostacolate e talvolta stroncate da problemi di dipendenza, come nel caso di Miles Davis e Bud Powell. Ma fu probabilmente Parker quello che pagò il conto peggiore. Nel 1936, mentre stava attraversando in auto l’altopiano d’Ozark per un concerto, ebbe un grave incidente nel quale rimediò una frattura alla spina dorsale. Cominciò a prendere antidolorifici, e scivolò in una dipendenza dagli oppiacei, che a quei tempi voleva dire eroina.
– Leggi anche: Il grande Charles Mingus
La droga occupò una parte enorme della carriera di Parker, la cui inaffidabilità e la cui tendenza agli eccessi diventò proverbiale nell’ambiente. Spesso impegnava i suoi sassofoni per comprarsi l’eroina, e si presentava ai concerti senza strumento, facendoselo prestare da qualcuno. Negli anni peggiori, si addormentava in piedi sul palco quando non doveva suonare, per poi svegliarsi e suonare con precisione e lucidità sorprendente quando toccava a lui.
Era un omaccione che amava tantissimo il pollo fritto – passione da cui sembra derivi il suo soprannome “Bird” – e capace di mangiare venti hamburger di fila e bere una quantità spropositata di whisky. Passava un sacco di tempo sui taxi, che usava per dormire, mangiare, avere rapporti con prostitute e incontri di lavoro. Si racconta che a volte suonava a casa degli amici nel cuore della notte per farsi prestare un fiammifero, e una volta si addormentò fumando nella camera del suo albergo di Los Angeles uscendo poi nudo per strada quando il letto prese fuoco.
Questi tratti diventarono parte integrante del suo personaggio, ma non gli impedirono di diventare nel giro di qualche anno la figura più ammirata e rispettata del jazz newyorkese, il padre nobile di una musica nuova e rivoluzionaria che era percepita come tale da chi la suonava.
– Leggi anche: A Thelonious Monk bastava il nome
Per via di uno sciopero dei musicisti che durò dal 1942 al 1943, non ci è giunta quasi nessuna registrazione di quegli anni, nei quali prese forma il bebop. Ma da quel momento in avanti Parker prese parte a centinaia di sessioni e concerti, moltissimi dei quali con Gillespie, con cui formò forse la coppia più formidabile della storia del jazz. La loro band, in cui suonarono i più grandi dell’epoca, da Davis a Monk al batterista Max Roach, diventò richiestissima e girò in tutti gli Stati Uniti, registrando principalmente per l’etichetta Savoy.
Ma quegli anni d’oro non durarono a lungo. In un periodo in cui lavorò in California, Parker cominciò a fare fatica a procurarsi l’eroina, sostituendola con grandi quantità di liquori che ne peggiorarono drasticamente le prestazioni sul palco e lo resero ancora più irrequieto e inaffidabile. Nel 1947 fu ricoverato in un istituto psichiatrico californiano, dove rimase per sei mesi subendo continue sessioni di elettroshock. Tornò poi a New York, dove riprese a consumare eroina e a registrare con maggiore regolarità: ne uscirono alcuni dei suoi dischi migliori, registrati in quintetto con Davis, Roach, Duke Jordan e Tommy Potter.

Da sinistra: Tommy Potter, Charlie Parker, Miles Davis e Duke Jordan, in concerto al Three Deuces di New York nel 1947. (William P. Gottlieb/Library of Congress)
– Leggi anche: L’inarrivabile John Coltrane
Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta Parker aveva raggiunto l’apice della sua fama, arrivando a suonare e registrare con diverse orchestre sinfoniche e ad avere un locale di New York intitolato in suo onore, il celebre Birdland. Nel 1953 suonò in quello che ancora oggi è considerato il più grande live della storia del jazz, insieme a Gillespie, Powell, Roach e Charles Mingus alla Massey Hall di Toronto, in Canada. La sala era semivuota, perché c’era in contemporanea un attesissimo incontro di boxe, e Parker arrivò senza sassofono, e ne usò uno di plastica. Mingus fece registrare quasi per caso il concerto, che rimase l’unico in cui i cinque suonarono insieme, entrando nella storia della musica del Novecento.
Ma Parker non aveva mai smesso di farsi di eroina, e le cose cominciarono ad andare di nuovo molto male quando perse sua figlia di tre anni per una polmonite. Nel 1954 tentò il suicidio, si allontanò da amici e colleghi finendo per essere perfino bandito dal Birdland per i suo comportamenti molesti. Fu preso sotto la protezione della baronessa Pannonica de Koenigswarter, una mecenate inglese che anni più tardi avrebbe aiutato anche Monk. Una sera del marzo del 1955, mentre era ospite nella sua suite allo Stanhope Hotel di New York per riprendersi da una dolorosa ulcera, stava guardando uno spettacolo comico in televisione, quando cominciò a sentirsi male e a soffocare. Morì nel giro di pochi minuti, a 35 anni non ancora compiuti. Il medico legale che lo visitò, valutandone le condizioni, stimò che avesse il fisico di un uomo di oltre 50 anni.