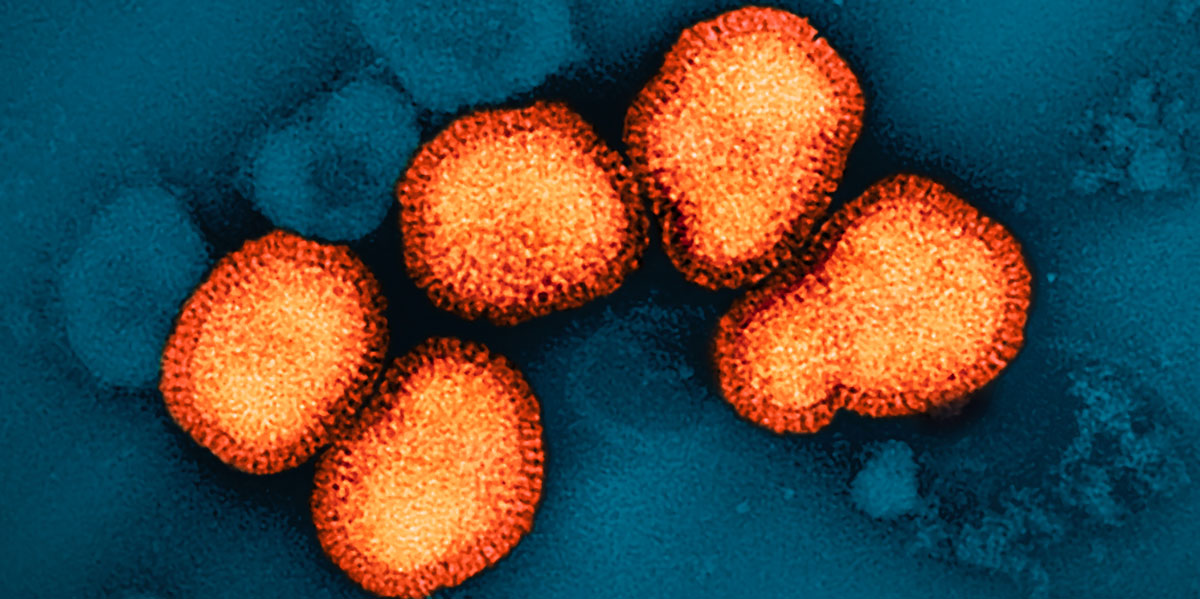Perché pochi infetti contagiano molti
I dati raccolti finora indicano che solo una parte delle persone positive al coronavirus causa un numero consistente di contagi: sembra c'entri soprattutto il caso

I dati raccolti negli ultimi mesi sulla pandemia sembrano suggerire che buona parte degli infetti non trasmetta ad altri il coronavirus, e che la diffusione del contagio dipenda da un numero ristretto di individui in grado di infettare molte persone. Sono i cosiddetti “super diffusori” di cui si era parlato molto all’inizio dell’epidemia, e sui quali iniziamo a sapere qualcosa di più grazie alle ricerche svolte nell’ultimo periodo e alle analisi sulla diffusione del coronavirus in particolari condizioni e aree geografiche.
Da settimane si leggono sui giornali e sui profili dei social network di numerosi epidemiologi storie e aneddoti di “eventi da super diffusione”, nei quali un individuo ha probabilmente contagiato inconsapevolmente decine di altre persone, magari perché infetto, ma senza sintomi. A fine maggio era circolata la notizia di una festa di compleanno in Texas, dove un uomo aveva da solo infettato altre 17 persone, secondo la ricostruzione dei contatti che aveva avuto durante i festeggiamenti.
Ben Althouse, epidemiologo presso l’Institute for Disease Modeling (Washington, Stati Uniti), ha usato un’analogia per spiegare il fenomeno: “È come lanciare un fiammifero acceso tra i ramoscelli per avviare un fuoco. Ne lanci uno e non succede niente. Ne lanci un altro, ma i ramoscelli non s’incendiano. Alla fine un fiammifero raggiunge il punto giusto, e all’improvviso si accende il fuoco”.
– Leggi anche: Che cos’è un “super diffusore”
Al momento i ricercatori sanno che alcuni infetti causano il contagio di un alto numero di persone, mentre altri no, e non sanno spiegarne completamente il motivo. La raccolta di dati sui focolai e su come si attivano è quindi essenziale per fare maggiore chiarezza, soprattutto nell’ottica di sviluppare sistemi più adeguati per fare prevenzione e arginare i nuovi contagi.
Da mesi sentiamo parlare di R0, cioè il “numero di riproduzione di base”. Serve a indicare la quantità di individui che in media vengono contagiati da una persona infetta: il dato è riferito a una popolazione totalmente esposta alla malattia, come avviene quando inizia a diffondersi un nuovo virus (qui lo avevamo spiegato più estesamente).
I primi studi svolti in Cina avevano portato a stimare un R0 tra 2 e 3, indicando che senza interventi in media un infetto contagia al massimo altre 3 persone. Particolari precauzioni, come il distanziamento fisico e i lockdown, hanno permesso di ridurre sensibilmente R0 in molti paesi, facendo rallentare la diffusione dell’epidemia.
Quando si parla di numero di riproduzione di base è importante ricordare che si tratta di un dato medio. Se 9 persone su 10 non contagiano nessuno, ma la decima da sola ne contagia altre 20, R0 rimane comunque a 2. E non è un dettaglio da poco: alcune malattie infettive come l’influenza si diffondono costantemente tra più persone, mentre altre come il morbillo tendono a diffondersi a ondate, con pochi infetti che contagiano un maggior numero di persone.
– Leggi anche: Il complesso problema degli asintomatici
Per distinguere meglio, i ricercatori utilizzano spesso un altro parametro che indica quanto varia negli individui la capacità di diffondere una malattia infettiva (“parametro di dispersione”)”. Uno studio, pubblicato nella sua forma preliminare e quindi da prendere con qualche cautela, ha stimato che circa il 10 per cento degli infetti è responsabile dell’80 per cento dei nuovi contagi. Altre ricerche sono arrivate a conclusioni simili, segnalando quindi che il coronavirus viene diffuso da un numero relativamente ristretto di persone, tra tutte quelle che diventano infette.
Non è ancora completamente chiaro quali siano i fattori che rendono un infetto un super diffusore. Un’ipotesi è che in alcune persone i virus riescano a replicarsi molto di più rispetto ad altre, e che quindi abbiano una maggiore capacità di diffonderli nell’ambiente circostante. Ci sono poi particolari condizioni ambientali che possono favorire il contagio da una persona più che da altre, se per esempio lavora per molto tempo con altri individui in un ambiente chiuso, a stretto contatto e con scarso ricambio d’aria.
Diversi ricercatori sospettano che le condizioni ambientali e le singole circostanze possano essere un fattore determinante, più delle caratteristiche fisiche dei singoli individui. Stando alle informazioni raccolte finora, la maggior parte dei nuovi contagi avviene in un periodo piuttosto ristretto: nel paio di giorni successivi al momento del contagio, a volte prima che si manifestino i sintomi. Se in quella fase la persona da poco infetta entra in contatto con molti individui, può trasmettere il coronavirus a un numero considerevole di persone.
È probabilmente per questo motivo che alcuni luoghi di aggregazione diventano spesso l’origine di nuovi focolai. La compresenza di più persone in un luogo circoscritto, magari al chiuso, costituisce di per sé un aumento del rischio, ulteriormente amplificato nel caso in cui tra gli individui a stretto contatto ci sia qualcuno infetto da poco e che inconsapevolmente può contagiare molte altre persone.
Questa circostanza, spiega Carl Zimmer sul New York Times, potrebbe spiegare perché ci sia stato un sensibile intervallo tra il momento in cui il coronavirus è iniziato a circolare in alcuni paesi e il momento in cui ha determinato l’epidemia su larga scala. Alcuni studi hanno evidenziato che probabilmente il coronavirus fosse in circolazione in Europa ben prima dei casi rilevati tra fine gennaio e febbraio. La combinazione della sua scarsa diffusione all’epoca e la mancanza, del tutto casuale, di un evento di super diffusione hanno fatto sì che il virus passasse inosservato per settimane, prima di determinare un alto numero di infezioni.
Comprendendo meglio questi meccanismi, si potrebbero elaborare strategie più adeguate per rallentare la diffusione dell’epidemia. Misure restrittive su grande scala come i lockdown potrebbero essere ricondotti su scale molto più piccole e puntuali, per fermare i singoli focolai senza la necessità di misure più incisive e limitazioni che interessano ampie aree geografiche, come accaduto tra i mesi di marzo e aprile in Italia e in numerosi altri paesi europei. Attività di questo tipo, su singoli focolai, sono del resto già attuate dalle autorità sanitarie, ma una migliore comprensione delle dinamiche di diffusione del coronavirus dovrebbero consentire di migliorare resa ed efficacia delle quarantene selettive.