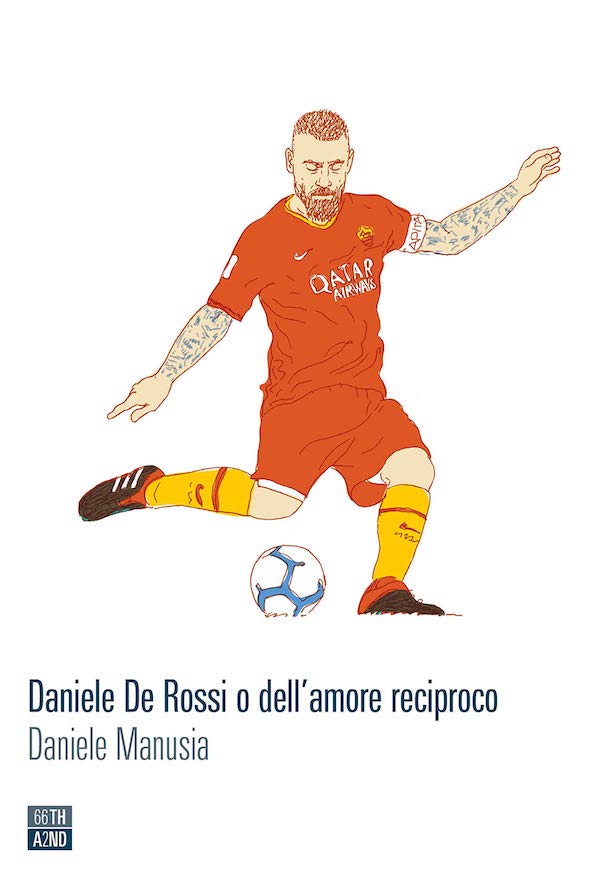Il tatuaggio di De Rossi
Non questo, il più famoso, ma un altro che dice molto del carattere dell'ex capitano della Roma, raccontato in un libro di Daniele Manusia

È uscito da qualche giorno Daniele De Rossi o dell’amore reciproco, libro in cui Daniele Manusia, fondatore e direttore del sito di approfondimento sportivo l’Ultimo Uomo, ha raccontato la carriera di Daniele De Rossi, per diciott’anni centrocampista della Roma, campione del mondo nel 2006 e capitano romanista dopo il ritiro di Francesco Totti. Per questioni anagrafiche e professionali, Manusia ha potuto seguire da vicino l’evolversi della carriera di De Rossi, considerato un giocatore atipico per il suo carattere e per le scelte fatte in carriera, come quella di trascorrere un quarto di secolo nella sua squadra del cuore, pur sapendo di rinunciare ai successi che avrebbe potuto ottenere in qualsiasi altro posto.
Daniele De Rossi o dell’amore reciproco è pubblicato dalla casa editrice 66thand2nd e fa parte della collana di storie sportive “Vite inattese”. Ne pubblichiamo un estratto, tratto dal capitolo “Il tatuaggio”.
***
Col passare del tempo, mentre la sua pelle diventava più spessa, ci cresceva sopra uno strato di forme colorate. A vent’anni, quando esultava togliendosi la maglia, era di un bianco quasi insalubre, con l’abbronzatura da operaio che girava intorno al collo e sugli avambracci; ma quando si avvicina ai trent’anni Daniele è un album di figurine. Su un bicipite ha dei Teletubbies che stringono un cuore con il nome della figlia e le parole di Favola, la canzone dei Modà che usava per addormentarla. Sulla spalla ha un occhio che osserva da sopra una nuvola da cui cade la pioggia e subito sotto ci sono un cavallo e un bambino coi baffi che tiene un cuore nelle proprie mani e una palla di cuoio, di quelle che usavano i pionieri del calcio, tra le gambe. C’è una scritta latina scolpita nella pietra: «Ubi tu Gaius, Ibi Ego Gaia» ovunque tu sia, io sarò. Ci sono anche San Pietro e Castel Sant’Angelo, Pac-Man con i suoi fantasmini, una geisha inginocchiata e un cuore in negativo su un fondo di vernice nera colante. Il tatuaggio più famoso è quello sul polpaccio destro, con il cartello triangolare di pericolo con al centro una figurina umana come quelle dei semafori che entra in scivolata sulla caviglia di un’altra figurina.
Non so quando sono comparsi esattamente, né ci ho fatto caso in quegli anni. So però che nel 2016 ne è spuntato fuori un altro, realizzato a Roma dall’artista canadese David Peyote, famoso per il suo stile psichedelico: il ritratto di un uomo con una barba rossa al cui interno si staglia la silhouette nera di un’antenna radio, con una cicatrice diagonale sullo zigomo e un cappello da pescatore riempito di birra gialla. Quel tatuaggio è anche un modo piuttosto strano e originale, per uno che non ne ha mai parlato pubblicamente, per esorcizzare le tante voci che lo mettevano in cattiva luce, riassumendo le leggende metropolitane che girano su di lui in un’unica immagine.
La birra perché Daniele a un certo punto – quando il vento ha iniziato a cambiare – è diventato «Capitan Ceres» per i suoi detrattori, e lo è rimasto fino alla fine: ancora durante la sua ultima stagione si è aperto un piccolo caso quando è stato fotografato mentre aspettava il controllo a sorteggio nella sala dell’antidoping con una birra in mano (analcolica, come pare sia prassi per reidratare i giocatori dopo lo sforzo e agevolare la produzione di urina per i test). Per quanto quella del calciatore ubriaco sia una leggenda stupida e piuttosto comune, non è difficile capire quanto possa essere subdolo metterlo in discussione in questo modo: guardatelo, voi pensate che De Rossi viva per la Roma ma in realtà pensa solo a divertirsi, non è un professionista. Non è un generoso come dice, ha dato meno di quello che avrebbe potuto dare. E così via.
La cicatrice è lo «sfregio» che gli dovrebbe aver lasciato, ovviamente, «uno zingaro», forse su richiesta dell’ex moglie, e che si dice Daniele copra con la barba. Una storia misteriosa e al tempo stesso ridicola: qualcuno riesce davvero a immaginare De Rossi legato a una sedia, mentre un tipo losco con accento dell’est Europa gli tiene la testa ferma e un altro gli avvicina la punta di un coltello alla faccia, dicendo una cosa tipo: «Adesso ogni volta che ti guarderai allo specchio penserai a noi»? Una storia che però ha attecchito nell’immaginario di persone mature e serie che non possono tuttavia fare a meno di prendere un tono infantile quando chiedono, mentre si parla di De Rossi, se è vera quella storia della cicatrice.
L’antenna dentro la barba, invece, è quella delle radio romane, dei radiolari, come vengono chiamati. Perché è da lì che sono generate tutte queste voci.
D’accordo, certe leggende nascono da sé, ma perché qualcuno avrebbe dovuto avere interesse nel diffonderle? Le cose per Daniele sono probabilmente cambiate dopo che ha preso le difese del portiere Doni, ormai caduto in disgrazia e fischiato dai tifosi anche quando deve entrare per sostituire Júlio Sérgio infortunato. A dicembre 2010 – Ranieri deve ancora dare le dimissioni, De Rossi deve ancora colpire Srna con una gomitata – quando gli chiedono di Doni dopo la partita con il Milan, De Rossi dice che è il miglior portiere con cui abbia mai giocato, dopo Buffon, e che era vittima di «qualche pappone» che parla «in giro per le radio». Uno di quelli «che entrano a Trigoria e fanno i padroni». Sta parlando di quel sistema mediatico, parallelo a quello ufficiale di giornali e tv, che ciclicamente esalta e distrugge la Roma, manipolando le discussioni con conduttori carismatici – che un paio di anni dopo De Rossi definirà «maiali col microfono» – che tengono sotto costante pressione società e giocatori. Una cosa che si dà per scontata, anche se in molti la considerano una delle ragioni per cui «l’ambiente romano» è uno dei più difficili per calciatori e allenatori (molti tifosi, i tifosi più veri, disprezzano quelli che chiamano le radio per insultare i giocatori, e li definiscono «romanistoni»). De Rossi non fa nomi, perché chi deve capire ha senz’altro capito e infatti, purtroppo per lui, la prova che le sue parole sono arrivate a bersaglio sta proprio in quelle leggende che negli anni a seguire hanno continuato a circolare sul suo conto. «Capisco i tifosi delle squadre, lo sono anch’io, sono un tifoso che va in campo e non in curva,» dirà in seguito «ma non capisco i tifosi delle radio o delle presidenze. Succede solo a Roma».
De Rossi non ha mai sentito il bisogno di smentire le leggende che lo riguardavano, ad esempio gli sarebbe bastato presentarsi una volta con la barba tagliata; non lo ha fatto per non aprire un dialogo con chi non lo meritava, ma dal suo attacco diretto si capisce anche che fosse a conoscenza delle voci e che non gli facessero piacere. Anzi, conoscendo molto bene la città e i suoi meccanismi, Daniele doveva anche sapere cosa significava mettersi contro il mondo delle radio romane, quindi per lui doveva valerne la pena, il fastidio doveva essere davvero grande. Il che spiega anche perché anni dopo ha finito per infilarsi i pettegolezzi che lo riguardavano letteralmente tra gli strati della propria pelle. Con il tatuaggio di David Peyote ha annullato il potere che avevano su di lui ma al tempo stesso li ha fatti diventare parte di sé. Si è tatuato il suo stesso doppio cattivo, la versione negativa di sé costruita da chi lo odiava. Strano, per qualcuno che ha parlato così spesso dell’amore che gli davano i suoi tifosi. Ma è una contraddizione che fa il paio con un’altra che ho notato. In un’intervista recente, del suo ultimo anno da calciatore della Roma, Daniele ha detto: «Se non leggi i giornali, se non apri i social, se non leggi le cazzate sui siti, le notizie di mercato non ti fanno niente. Io non leggo più». Solo che in una di quelle rare occasioni di cui ho già scritto, in cui l’ho visto di persona, io l’ho visto leggere con grande attenzione «La Gazzetta dello Sport». Magari avrà smesso tempo dopo, o magari è più suscettibile di quello che vorrebbe dare a vedere.
© Daniele Manusia, 2020
© 66thand2nd 2020