Il coronavirus esiste ancora, eccome
Le dichiarazioni sulla sua scomparsa "dal punto di vista clinico" hanno fatto molto discutere, ma il virus non è andato da nessuna parte e i rischi sono ancora presenti
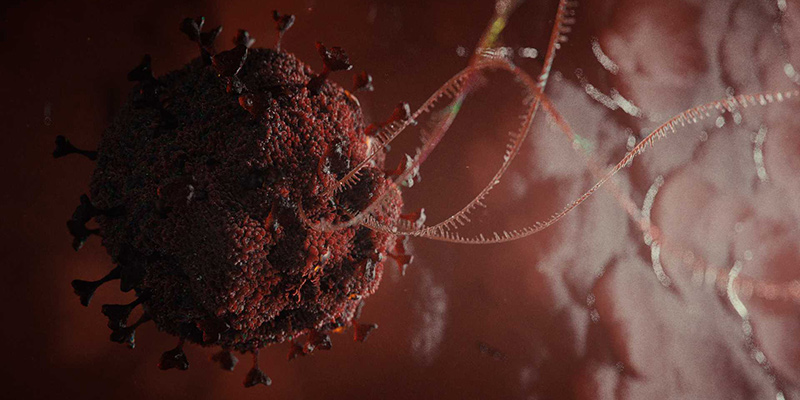
Da domenica scorsa circolano molto alcune dichiarazioni di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione presso l’ospedale San Raffaele di Milano, che in modo piuttosto categorico ha sostenuto che il coronavirus “dal punto di vista clinico non esiste più” durante una puntata della trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata. Le sue affermazioni sono state ampiamente riprese dai giornali, talvolta senza informazioni sufficienti di contesto, e hanno contribuito alla diffusione di fraintendimenti, come quelli sulla presunta mutazione del coronavirus.
Cosa ha detto Zangrillo
Alberto Zangrillo ha 62 anni, è di Genova, si è specializzato in anestesia e rianimazione, ricoprendo dal 2003 ruoli da primario presso il San Raffaele, uno degli ospedali privati più famosi nell’area di Milano. Zangrillo è soprattutto noto per essere da circa 30 anni il medico personale di Silvio Berlusconi, assistito in diverse occasioni per malattie e operazioni con ricoveri proprio al San Raffaele. Nonostante la sua vicinanza all’ex presidente del Consiglio, Zangrillo non ha mai tentato o intrapreso la vita politica, dedicandosi esclusivamente alle attività cliniche e di ricerca. Negli anni ha comunque dimostrato di gradire una certa attenzione da parte dei media, partecipando a numerosi programmi televisivi e dando innumerevoli interviste ai giornali.
Da primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare del San Raffaele, Zangrillo negli ultimi mesi ha seguito direttamente l’evoluzione dell’epidemia in Italia, osservando gli effetti dei pazienti con COVID-19 nei reparti per le malattie infettive e in quelli di terapia intensiva del suo ospedale. Nella fase di massima emergenza sanitaria, con gli ospedali stracolmi di pazienti, Zangrillo aveva dato di frequente interviste per raccontare la situazione, come avevano fatto diversi altri suoi colleghi delle aziende ospedaliere lombarde, le più interessate dall’epidemia.
Zangrillo: "il virus dal punto di vista clinico non esiste più"#Zangrillo #COVID19 pic.twitter.com/9ymNcFQ4M1
— Emei Markus (@EmeiMarkus) May 31, 2020
Sono infatti gli anestesisti-rianimatori a occuparsi dei pazienti in terapia intensiva, provvedendo ai trattamenti da effettuare, compresi quelli più estremi come l’intubazione. Zangrillo non è un virologo e non si occupa quindi dello studio dei virus, ma della valutazione dei loro effetti sui pazienti nella pratica clinica, cioè durante la loro permanenza in ospedale mentre vengono sottoposti ai trattamenti, nel caso del coronavirus contro gli effetti più gravi della COVID-19 (che interessano una percentuale relativamente bassa dei malati, al punto da rendere necessario il loro ricovero).
– Leggi anche: Come sta andando la “Fase 2”
Clinica
La frase sul coronavirus che “dal punto di vista clinico non esiste più” pronunciata da Zangrillo va quindi letta tenendo a mente la premessa qui sopra: vuole dire che nell’esperienza di chi si occupa dei pazienti con COVID-19 la gravità dei sintomi sembra essere molto inferiore rispetto ad alcuni mesi fa, con una minore presenza del coronavirus nell’organismo delle persone infette. Il problema è che Zangrillo ha usato un’espressione molto categorica per affermarlo, arrivando a sostenere che il virus “non esiste più” clinicamente. Questo non significa che sia scomparso, ma che secondo Zangrillo è meno rilevante rispetto a qualche settimana fa e per i sintomi che comporta.
Le affermazioni di Zangrillo derivano da una ricerca condotta da Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele, basata sulle esperienze cliniche di circa 200 pazienti positivi al coronavirus ricoverati e trattati presso la struttura ospedaliera. Clementi sostiene di avere rilevato una minore “capacità replicativa” del coronavirus a maggio rispetto ai mesi precedenti, ma che ciò non implica necessariamente che il virus sia “mutato”. La ricerca indica che è cambiata la “manifestazione clinica”, cioè il modo in cui si presenta la COVID-19 negli infetti.
Clementi sostiene che la mancanza di nuovi ricoveri in terapia intensiva da diversi giorni conferma le conclusioni del suo studio. Zangrillo ha sostenuto qualcosa di analogo, arrivando a dire che proprio grazie a queste circostanze non si è verificata una “nuova ondata” di contagi, e che quindi l’epidemia potrebbe non subire nuove accelerazioni. Ha ribadito gli stessi concetti in una recente puntata di Porta a Porta, ricevendo però alcune smentite da Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano.
Galli ha ricordato che il numero inferiore di ricoveri è soprattutto riconducibile ai due mesi di restrizioni e limitazioni agli spostamenti, che – come hanno rilevato molti esperti – hanno avuto un ruolo centrale nel rallentare la diffusione del contagio. La situazione attuale è frutto della cosiddetta “Fase 1”, che ha inciso sensibilmente sull’attuale “Fase 2” di convivenza con il coronavirus. Le restrizioni hanno fatto sì che il virus circolasse meno tra la popolazione, riducendo anche il numero di persone a rischio di entrare in contatto con individui inconsapevolmente contagiosi (perché con sintomi molto lievi o assenti).
Come tutte le ricerche preliminari e in attesa di pubblicazione, anche lo studio condotto presso il San Raffaele deve essere preso con cautela, ricordando che 200 pazienti in un unico ospedale sono una base relativamente ristretta di individui dai quali derivare considerazioni più generali (o categoriche come ha fatto Zangrillo).
– Leggi anche: Ora negli ospedali bisogna pensare a tutto il resto
Carica virale
La ricerca di Clementi e colleghi è inoltre di tipo quantitativo e non qualitativo: per ogni paziente è stato analizzato un campione di muco e saliva (prelevato tramite tampone) per valutare poi la carica virale di ciascun individuo, cioè la quantità di particelle virali presenti nel loro organismo. In linea di massima, più risulta alta la carica virale, più è probabile che la persona infetta manifesti sintomi importanti e che si possono poi aggravare. I ricercatori hanno poi messo a confronto i risultati di queste analisi riferite a maggio con quelle effettuate a marzo, trovando una minore carica virale. Il confronto è quindi avvenuto inevitabilmente tra pazienti diversi e in condizioni variate, ambientali e cliniche, cosa che può avere influito sui risultati.
Clementi comunque non ha mai affermato che il coronavirus sia “mutato”, ricordando che allo stato attuale delle conoscenze non sia possibile sostenerlo e che non si ha ancora “certezza sulle origini del fenomeno”.
Mutazioni
Come avevamo raccontato più estesamente qui, nel corso del tempo è normale che i virus mutino, cambiando alcune delle loro caratteristiche. Ciò deriva dalle imprecisioni nel meccanismo che adoperano per replicarsi, sfruttando i sistemi delle cellule che invadono. Gli errori del tutto casuali nella trascrizione delle informazioni genetiche possono poi portare a mutazioni, quasi sempre innocue e che si trasmettono alle generazioni successive, accumulandosi a quelle nuove prodotte nei processi di replicazione seguenti.
Queste imprecisioni determinano il progressivo allargamento dell’albero genealogico di un virus, con nuovi rami che però non implicano che si sviluppi un nuovo “ceppo virale”. I virologi riservano questa definizione per una nuova generazione di virus che presenta differenze marcate e significative rispetto alle precedenti, soprattutto negli esiti delle sue attività.
Nel caso del coronavirus, diversi gruppi di ricerca in giro per il mondo hanno notato cambiamenti e la presenza di versioni lievemente diverse, che si sono radicate e affermate più di altre in alcune aree geografiche. Le differenze rilevate finora non hanno però messo in evidenza particolari cambiamenti nel modo in cui il coronavirus si diffonde o sulla sua aggressività. E queste circostanze, basate sull’analisi in laboratorio del virus e non sulle sue manifestazioni cliniche, non sembrano molto compatibili con le affermazioni di Clementi.
– Leggi anche: Come è fatta Immuni
Cautela
La pubblicazione nei prossimi giorni della ricerca condotta presso il San Raffaele dovrebbe contribuire a fare maggiore chiarezza, per lo meno sulle conclusioni delle studio e le metodologie applicate. La pandemia ha portato in poco più di cinque mesi alla produzione di migliaia di studi da parte di centri di ricerca e ospedali, spesso diffusi nella loro forma preliminare e senza una revisione alla pari da parte di altri esperti per verificarne l’affidabilità. Molte di queste ricerche sono di tipo aneddotico, quindi basate su esperienze cliniche su un numero ristretto di pazienti, non sempre significativo per derivare considerazioni più ampie e generali.
Preso con le dovute cautele, anche questo tipo di ricerche contribuisce comunque ad avere informazioni importanti per comprendere meglio modalità e rischi di diffusione di una malattia infettiva che conosciamo da pochissimo, e che ha già causato la morte di almeno 380mila persone in tutto il mondo, con 6,4 milioni di contagi rilevati. I risultati ottenuti dovrebbero però essere comunicati offrendo dati di contesto, ed evitando di riprendere semplici dichiarazioni categoriche da parte degli autori interessati.
– Leggi anche: Vietare il consumo di animali selvatici non è così facile



